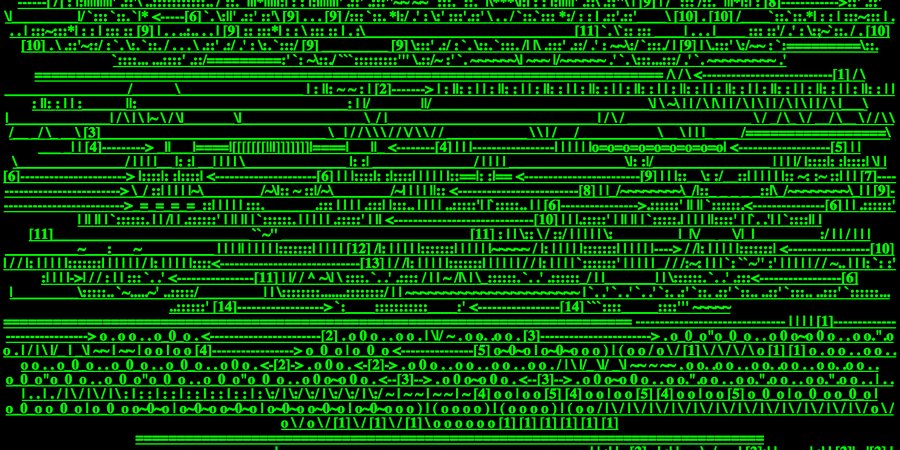Apologia del fandom
Un'indagine sul fan inteso come fruitore narrativo ideale.
I fan rappresentano un ritorno alla forma più autentica e originaria del concetto di fruitore narrativo, nonostante siano ancora bistrattati e derisi di continuo. Nel 1992, Il teorico americano Henry Jenkins affermava che il termine “fan” non era mai uscito dalla sua originaria connotazione di fanatismo, falsi credi, eccesso orgiastico e pazzia. (Cfr. H. Jenkins, 1992, pp. 12-3). Oggi, a trent’anni di distanza, le cose sono leggermente cambiate, ma non troppo.
Per esempio, prima che si convertisse al “Mi piace”, su Facebook si poteva “Diventare Fan” di una pagina; oppure, è ormai comune sentire nel quotidiano qualcuno che si dichiari, più o meno ironicamente, fan di qualcosa. Tuttavia, questo presunto fan usa probabilmente il termine in sostituzione del meno problematico “ammiratore”. Il fan possiede infatti delle caratteristiche precise, che in parte sono responsabili della cattiva luce in cui è ancora gettato. Fra queste, ce ne sono due, nel contesto della narrazione, che rendono il concetto di fan più un ritorno alle origini che un fenomeno interamente moderno: l’intersoggettività e l’atteggiamento attivo.
Ma partiamo da lontano, un milione di anni fa, più o meno. Una specie di Homo, l’Erectus per la precisione, scopre il fuoco. Ci mette più di cinquecento mila anni per farlo diventare una cosa usuale, ma quando ci riesce è una rivoluzione. Nel frattempo, però, si estingue, e la rivoluzione ce la godiamo noi Homo Sapiens. L’uso del fuoco da parte degli esseri umani fu rilevante non solo per la cottura dei cibi o per la difesa dalle belve feroci, ma anche per una questione sociale. Con il fuoco i nostri antenati cacciatori e raccoglitori poterono iniziare a passare le loro serate in compagnia, a chiacchierare. Pare che di sera si chiacchierasse di cose diverse rispetto al giorno. Con la luce del sole si discorreva dell’utile: più che altro questioni “economiche”. Di notte si raccontavano le storie. Dunque, la pratica della narrazione, uno degli elementi più autentici e originali dell’essere umano in quanto tale, sarebbe nata attorno al fuoco, nel vivo scambio orale della sera.
La narrazione ha conservato questa sua natura orale per millenni, se si escludono i tentativi di fissare alcune scene narrative nelle pitture rupestri. Basti pensare che anche le opere fondanti della storia della narrativa scritta, le cui origini si mischiano con il mito e la religione, come il Vecchio Testamento, i poemi omerici o l’epopea di Gilgameš, non sono altro che trascrizioni di storie tramandate a lungo soltanto oralmente.
Oralità e scrittura comportano due modalità differenti non solo di intendere la narrazione, ma anche di produrla e diffonderla. Il concetto stesso di racconto o narrazione è nato in forma orale, e per via di questa oralità ha vissuto un imprinting ineliminabile. A causa di questa origine tutte le storie possiedono una componente di attività che viene inevitabilmente depotenziata dall’uso della scrittura. Il racconto intorno al fuoco richiedeva per forza la risposta e lo scambio di tutti i partecipanti. Era costitutivamente dialogo. Il monologo, pur essendo orale, è invece una “perversione” della scrittura. Questa natura dinamica e partecipativa era ancora conservata nell’attività dei rapsodi e degli aedi o nella trasmissione orale dei racconti religiosi. Tant’è che le opere citate in precedenza hanno continuato a subire una serie di modifiche più o meno consistenti anche quando il processo di trascrizione era storicamente già iniziato, segno che la tendenza allo scambio narrativo attivo era ancora viva.

Nei secoli, poi, la narrazione si è andata progressivamente cicatrizzando nel testo. La sua forma orale ha ovviamente continuato a resistere, nelle tradizioni popolari, nelle storie della buonanotte, nei miti e in tutto un immaginario di racconti che ancora oggi sopravvive grazie alla trasmissione a voce. Ma la smania della documentazione, e forse la paura dell’oblio, hanno convinto l’umanità, o quanto meno le società occidentali, a cristallizzare ogni storia per iscritto. Negli ultimi secoli questa tendenza ci ha condotto a circoscrivere la pratica della narrazione a dei campi precisi. Come tante altre pratiche organiche e vissute, come la danza o la musica, anche la narrazione ha subito un processo di istituzionalizzazione divenendo un’arte piuttosto canonizzata. La narrazione è dunque divenuta progressivamente narrativa, ed è stata relegata a dei campi precisi, tutti testuali, primo fra i quali la letteratura. Lo studio delle forme di narrazione non canoniche, fra cui ormai anche quella orale, è stato sottoposto ai criteri della narrazione scritta. Tant’è che la semiotica, per parlare di un messaggio comunicativo narrativo, anche orale, fa spesso riferimento alla categoria di testo.
Anche la narratologia utilizza più che altro i criteri del testo scritto. Le categorie che adopera (autore, opera, lettore, struttura ecc.) ineriscono sempre a un testo statico e a una fruizione passiva. Ormai, l’idea che le storie siano un oggetto definito, creato attivamente da qualcuno e fruito passivamente da qualcun altro, è un assunto ben assimilato dalla nostra cultura.
Tuttavia, la natura attiva della narrazione ha sempre continuato a ribollire sotto questa patina di immobilismo, e fenomeni contemporanei come il fandom fanno emergere questo magma. Nonostante appaia come una novità, l’interattività caratteristica del fandom rappresenta un recupero della condizione autentica dell’essere umano, quanto meno in riferimento alle storie e ai racconti. Enrica Tedeschi definisce il fandom come «quella sorta di moltiplicatore dei contenuti mediati che espande, o comprime, i significati presentati dai media, costruendo ipertesti di ipertesti, all’infinito» (E. Tedeschi, 2003, p. 8). Il fan, dunque, deve per forza lavorare sul testo, non può subirlo passivamente. Deve farlo tornare alla voce, recuperare la dinamica laddove per secoli ha dominato la parvenza di un oggetto statico.
Il coinvolgimento attivo del fan, stando a quanto scrive Jenkins (Cfr. Jenkins 1992, pp. 23-4), non è figlio soltanto di un’eccessiva fascinazione, di una celebrazione quasi religiosa di un prodotto o un aspetto della cultura di massa. L’attivo coinvolgimento, anzi, può provenire dalla frustrazione, e può anche condurvi. Nel racconto che fruisce, e di cui si innamora, il fan non vede l’oggetto chiuso e perfetto che la critica e la teoria letteraria hanno descritto per secoli, ma una matrice di potenziali significati narrativi che nell’opera “ufficiale” subisce un precoce esaurimento, un’ingiustificata compiutezza.
Da questo punto di vista, il fan non è per nulla un seguace, ma ne è l’esatto contrario. Al fan, inteso in questo senso, mancano le caratteristiche fondamentali per essere considerato alla stregua di un tifoso sportivo, contesto in cui, curiosamente, il termine fan ha iniziato a circolare nel IXX secolo (Cfr. Jenkins, p. 20). Il fanatismo del fan lo conduce lontano dall’accettazione dogmatica e passiva dei contenuti (in questo caso le storie) e lo rende a tutti gli effetti un fruitore critico. Scrive ancora una volta Tedeschi che «Il lavorio del fan ha a che vedere con la rielaborazione continua del significato e con la logica della parafrasi, entro un circuito ermeneutico che va e viene, costantemente, dal soggetto ai media e dai media al soggetto.» (E. Tedeschi, 2003, p. 110). Il fan coltiva così la sua naturale propensione all’attività narrativa: riunendosi in club, fondando fanzine, ma soprattutto avanzando fan theory e scrivendo fan fiction.

Non è stato però il fan in sé a riaprire la questione sull’attività del fruitore o sull’intrinseca natura partecipativa della narrazione. Il fan è soltanto l’esplicitazione, nel materiale e nell’attivo, di una tendenza che è in fondo sempre stata intuita dalla cultura umana, e che durante il secolo scorso è arrivata a un certo livello di consapevolezza anche sul piano della teoria e della critica. Nel corso dell’Ottocento, e fino ai primi del Novecento, la critica letteraria era concentrata soprattutto sul concetto di autore e sulle sue intenzioni. Correnti diverse fra loro come quella marxista o quella psicoanalitica puntavano all’estrapolazione di un significato univoco che fosse relazionato all’autore come a colui che ha creato il testo, e dunque ne possiede le chiavi interpretative più autentiche. Il formalismo russo prima, e lo strutturalismo degli anni ’60 poi, hanno provocato invece uno spostamento del focus dall’autore al testo, al cui interno erano riscontrabili delle istanze, come la forma o la struttura, in grado di restituire il significato dell’opera a prescindere dalle intenzioni dell’autore. Ma il Novecento è stato anche il secolo di un altro cambiamento di prospettiva. Non ci si è spostanti soltanto dall’autore al testo, ma anche dal testo al lettore.
Alcuni strutturalisti come Genette o Chatman avevano già compiuto dei passi in questa direzione, riconoscendo la presenza di un lettore implicito all’interno del testo, una sorta di fantasma del lettore, più un appello testuale che un soggetto vero e proprio. Tuttavia, la rivoluzione è da attribuire ai critici e teorici della cosiddetta Reader Response Theory, nella quale si potrebbero far rientrare anche autori come Umberto Eco e Italo Calvino.
Autori differenti fra loro, come Wolfgang Iser, Stanley Fish o Hans Robert Jauss, hanno sostenuto nel corso dei secoli diverse posizioni, tutte però ruotanti attorno al ruolo e all’importanza del lettore. Tuttavia, non venne soltanto restituito al lettore un ruolo fondamentale nella produzione di senso, ma quest’ultima venne anche relazionata all’attività di lettura più che al testo inteso come oggetto statico. Per Stanley Fish il significato è addirittura identificabile per intero con questa attività, ed entità come il lettore e l’autore non sarebbero altro che il prodotto di questo dinamico processo d’interpretazione (Cfr. S. Fish, 1980). A cavallo fra gli anni Settanta e Ottanta è avvenuto dunque, già sul piano della critica, un forte cambio di paradigma. Anche lo studio di Umberto Eco sul concetto di Opera Aperta (Cfr. U. Eco, 1962) è soltanto all’apparenza una ricerca in merito a un tipo peculiare di testo letterario, postmoderno e innovativo. Le intuizioni di Eco miravano invece a riscontrare un elemento di apertura nelle opere tout court. Le opere postmoderne e interattive sono soltanto l’esplicitazione di un paradigma da sempre intrinseco a tutte le narrazioni.
Allo stesso modo, il fan è l’esplicitazione di una maniera d’intendere il fruitore che è sempre esistita, ma che nel corso dei secoli è stata oscurata dall’immagine del lettore solitario e passivo. Per gli autori della Reader Response Theory, il lettore ha sempre un ruolo attivo. Per Iser, ad esempio, l’attività di lettura colma di continuo degli spazi bianchi lasciati nel testo dall’autore, e il lettore utilizza un repertorio di riferimenti intra ed extra-testuali per fornire senso all’opera (Cfr. W. Iser, 1976). Senza questo processo non ci sarebbe mai produzione di senso. Come a dire che non esisterebbe l’opera se non ci fosse nessuno a leggerla. Questo qualcuno necessario è anche per Iser previsto all’interno del testo sotto forma di lettore implicito. Da questo punto di vista il fan è la versione aumentata di questo lettore. Scrivendo fan fiction o congetturando sugli eventuali sviluppi di una trama seriale, il fan esplicita la sua natura attiva. Ma non solo. La produttività intrinseca al concetto di fan non è l’unico elemento che lo caratterizza.
Una fan fiction, per esempio, nasce per essere qualcosa di lontano da un’opera chiusa, si predispone direttamente al commento, all’interpretazione, magari anche alla continuazione da parte di altri fan. Tutto ciò è ancora più evidente con le fan theory. Quando un fan cerca di prevedere, su Reddit, il finale di stagione di Game of Thrones, non si aspetta certo che gli altri fan si limitino a leggere passivamente la sua teoria, ma si predispone al commento e al confronto. In questo scambio non si stanno soltanto avanzando ipotesi, ma costruendo a tutti gli effetti mondi possibili e snodi narrativi. Nelle fan theory e nella fan fiction le storie riescono ad essere quello che erano alle origini: mondi alternativi e matrici di senso, generatori potenzialmente infiniti di svolte, personaggi e ambientazioni. Gli archi di trasformazione del personaggio, o le progressioni lineari di un racconto, sono soltanto uno spaccato di un universo potenziale, che i fan, con la loro attività sociale, riescono spesso a tenere vivo e produttivo.
Tutto ciò emerge distintamente anche nella sempre più frequente transmedialità vissuta dal nostro tempo. Il fatto che si possa fruire una storia attraverso media differenti: romanzi, film, videogiochi e post Instagram, testimonia che il compito di generare senso non è demandato alla produzione, ma alla fruizione. Soltanto il fruitore, infatti, muovendosi fra media diversi, può unire i pezzi del puzzle e costruire un mosaico complesso di significati della storia. Questo perché l’adattamento cinematografico di un libro non è mai soltanto un adattamento. Nel media diverso c’è sempre un senso diverso, che il fruitore non si limita a cogliere, ma produce e sviluppa. Questo sviluppo è compiuto da parte del fan in maniera esplicita. È in questo senso che Henry Jenkins parla di culture partecipative o convergenti (Cfr. H. Jenkins, 2006). Per quanto riguarda i media e la comunicazione stiamo assistendo ormai da qualche decennio alla nascita di un soggetto nuovo, il prosumer, il quale non è né esclusivamente produttore, né esclusivamente consumatore. Il fan è l’esempio massimo di prosumer, di soggetto in cui attività e passività convivono armonicamente e si alimentano a vicenda. Il fan a cui fa riferimento Tedeschi viene pur sempre descritto «come l’attore attivo e passivo della visione, o come il portatore di risorse creative e immaginative.» (E. Tedeschi, 2003, p. 36) Ancora prima dei social network si è scardinata la logica dello scambio unidirezionale e il pubblico ha iniziato a pretendere uno spazio sempre più grande e attivo.

Ancora una volta, non è soltanto una svolta epocale, ma rappresenta anche un recupero della dimensione originariamente dinamica e partecipativa della comunicazione umana, e della narrazione in particolare. Non è un caso che questa svolta sia avvenuta in quest’epoca. Le attuali tecnologie nel campo delle telecomunicazioni hanno consentito uno scambio constante e continuo a livello globale. Si tratta di un requisito fondamentale dal momento che le nostre società andavano già da tempo nella direzione di una dimensione globale. Se l’audience dell’ultimo film della Marvel, ma già del primo Harry Potter, coinvolge il mondo intero, senza barriere linguistiche o culturali, è normale che anche l’audience attiva, la comunità di potenziali fan aspiri ad essere globale.
Internet, per esempio, ha consentito di trasformare le fanzine prima in dei forum, poi in dei gruppi sui social network e dei canali su Reddit. Nel corso di questo processo è andata progressivamente aumentando l’accessibilità e la velocità di comunicazione, al punto che il peso che già i piccoli fan club cominciavano ad avere è diventato enorme, tant’è che si parla polemicamente di fenomeni come il fan service. È questa la convergenza di cui parlava Jenkins. I fan tendono naturalmente all’attività, alla produzione di contenuti. Ma dal momento che il concetto di opera è ancora ammantato da una certa autorevolezza, autorità e originalità, i fan pretendono anche di far agire questa loro tendenza operativa sul testo ufficiale. Come se la parte passiva e quella attiva, di solito in armonia, entrassero qualche volta in conflitto. I fan sono affetti, a volte, da una sorta di “Sindrome da Misery” (dal personaggio del romanzo di Stephen King) e non riescono a sopportare in alcun modo che la storia di culto di cui sono fan prenda una strada poco gradita.
Tutti questi elementi hanno prodotto un tipo di pubblico che ha pulsioni lontanissime dal godimento passivo di un’opera, ma anche dalla ricerca della catarsi greca. A dominare oggi è quella che Elena Tedeschi definisce «pulsione alla performance» (E. Tedeschi, 2003, p. 29). Per l’autrice quella in cui viviamo «è una società i cui cittadini si sentono in primo luogo attori protagonisti e mal sopportano il ruolo di comparse: essi sono soggetti portatori di vis drammatica e di una ritualità celebrate e acclamate dall’intera collettività. Una società di performer» (E. Tedeschi, 2003, p. 27). È difficile non riscontrare in queste parole anche un tono di condanna. Tuttavia, è evidente che anche questa latente considerazione negativa ha delle origini ben precise, ravvisabili da una parte nel nutrito dibattito contemporaneo sulla società della performance e i danni alla salute mentale che produce; ma dall’altra in una considerazione oggettivistica dell’arte, e quindi anche della narrazione, che ancora resiste tenacemente.
L’arte, e l’estetica in generale, continuano a subire un certo pregiudizio sostanzialistico, che conduce a considerarle come qualcosa di simile al sacro, inerente più al canone e all’istituzione che a un’esperienza vissuta. Sin dalla sua origine, l’estetica come disciplina filosofica è stata strettamente connessa al concetto di bello e all’arte come campo definito o definibile. Ancora Adorno giustificava le sue invettive nei confronti del jazz difendendo un’idea di arte come di qualcosa che deve innalzare l’animo umano. Il paradigma sotteso a questa concezione dell’estetica era quello che Giovanni Matteucci definisce dell’esperienza di-qualcosa (Cfr. Matteucci, 2019, p. 50). Enti come il soggetto e l’oggetto si davano per scontati nel contesto della relazione estetica o artistica fra l’autore (o il fruitore) e l’opera d’arte. Ancora oggi ci appare naturale affermare che lo spettatore ha un’esperienza del quadro, tanto quanto il lettore ha un’esperienza del libro. Tuttavia, sulla scorta di paradigmi estetico-filosofici differenti Matteucci propone di sostituire al paradigma dell’esperienza di- quello dell’esperienza con- qualcosa. La conseguenza principale sarebbe quella di smettere di considerare soggetto e oggetto come enti preesistenti alla relazione, ma di intenderli invece come il prodotto di quest’ultima. Ad avere la precedenza sarebbe dunque un meccanismo di campo e la relazione estetica non sarebbe un flusso passivo e unidirezionale, ma uno scambio attivo e dinamico. L’opera d’arte, ma in realtà qualunque oggetto estetico, non sarebbe tanto un oggetto vero e proprio, quanto un dispositivo, un richiamo all’azione e un appello all’esperienza. Questa concezione poggia su alcune intuizioni estetiche ben precise, prime fra tutte quelle di John Dewey.
Nel suo Arte come esperienza, eloquente già dal titolo, Dewey cerca di restituire non soltanto all’arte, ma a tutte le esperienze estetiche, una dimensione organica. Scrive Dewey che «ci sono cose dentro il corpo che sono estranee all’organismo, e ci sono cose fuori di esso che gli appartengono de jure se non de facto, ossia, di cui bisogna prendere possesso per continuare a vivere» (J. Dewey, 1934, p. 49). Le storie sono una di queste cose. L’essere umano le produce e se ne appropria per piacere, ma anche per bisogno. Allo stesso tempo, però, le storie determinano l’essere umano nella sua identità più profonda, al punto che tracciare un confine fra l’essere umano come soggetto, e la storia come oggetto, è praticamente impossibile. Andrebbe ricostruito lo scambio vivo con le storie, e per farlo bisogna innanzitutto tornare a considerarle un elemento vivo, organico e aperto. I fan lo stanno facendo, e la cosa più interessante è che compiono questa missione inconsapevolmente, spinti, appunto, da un organico istinto vitale. La società della performance è soltanto il modo che ha avuto la contemporaneità di recuperare un più semplice impulso alla socialità, al confronto e allo scambio. Raccontare, sin dalle origini, era un’attività sociale. Ma non lo era perché si avesse coscienza dei vantaggi evolutivi che questo comportava, non almeno in prima battuta. Lo era perché grazie al racconto si poteva partecipare insieme di un’esperienza, si poteva tenere unito il flusso che raggruppa gli esseri umani fra di loro.
Se per Dewey bisogna «ripristinare la continuità dell’esperienza estetica con i processi normali del vivere» (Dewey, 1934, p. 37), non si può negare che i fan portano a termine con diligenza proprio questo compito, innanzitutto sgretolando la patina di oggettivismo che ancora ammanta i prodotti culturali, sporcandosi le mani con l’elaborazione e lo sviluppo del senso, ma soprattutto scomparendo come soggetti granitici e definiti, finendo per mischiarsi e confondersi con il processo dinamico che dà vita alle storie. Dunque, oltre a essere una previsione, quella che il soggetto fan si lasci alle spalle la sua brutta nomea e ottenga uno spazio di legittimità nel dibattito culturale contemporaneo, è anche una speranza. Se, nei fatti, il fan spesso riabbraccia la sua originaria natura fanatica forse è anche perché la sua identità, le sue opinioni e le sue attività non sono ancora considerate degne di alcun rispetto. Restituire dignità al fruitore attivo, oggi incarnato dal fan, significa anche concedere spazio a un modo alternativo di fare critica; accettare per davvero la democratizzazione del dibattito sulle arti in generale, e sulla narrazione in particolare; rifiutare certi accademismi elitari che, nonostante la società dei consumi, continuano a sopravvivere.
_______________________
Fonti
J. Dewey, Art as Experience (1934), ed. it. a cura di G. Matteucci, Arte come esperienza, Aesthetica, Sesto San Giovanni 2020.
U. Eco, Opera Aperta (1962), Bompiani, Milano 1997.
S. Fish, Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities (1980), ed it. a cura di C. Di Girolamo, C’è un testo in questa classe) L’interpretazione nella critica letteraria e nell’insegnamento, Einaudi, Torino 1987.
W. Iser, (1976), Der Akt des Lesens, trad. it. R. Granafei e C. Dini, L’atto della lettura, Il Mulino, Bologna 1987.
H. Jenkins, Textual Poachers: Television, fans and participatory culture, Routledge, London, 1992.
H. Jenkins, Convergence culture (2006), New York University Press, New York, trad it. V. Susca e M. Papacchioli, Cultura convergente, Apogeo, Milano 2007.
G. Matteucci, Estetica e natura umana, Carocci, Roma 2019.
E. Tedeschi, Vita da fan, Meltemi, Roma, 2003.