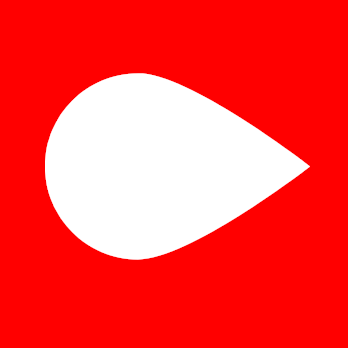Scusami, ma ci credo tanto (I)
Riflessioni sparse su Måneskin, rock’n’roll, Eurovision e capitale culturale. Atto primo.
1.
La sera del 14 dicembre 2017, al Forum di Assago, durante la finale dell’undicesima edizione del talent musicale X Factor, andò in scena un classico dramma della Democrazia.
Il tenore-pop (una roba un po’ tipo I Volo) siciliano Lorenzo Licitra, sostenuto da Mara Maionchi, uno dei giudici del talent, vinse a sorpresa il televoto contro i favoritissimi Maneskin, un giovanissimo gruppo rock romano portato da un altro dei giudici, il frontman degli Afterhours Manuel Agnelli. Il nome esatto del gruppo sarebbe Måneskin, una parola danese che significa ‘chiaro di luna’: la bassista, Victoria De Angelis, è per metà danese. Il resto della band è composto dal cantante Damiano David, dal chitarrista Thomas Raggi e dal batterista Ethan Torchio.
Cos’era successo? Due cose: i Måneskin erano proprio tanto giovani – 18 anni il cantante, 16 gli altri – e dovendo suonare per la prima volta di fronte a un grande pubblico live e con una coreografia fastosa, ce la misero tutta ma dimostrarono evidenti limiti di tenuta, il cantante in affanno dopo essersi scatenato nelle coreografie, compreso un momento di pole dance, e il gruppo che finisce fuori tempo; Licitra, invece, più maturo, elegante e professionale, un bell’uomo dotato di una bella voce ben impostata, fu impeccabile.
Inoltre, la finale era in chiaro e a votare quindi fu un pubblico che solo in parte aveva seguito il resto del programma e quindi vedeva i concorrenti per la prima volta. I Måneskin parvero a molti spettatori degli scappati di casa arroganti e non all’altezza delle loro ambizioni.
Commentando la serata Rolling Stone Italia, il Corriere della Sera della stampa musicale italiana, commentò con una certa soddisfazione la vittoria di Licitra che, a quanto pare, rappresentava il ‘vero rock’n’roll’: ‘una figura pulita, positiva, con anni di studio alle spalle e un atteggiamento sempre impeccabile’. Le ‘ali di cera dei Måneskin erano state sciolte dalla troppa sicurezza in sé stessi’ mentre ‘la serata in stato di grazia del tenore siciliano ha finalmente calato la maschera sui limiti della prevalenza della messinscena in un contesto sì televisivo, ma con uno sbocco prettamente musicale’.
Beh, non so voi ma io oggi provo un certo disgusto a leggere questo commento, malgrado sia una persona di una certa età piuttosto flemmatica e da tempo lontana da qualsiasi estetica dionisiaco-romantica-ribellistica. Questo elogio dell’umiltà impiegatizia su una rivista un tempo considerata rock era semplicemente avvilente e posso immaginare come si saranno sentiti allora i quattro adolescenti romani.
Un dramma della Democrazia, dicevo: il Popolo Sovrano col voto può imporre la sua volontà ma il Mondo Reale non si sente sempre obbligato a tenerne conto. Il povero e incolpevole Licitra scomparve dalla circolazione mediatica nel giro di pochi mesi; i Måneskin, in compenso, forse motivati da un desiderio di rivincita alla Rocky, ripartirono rapidamente, maturarono come band e nel 2021 vinsero a sorpresa il Festival di Sanremo e subito dopo l’Eurovision Song Contest di Rotterdam (la prima vittoria italiana dal 1990), di fronte a una platea mondiale senza precedenti e in queste ore sono nelle charts di qualche decina di paesi, compresi il Regno Unito e gli Stati Uniti.
Era successo qualcosa. Probabilmente i Måneskin non saranno una cosa importantissima nel ritmo vitale dell’Universo ma trovo siano un discreto punto di partenza per mettere giù un po’ di pensierini sparsi su alcuni temi collegati, tipo il destino del rock o la natura del gusto, ma soprattutto per rispondere alla domanda: dove abbiamo sbagliato?

2.
È sempre bene dichiarare da che punto di vista si sta guardando l’oggetto della discussione. Il mio è quello di un metallaro. Ex metallaro, diciamo.
Kiss e Iron Maiden al Palasport di Genova nel 1980 (dove vidi anche i Clash e i Deep Purple) furono il mio primo grosso concerto live. A Genova vennero anche i Saxon – chi se li ricorda? – al cinema-teatro Verdi di Sestri Ponente. Il più delle volte dovevo andare a Milano, dove vidi praticamente tutti i gruppi importanti degli anni Ottanta e primi anni Novanta – Metallica, Slayer, Anthrax (con i Public Enemy!), Aerosmith, AC/DC, Red Hot Chili Pepper, Def Leppard, Ramones… – you name it. Vidi il penultimo concerto dei Nirvana, vidi i Guns’n’Roses a Torino con Faith No More e Soundgarden di supporto, vidi i Sonic Youth al Rolling Stone di Corso XXII Marzo e purtroppo ci vidi anche i Manowar (Dio mio, i Manowar…).
Poi a poco a poco smisi ma ogni tanto partivo ancora per occasioni speciali – Rush, Rammstein… L’ultimo concerto importante fu qualche anno fa, Bruce Springsteen allo Stadio Meazza dove lo avevo già visto nel 1985: l’età media del pubblico era decisamente più alta. Mettiamoci un Monster of Rock a Modena, concerti al Marquee di Londra, all’Hammersmith, all’Elysée Montmartre, al Madison Square Garden – più una lunga serie di gruppi locali… Insomma, fui a lungo in servizio attivo permanente e ero grosso modo, appunto, un metallaro, anche se di gusti piuttosto ampi e tolleranti. Imparai l’inglese su riviste musicali come Rolling Stone e Spin, e Kerrang, una brillante rivista metal inglese, con l’occasionale NME o Melody Maker di supporto – tendevo a evitare le riviste italiane. Ovviamente in questa lista c’è molta comprensibile vanità personale ma volevo fosse chiaro che una certa idea, magari un po’ vecchiotta, di cosa sia il rock ce l’ho di prima mano.
Un rocker timido ma discretamente convinto. L’orizzonte musicale era quello e non c’era niente di interessante fuori (cioè, al massimo Prince. O Frank Zappa. E naturalmente Springsteen e…). Di base c’era il metal, poi l’hard rock (all’epoca si distingueva) e mi piaceva parecchio il punk, cosa che provocava infinite discussioni con gli altri metallari. La musica italiana come non esistesse.
A metà degli anni Novanta non andavo più molto per concerti (era anche un po’ una stancata, su) ma continuavo a seguire la scena e a leggere Rolling Stone, quello americano, ovvio, anche se più per il resto – era davvero una signora rivista – che per la musica.
Poi, poco dopo il 2000 mi resi conto che una sezione importante del mio capitale culturale si stava svalutando di brutto. Il massiccio investimento nel rock nei decenni precedenti dava rendimenti decrescenti, le azioni scendevano lentamente ma costantemente. Per fortuna il mio portafoglio era molto diversificato. I libri, innanzitutto, che ne formavano la vera base: più saggistica e storia che narrativa, e questa ancora largamente pop, con tantissima fantascienza – di lì a poco avrei dovuto fare scelte strategiche, dato che la saggistica ‘seria’ stava scendendo. Cauti acquisti nella divulgazione scientifica, più consistenti in antropologia e storia dell’arte. Ma quello non era un problema, sapevo di poter gestire il settore. E poi il cinema, nel quale stavo investendo pesantemente proprio in quegli anni. Un po’ debole con i fumetti e con lo sport, a parte il pugilato, un investimento di prestigio ma non particolarmente redditizio. Parecchia poesia, ma come investimento etico. Disastrosamente, non diedi la giusta importanza ai videogame. Ovviamente potevo contare su una solida base di buoni del tesoro pluriennali, cioè la mia cultura televisiva, che risaliva all’infanzia: la tivù era entrata in casa Trucco nel 1962, proprio in occasione della mia nascita.
Riguardo in particolare alla musica, mi liberai di parecchia roba, in particolare del metal più estremo e rigoroso, sceso a livelli di junk bond. Un assolo di chitarra era sufficiente per un downgrade da parte di Standard & Poor, mentre quelli di batteria erano stati da tempo dichiarati illegali sia dalla Consob che dalla Sec, quindi disinvestii. Investii invece – era l’ora, avevo quarant’anni, cribbio – in classica e jazz, la musica cosiddetta ‘seria’, ma erano investimenti di mantenimento e diversificazione, non core business, per non parlare dei musical di Broadway, un’infatuazione irrilevante dal punto di vista del capitale. Niente rap, niente hip hop, niente techno, niente dance (a parte il recupero nostalgico di certa Disco anni Settanta) – il mio repertorio di pregiudizi in fondo non era cambiato di molto – e recupero del pop vintage che aveva ignorato quando era nuovo: insomma, l’avevo sempre saputo che gli Abba erano grandi, solo che non potevo ammetterlo. Anche la musica italiana ora aveva un suo (piccolo) perché.
A livello di capitale emotivo la situazione era un po’ diversa. Io scrivo e leggo sentendo musica, soprattutto jazz e classica e lounge, ma non posso farlo col rock: Mozart e Duke Ellington, per non parlare di Herp Albert, riesco a usarli come sottofondo, i Metallica o gli Who no. Quando arriva il rock devo prestare attenzione – o cambiare stazione. Più tempo passavo a scrivere, come cominciai a fare sul serio nel 2010, meno rock ascoltavo. Il suo posto nella mia vita emozionale si restringeva sempre di più ma senza mai sparire del tutto. Era lì, a disposizione per quando non potevo farne a meno ma di solito potevo farne a meno.
Questa era la situazione quando, nel 2008, mi imbattei in un piccolo libro che avrebbe cambiato il mio modo di considerare la musica e non solo.

3.
“33 1/3” è una nota collana di monografie su singoli album rock e pop scritti da giornalisti e critici musicali e pubblicata in Gran Bretagna da Continuum a partire dal 2003. Finora sono usciti 154 titoli che spaziano da Jeff Buckley ai New Kids on the Block, dai Led Zeppelin a Janet Jackson, da Bruce Springsteen a Kanye West (quasi totalmente anglofoni, però: Can, Serge Gainsborough e poco altro – anche Angelo Badalamenti, unico nome italiano, presente con la colonna sonora di Twin Peaks, è nato a Brooklyn).
Nel 2007 esce un titolo che si rivelerà assolutamente seminale: Let’s talk about love. A journey to the end of taste del canadese Carl Wilson: si occupa dell’album omonimo di Celine Dion, quello con My heart will go on, la canzone del film Titanic. Lo comprai a Londra, incuriosito da una entusiastica recensione sul Guardian. Il libro ebbe un tale successo da essere ristampato nel 2014 in un’edizione celebrativa con una nuova introduzione di Wilson e saggi di Nick Hornby, Krist Novoselic, James Franco e altri. Il testo è lo stesso, eccetto che per il sottotitolo che ora è Why other people have such bad taste. La traduzione italiana è del 2014, per la defunta ISBN, e il titolo porta l’impronta inconfondibile del fondatore della casa editrice, Massimo Coppola: Musica di merda (lo trovate ancora per Kindle).
Wilson usa Celine Dion, all’epoca al culmine della sua fama mondiale, per esplorare il concetto di gusto, in campo musicale ma non solo, in particolare cosa significano i nostri gusti personali e soprattutto perché diamo loro tanta importanza. Wilson era nato e cresciuto nella francofona Montreal, dove la precoce Celine, la più piccola di 14 tra fratelli e sorelle, era famosa da ben prima di essere conosciuta nel resto del mondo. Per il giornalista, perfettamente inserito nell’ortodossia rock, la ragazzina di 16 anni che nel 1984 cantò di fronte a Papa Giovanni Paolo II nello stadio di Montreal rappresentava il Male, l’essenza di tutto ciò che non è cool e kétaine, la variante quebecois del kitsch. Il cool è la moneta di scambio principale dell’economia della reputazione nel tardo XX e primo XXI secolo. Celine Dion, malgrado tutto il suo successo, era e è uncool fino al midollo.
Però anche Wilson, all’inizio del secolo, comincia a notare i rendimenti decrescenti dell’investimento nel rock, cosa che lo destabilizza non poco, avendogli dedicato tutta la sua vita professionale. ‘La morte di Kurt Cobain ribadì la sconfitta e l’incorporazione delle ambizioni utopico-prometeiche del rock’, come disse Mark Fisher – c’era voluto qualche anno perché tutti lo ammettessero e il 5 aprile 1994 diventasse la data ufficiale in cui tutto era finito.
Wilson comincia soprattutto a essere disturbato dal disprezzo per la Dion, dallo snobismo confinante col razzismo nei suoi confronti e precisamente coincidente col classismo con cui i possessori del capitale contro-culturale considerano i suoi fan, gente non giovanissima, sovrappeso, che viveva nei posti sbagliati, vestiva male e faceva lavori ridicoli. Contava anche il fatto che la francofona Dion, pur imparando l’inglese, restava in qualche modo estranea alla koinè anglofona. Un atteggiamento che fino a poco tempo prima gli era parso perfettamente normale cominciava a non essere più tale: era il momento di ripensare tutto da capo. Let’s Talk About Love è un brillante saggio-memoir nel quale Wilson intreccia storia personale, cultura canadese, critica musicale e teoria sociologica.
Perciò ecco Pierre Bourdieu e la ‘distinzione’: il centro di Let’s talk about love è un riassunto divulgativo delle teorie sul gusto del sociologo francese. Si parte da una frase di Paul Valery, per cui il gusto non è altro che la somma di mille piccoli disgusti. ‘Avere gusto significa saper escludere’ – escludere manufatti culturali ma soprattutto escludere quanti li amano. ‘Come per il denaro, il capitale culturale e sociale dipende dalla scarsità, sul sapere quel che gli altri non sanno’. La distinzione, che nella Francia degli anni Sessanta di cui tratta il saggio di Bourdieu è ancora largamente verticale, con chiari riferimenti di classe alta, media e bassa, a cavallo del millennio acquista nuove polarità, più orizzontali. Il cliché indie-rock ‘Mi piaceva quella band – finché non ha cominciato a piacere a gente come te’ è un esempio perfetto di distinzione in azione. Allo stesso tempo l’insicurezza nel gusto provocata dalla sua natura sociale è un fattore potente nel processo di crescita artistica e l’estetica è la disciplina accademica create per gestire questa insicurezza.
In termini di distinzione i contenuti culturali non hanno un’essenza autonoma ma sono soggetti quasi esclusivamente a una dinamica di inclusione-esclusione sociale. Quel che è per definizione signorile in un secolo diventa volgare il secolo successivo quando è alla portata di chiunque possa comprarlo. L’altro fattore importante è la dinamica interna del campo culturale, essenzialmente una lotta di potere fra fazioni che si appoggiano a teorie e canoni estetici ‘oggettivi’.
Una delle accuse principali alla musica di Celine Dion è quella di essere fradicia di un sentimentalismo troppo disinibito, sia nella natura dei testi che dei temi che se non sono strettamente reazionari – Dion è politically correct in maniera persino rinfrescante – sono quantomeno molto tradizionali: l’amore vince tutto, ma è anche dolore e sacrificio, e mai dimenticare la famiglia. Il sentimentalismo – che nell’accezione showbiz americana si identifica nello ‘schmaltz’ – è equiparato automaticamente con il conformismo politico e culturale. Ma la ‘sovversione di oggi è l’inverso del sentimentalismo: è quasi sempre un termine di approvazione’. Però ‘la retorica aziendale e governativa imita la sovversione e si tramuta in schmaltz ribellistico’. Una forma di ‘razionalismo machista’ è gran parte del motivo per cui ‘ci piace condannare il sentimentalismo’.
E’ curioso, dato che nel XX secolo la missione dell’arte moderna era diventata ‘non solo la rivelazione di verità superiori ma anche l’attacco contro la falsità sociale. L’idea stessa di bellezza diventa una resa imbelle ai valori borghesi – ora la bruttezza, l’oscenità, la casualità e la mancanza di forma possono essere il nuovo buon gusto. L’innovazione diventa il termine di paragone e gli artisti tentano continuamente di superare il gusto, di violare i suoi termini o di renderlo irrilevante’. Come ci ricorda Boris Groys, ora non è più l’osservatore a giudicare l’opera ma l’opera a giudicare – e di solito condannare – l’osservatore. Ciò non potrebbe essere possibile – chi vuole essere giudicato? – senza un massiccio investimento cognitivo e emotivo.
Una musica così pesantemente user-friendly come quella di Dion non può essere cool per principio, almeno nei termini di riferimento della cultura d’avanguardia e il rock, per parecchio tempo, ne ha fatto parte integrante, almeno dal momento in cui s’è cominciato a prenderlo sul serio (in fondo era nato come ‘musica da ballo’. Il primo grande evento rock italiano fu, nel 1957, 1° Festival del Rock and Roll e Danze Jazz’ al Vigorelli di Milano, dove le star erano ‘Adriano Celentano e i suoi Rock Boys’ - fra i chitarristi i giovanissimi Enzo Jannacci e Giorgio Gaber - e l’organizzatore Bruno Dossena, ballerino e ‘campione mondiale di rock and roll’, che morì tragicamente in un incidente stradale l’anno successivo).
La centralità culturale della musica finisce per snaturarla. ‘Nella vita di tutti i giorni la musica è di solito parte di altre attività, dal ballo ai lavori di casa, dal sesso al gossip. Nel discorso critico è come se l’unica cosa giusta da fare ascoltando musica sia il giudicarla. La questione diventa “questa musica è adatta a essere giudicata criticamente?”’.
La manutenzione delle emozioni diventa un’attività sospetta (eccetto che l’unica emozione ammessa, il senso di superiorità e esclusione). I valori contro-culturali si focalizzano sul lato negativo e finiscono per sentimentalizzare l’ambiguità e il negativo (un po’ come fa Walter Siti nel suo recente pamphlet contro l’impegno) e le gerarchie dell’antisentimentalismo sembrano finire in un perverso rovesciamento dei valori, puro marker culturale cattivista. Per citare la critica cinematografica Pauline Kael, nel suo famoso saggio del 1969 ‘Trash, art and the movies’, l’arte finisce per impoverirsi: ‘Non siamo solo gente educata e di buon gusto, siamo anche gente comune con sentimenti comuni. E questi nostri sentimenti comuni non sono tutti CATTIVI’. Milan Kundera identificava il kitsch con quell’arte che vorrebbe eliminare dalla vita la merda; però così la vera arte, quella originale e innovativa e profonda e disturbante e significativa, era quella che si identificava con la merda e ci sono degli ottimi motivi per l’impopolarità della merda.
Insomma, al termine di questo percorso le pretese di superiorità culturale del rock – o meglio della versione colta del rock (e non posso che essere felice del fatto che il mio amato metal sia stato sempre considerato con estremo sospetto dal canone della coolness se non proprio escluso come musica per bifolchi), quella che rifiuta la contaminazione col pop – risultano, appunto, solo pretese. E togliere dalle spalle del rock il peso della distinzione non può fargli che bene, dal punto di vista del divertimento e anche, in definitiva, dell’arte. Come minimo avrebbe potuto farlo uscire dalla crisi in cui era caduto a partire dagli anni Novanta.
Alla fine del libro Wilson si era riconciliato con Celine Dion (magari non musicalmente, ma emotivamente sì); io invece avevo cominciato a seguire l’Eurovision Song Contest.

4.
La finale di X Factor 11 che ho descritto prima non la vidi all'epoca, dato che non seguivo la trasmissione da quando non era più in RAI. Dei Måneskin sapevo giusto che esistevano e le uniche due cose che mi facevano venire in mente erano: ‘Uh, che bello, chitarre!’ e ‘Ma quanto è figo il cantante?’. Non abbastanza. Mentre loro reagivano con determinazione alla delusione post-talent io ascoltavo altro.
Poi vinsero un po’ a sorpresa Sanremo e io, come tanti che un tempo avrebbero trovato la cosa assurda, Sanremo lo seguivo da qualche anno. Una bella sorpresa, dal mio punto di vista: in fondo, e sgombriamo il campo subito, buono o mediocre che sia, il loro è indubbiamente rock. Ma soprattutto la vittoria sanremese voleva dire che sarebbero andati all’Eurovision Song Contest e a me l’ESC interessa molto. E se c’era un gruppo italiano in grado di vincerlo erano proprio i Måneskin.
Uno dei rari momenti di leggerezza del 2020 è stata la commedia Netflix americana Eurovision Song Contest: The Fire Saga, con Will Farrell e Rachel McAdams, che vi interpretano i Fire Saga, rappresentanti dell’Islanda al festival: le circostanze hanno fatto sì che il film fosse, in pratica, il sostituto del festival rimandato per via del Covid. Satira, ovviamente, e Dio sa quanto l’ESC possa essere ridicolo. Fra l’altro, in quanto film americano, avrebbe potuto essere una satira dall’alto, dal punto di vista dell’aristocrazia della popular music, e sappiamo quanto la satira dall’alto possa essere antipatica (ve la ricordate Complesso del Primo Maggio di Elio e le Storie Tese?). Il film però si rivela qualcosa di diverso: quando i Fire Saga sul palco cantano la loro finta canzone islandese Husavik ci rendiamo conto con una certa sorpresa che è una bella canzone, una tipica canzone da Eurovision però BELLA. Una contraddizione in termini, no? Il film si rivela un omaggio, ironico e affettuoso.
Considerate la scena in cui, durante una festa favolosamente trash, Farrell, McAdams e altri personaggi del film cantano (un ‘song along’) insieme a passati vincitori del concorso, come la drag queen austriaca Conchita Wurst che vinse nel 2012. Tutte cover - Abba, Black Eyed Peas, Cher, Celine Dion… - e la scena è così simpatica e contagiosamente allegra, tipo un matrimonio in cui si balla e tutti sono un po’ bevuti ma non troppo e ci si diverte sul serio, e i cantanti sono così ovviamente, come dire, ‘bravi’ che il dubbio viene: non è che per tutto questo tempo avevano avuto ragione loro e che la musica che ci piace davvero ascoltare è, insomma, questa? Come minimo è musica che non pretende da noi che la si prenda sul serio, non è musica buona giusto per esprimere giudizi e sentirsi superiori.
L’Eurovision è una strana bestia. Nasce nel 1956 per iniziativa delle varie televisioni nazionali dell’Unione Europea come imitazione continentale del Festival di Sanremo. L’obbiettivo è quello di promuovere la comunicazione e comprensione fra popoli che avevano smesso di massacrarsi giusto una decina d’anni prima, un’idea ministeriale e burocratica dell’entertainment, con cantanti vestiti da sera su un palco pieno di fiori. Finisce per diventare la perfetta incarnazione del trash come ‘imitazione fallita’, per usare la nota definizione di Tommaso Labranca. Negli anni del rock e poi dell’hip hop, del dominio incontrastato sulle nostre vite emotive di Stati Uniti e Gran Bretagna, l’Europa offriva boy band belghe, bluesman norvegesi, neomelodici croati, metallari finlandesi e dive soul armene, e, come diceva Montale citando il suo amico Missiroli, non si può essere grandi poeti bulgari.
Non per niente la BBC lo trasmetteva come programma comico e la Gran Bretagna, la terra dei Beatles, dei Rolling Stone, dei Black Sabbath, dei Led Zeppelin, degli Oasis etc, mandava gli scarti della sua creatività: dei quattro vincitori britannici i più noti sono Sandie Shaw e Kathrina and the Waves. Vi lascio immaginare gli altri. Del resto, solo due star veramente riconosciute hanno vinto negli anni: gli ABBA nel 1974 – dimostrando che puoi vincere con una canzone, ‘Waterloo’, non solo bella ma soprattutto memorabile (e nella popular music memorabile significa bello) – e la nostra Celine Dion per la Svizzera (?) nel 1988. L’Italia, ricordiamo, aveva vinto solo due volte: con Gigliola Cinquetti nel 1965 e Toto Cotugno nel 1990. Non proprio il massimo, anche se uno scopre che Franco Battiato partecipò nel 1995 insieme a Alice con I treni per Tozeur – insomma, quando voleva il saggio di Riposto non era uno snob, motivo di più per ricordarlo con affetto.
Le competizioni fra prodotti dello spirito sono sempre problematiche, proprio per principio, a qualsiasi livello di prestigio: vale per i Nobel, gli Oscar, lo Strega, Sanremo e l’Eurovision. Le regole di voto per l’ESC cambiano negli anni ma c’è una regola fissa: una nazione non può votare per sé stessa, cosa che dà il via a risultati caotici con paradossi di Condorcet impilati l’uno sull’altro e nazioni che si promettono amore eterno (tipo che la Grecia vota SEMPRE Cipro e Cipro vota SEMPRE la Grecia) mentre altre portano avanti vecchi contenziosi territoriali risalenti almeno alla Guerra dei Trent’anni. L’effetto curioso è che se le canzoni sono generalmente pop perbenista e disimpegnato la politica è sempre presente. Ma politica vera, la politica degli stati, dei governi e dei partiti. Di solito la musica ‘politica’ non è altro che il commento, a volte brillante, a volte evocativo, ma di solito superficiale e poco informato, ai fatti del giorno: soprattutto è musica che malgrado le sue pretese lascia il tempo che trova proprio politicamente. Le canzoni politiche possono essere belle (di rado ma succede) ma appunto, solo come canzoni perché, si sa, ‘poetry makes nothing happen’ (W. H. Auden). L’Eurovision invece alla politica è legato a doppio filo. Legato come strumento, vero, ma legato comunque. E comunque solo la politica può spiegare come abbia fatto il Lussemburgo a vincere cinque volte e l’Italia solo tre.
Negli ultimi anni è successo che, col declino del rock e la crescente rispettabilità critica di hip hop, rap e trap – cioè il nuovo mainstream, la musica che si DEVE seguire – l’Eurovision, con il suo appeal pop-ulista nel senso buono del termine, ha trovato una sua nuova collocazione e persino importanza. Non è solo l’evento culturale (sì, culturale) più seguito al mondo ma è anche quello più GLBT-friendly, cosa che ha provocato le reazioni negative di certi governi populisti nel senso cattivo del termine. Con la crescita costante del pubblico le nazioni si sono impegnate a mandare artisti migliori che si esibiscono in set sempre più fastosi. I momenti cringe di imitazione fallita non mancano mai ma non sono più tutta la storia. Insomma, ci si diverte. In più, è l’immagine di un mondo senza gli Stati Uniti o in cui gli Stati Uniti contano poco, come i Mondiali di calcio. Forse è l’immagine del futuro.
E il futuro è adesso. Il 2021 è stato l’anno in cui l’Eurovision Song Contest è diventato VERAMENTE importante.
‘The Eurovision Song Contest has never been more important’, scriveva lo Spectator, il venerabile magazine conservatore britannico, il 21 maggio scorso, parole che sarebbero sembrate davvero strane dieci anni fa (dagli inglesi, poi!). Saltata per il Covid l’edizione 2020, quella del 2021 si è caricata, come tutto quanto in questa ansiosa e spossata primavera di riapertura, di un clima d’attesa sproporzionato, sia a livello di copertura mediatica che di schiuma social. La finale del 22 maggio, presso l’arena di Rotterdam Ahoy, è stata vista da 183 milioni di spettatori e è stata sfarzosa e drammatica come meglio non si sarebbe potuto sperare. I Måneskin, con un pezzo che potremmo definire glam-punk, Zitti e buoni, e una presenza scenica molto più rodata rispetto al Forum di Assago del 2017, erano fra i favoriti ma nel corso della lunga sequenza delle votazioni varie nazioni si sono ritrovate in testa: l’Islanda, l’Ucraina (con la mia canzone preferita, Shum, un rituale di fertilità pagano trasformato in pezzo dance allegramente minaccioso), la Finlandia (con l’altra canzone rock della serata, una cosa alla Linkin Park/Limp Bizkit in inglese), la Francia e la Svizzera – il tutto in mezzo a una festoso tifo calcistico non solo da parte della ridotta audience live ma anche degli artisti stessi. Gli italiani, solo quarti dopo il voto sempre opaco delle giurie di qualità, sono portati alla vittoria dal televoto. Tempi televisivi perfetti e suspense gestita benissimo da tutti, specie dai quattro giovani romani, emotivamente trasparenti in modo quasi commovente. La reazione al momento della vittoria è fra le migliori di sempre, per noi intenditori, specie il batterista, Ethan, che ha un’esperienza mistica istantaneamente memetica. Il messaggio al mondo urlato da Damiano sembra fatto apposta per scaldare il cuore dei vecchi rocker: ‘Rock’n’roll never dies!!!’.
Poco dopo, durante la conferenza stampa, Damiano, probabilmente non del tutto lucido in quel momento, scopre da un giornalista che qualcuno online lo accusa di essersi fatto una pista di coca in diretta mondiale. Benvenuti a Mordor, ragazzi.
Nota bene: il rappresentante inglese, James Newman, un tipo simpatico ma privo di qualsiasi carisma e con una canzonetta insignificante, arriva ultimo con 0 punti complessivi, un record difficilmente superabile (la prende con gran classe, però). Lo Spectator, ancora lui, si indigna: la Gran Bretagna non può prendere così sottogamba la ‘manifestazione culturale più vista del mondo’: se la BBC non fa il suo dovere, allora ci deve pensare qualcun altro, per esempio il canale tivù privato ITV. Il governo deve intervenire. Mandiamo Sir Paul McCartney!
Sempre dall’Inghilterra, un tweet chiede agli italiani perché ‘tenessero nascosto un simile tesoro’. Già. In effetti gli italiani non lo sapevano affatto, di tenere nascosto un simile tesoro.
(continua qui)