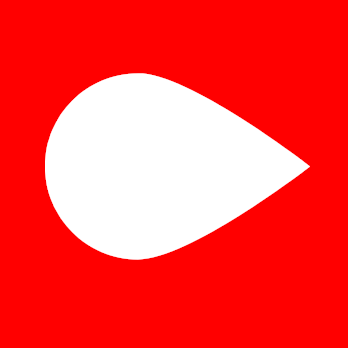Il dio è morto, e continua a farci danzare
Uno scambio con Paolo Pecere, autore del saggio "Il Dio che danza. Viaggi trance e trasformazioni".
Il Dio che danza. Viaggi trance e trasformazioni è l’ultimo libro di Paolo Pecere, docente di filosofia, autore di numerosi saggi e di due romanzi. Ne Il Dio che danza, Pecere racconta i viaggi da lui compiuti sulle tracce del fenomeno di trance da possessione indotta dalla danza e dalla musica.
«Il cammino inizia dal tarantismo in Puglia, sulle orme di Ernesto de Martino, e, seguendo collegamenti storici e mitologici, prosegue in India Meridionale, dove nel theyyam gli dèi entrano nel corpo dei danzatori. Approda poi in Pakistan, dove il pensiero scivaita teorizzava che “il sé è un danzatore” e i sufi vanno in estasi ruotando al ritmo della musica; in Africa, dove è possibile osservare le possessioni dello zâr e del vodu; infine in Brasile, dove il vodu, arrivato con la tratta degli schiavi, si affianca alle culture e ai culti indigeni, tra cui lo sciamanismo amazzonico». [1]
Jacopo La Forgia - Chi è il “dio che danza”? Nel primo capitolo del libro scrivi che si tratta di «un dio straniero che viene da lontano, che cambia identità, che viene fatto a pezzi e si ricompone, che è uomo e animale, uno e molti, che finisce in catene, che le spezza, che libera». Ad Andrea Cafarella, nell’intervista uscita su Kobo, racconti che: «è Dioniso, è Shiva, ma è anche – secondo l’ipotesi del mio libro – in genere la figura di un’entità che anima e agita il corpo di una persona in stato di trance, o estasi. Il mio libro nasce dall’idea di raccogliere alcuni scritti e riflessioni su viaggi fatti in un periodo di tempo piuttosto esteso, dal 2005 al 2020. Selezionando il materiale mi sono reso conto che per molti anni, in alcuni dei miei viaggi, ero andato sulle tracce di fenomeni di trance da possessione, come il theyyam in Kerala, le danze sufi in Pakistan e il vodu in Benin». [2]
La chiave di lettura di questi fenomeni proviene da esperienze fatte nell’infanzia. Da bambino passavi spesso l’estate in Puglia, regione di provenienza della tua famiglia; ti appariva «antichissima ed essenziale, come se le pareti bianche delle case, il torchio del frantoio e gli ulivi contorti sapessero qualcosa che [al te bambino] sfuggiva» e che col passare del tempo sfugge sempre di più; in Puglia sperimentavi per la prima volta «l’atto di immaginare di essere altre persone, di incorporare altre voci».
Tra le cose che racconti sui tuoi viaggi d’infanzia ce n’è una che mi ha colpito molto:
«Sulla via del mare ogni anno si visita il cimitero. L’odore di fiori e bruciato invade i sensi, marca il passaggio a un altro mondo silenzioso. Tra i vialetti di marmo, sotto i cipressi, tutti avanzano senza parlare, fermandosi di fronte alle tombe come se non ci fosse modo di passare oltre. L’estate al Sud è anche una pedagogia della morte: lo portano al letto del nonno morente, lo bacia, gli tiene la mano rugosa».
Che ruolo ha la morte nel tuo percorso sulle tracce dei fenomeni di trance, possessione, estasi mistica?
Paolo Pecere - È una domanda interessante, a cui non avevo pensato, e la prima cosa che mi viene in mente è che nei miei tre libri narrativi – prima di questo, i romanzi La vita lontana e Risorgere – c’è sempre la morte di un parente che innesca un viaggio di scoperta, e questo viaggio passa anche per l’Asia. Restando al Dio che danza, la morte ha sicuramente un ruolo fondamentale nel percorso del libro. Per un verso, vado in cerca di fenomeni che in Italia sono scomparsi: i tarantati pugliesi, i danzatori dell’argia sarda, e più in generale il mondo contadino in cui per secoli queste persone hanno danzato – un mondo che è stato anche quello dei miei nonni – non ci sono più. Dunque il libro si apre con una rielaborazione di storia e memoria, e con la domanda su cosa riempie quel vuoto nella società italiana di oggi. Per l’altro verso, l’esperienza di possessione è un transitorio diventare altro, quindi una morte simbolica, che però è anche trasformazione. Tra questi due poli si muove l’io viaggiante del mio libro.
L’infanzia è una delle chiavi con cui tento di accedere all’esperienza della trance di possessione, in quanto età in cui si gioca a diventare altri, s’immaginano altri mondi, si vive ancora sulla soglia delle norme sociali. Ed è anche l’età in cui ho vissuto questo moto pendolare tra Roma e il Sud, dove ho incontrato le ultime appendici del mondo rurale del tarantismo, con i bisnonni e i nonni che ho perduto precocemente. Negli uliveti roventi, nel bagno rigenerante, ho ritrovato lo scenario del tarantismo di cui parlano le fonti moderne, ma boschetti e acqua sono anche lo sfondo degli altri rituali a cui ho assistito in terre lontane. Così la natura permette di far rinascere ciò che la cultura ha perduto, e del resto Dioniso, Shiva, e altri dei di cui parlo, erano la natura che distrugge e ricrea.

JLF - Il soggetto dei ricordi del primo capitolo sono tre persone e una persona sola: Paolo Pecere bambino che d’estate visita la Puglia; Paolo Pecere adulto che ricorda il sé bambino, e che ricerca nell’infanzia il luogo in cui inizia l’interesse per i fenomeni di trance di possessione; Paolo Pecere in carne e ossa, che ora legge le domande che gli pongo. Una molteplicità unificata dalla narrazione o un io che si moltiplica nel corso di un’esperienza − il viaggio che inizia in Puglia negli anni settanta e che si conclude a luglio 2020 a San Cesario di Lecce, dopo esser proseguito nel subcontinente indiano, nell’Africa occidentale e in Sud America.
Nel primo capitolo descrivi e analizzi il tarantismo. Tra le altre cose, scrivi che «la trance del tarantismo non includeva soltanto una crisi dell’individuo, ma apriva un dramma di trasformazione, un farsi altro ed esplorare altre identità, anche di genere». Nel seguito del libro, questo dramma di trasformazione, questo farsi altro è poi da te ricercato e analizzato in altri rituali, quali il dhammal dei dervisci in Pakistan, le cerimonie di possessione dello zâr in Etiopia, i rituali afroamericani del candomblé e dell’umbanda in Brasile. Il dramma di trasformazione diviene così un elemento chiave dell’architettura del testo.
Perché quando parli del bambino che scopre, vivendolo, il dramma della metamorfosi, usi la terza persona? Che impatto ha questa scelta formale sulla narrazione, e cosa significa partire da un’esperienza personale per descrivere un fenomeno che ritrovi, simile o diverso, in culture e società così distanti tra di loro?
PP - Ho scelto la forma del saggio narrativo, con un io narrante, perché volevo accompagnare il lettore, avvicinarlo alle esperienze di cui parlo e coinvolgerlo nella mia ricerca di comprensione, che non sempre arriva a conclusioni certe. Per ottenere tutto questo dovevo introdurre i luoghi di cui parlo, che in molti casi il lettore non conosce, ma anche mettere in luce il momento dell’arrivo di un osservatore con una origine e bisogni ben precisi. Solo così si può dare un’idea adeguata di cosa significhi oggi la trance da possessione, in società diverse di un mondo globalizzato, in cui il narratore arriva da straniero, e in certi casi è percepito come turista, o finanche discendente dei colonizzatori. Questo osservatore sono io ma potrebbe essere un altro. Nel libro non c’è una volontà autobiografica e i riferimenti personali sono ridotti all’osso e intrecciati alla trama del libro. Caratterizzano una persona in carne ossa, un figlio di emigrati che prova una strana nostalgia per un passato familiare, ma anche per passati del tutto stranieri, e che comprende ancora i bisogni a cui rispondono i rituali di danza e possessione: bisogni di cura, di riscatto sociale, di visioni del mondo alternative, di ricreazione artistica, e così via.
Dovendo orchestrare tutto questo, come dici bene, mi trovo distante dal bambino che ero, e rielaboro alcuni ricordi attraverso le letture successive: costruisco, per così dire un contrappunto tra il viaggio di de Martino nella Puglia del Dopoguerra e i miei viaggi d’infanzia nella Puglia dei primi anni ’80, che è altrettanto distante da quella di oggi. Perciò uso la terza persona: quel bambino appartiene alla serie di personaggi che abitano il libro, accomunati da una comune ricerca di un’altra vita. Si tratta del resto di un espediente narrativo profondamente radicato nella nostra tradizione, e nel libro, per definire cosa cerco di fare, mi riferisco proprio a una scrittrice di romanzi – Zadie Smith – quando scrive che la sua narrazione consiste nell’incorporare altre voci.
JLF - Parliamo di possessione. È uno dei meccanismi della trance rituale, e nei tuoi viaggi ne incontri diverse tipologie. Nel quarto capitolo, “Il dio nascosto”, siamo in Ghana, dove Jean Rouch, inventore dell’antropologia visuale, realizzò nel 1954 il suo documentario più conosciuto, Les Maïtres fous, I maestri folli.
Le immagini documentano il culto degli Hauka, nato in Niger negli anni venti del Novecento e portato in Ghana da emigranti lavoratori, che Rouch incontra al mercato del sale di Accra. Li segue nella boscaglia, dove vanno a diventare altri. Nei pressi di una costruzione di legno, che dicono sia il palazzo del governo, ciascuno a turno si trasforma – gli occhi roteanti, la bocca schiumante – e incarna un personaggio del potere coloniale: il “Generale”, “la sposa del Generale”, il “Colonnello”, il “Caporale”, il “Dottore”, “Madame Lokotoro, la moglie del dottore”, il “Macchinista ferroviario” e cosí via. Sembra un gioco di ruolo infantile divenuto dissociazione, una grottesca mascherata che finisce con una riunione di corpi oscillanti, ebbri, in cui si delibera il sacrificio di un cane. Tutti si gettano per terra a berne il sangue. Il giorno dopo i giovani si ritrovano serenamente nella vita urbana: venditori tra banchi del mercato, negozianti, soldati semplici, operai intenti a scavare buche per le condutture d’acqua di fronte all’ospedale psichiatrico.
Alla pagina seguente scrivi:
Il paradosso sta nel riconoscere una funzione salutare a questi stati di agitazione corporea, in cui è tanto evidente la mancanza di controllo razionale: come si può trovare un motivo di ammirazione, invece che di smarrimento o pietà, per quelle sceneggiate di individui dissociati, scissi, regrediti? Un modo per farlo consiste nel considerare che quella dissociazione è regolata, è una tecnica sociale che permette di vivere una molteplicità psicologica altrimenti impedita nel contesto politico e religioso dominante.
A partire da questo, si è ipotizzata la possibilità di «valutare i rituali e la trance di possessione come tecniche psicoterapeutiche». Tale ipotesi la avanza per primo Lévi-Strauss, come scrivi poco dopo, che paragonò lo sciamanismo alla psicoanalisi. Tra le due pratiche ci sono tratti comuni e differenze; sia nelle pratiche sciamaniche che in quelle psicoanalitiche si tenta di elaborare un conflitto tra l’io e l’ordine della realtà, ma la terapia della possessione, al contrario della psicoanalisi, non lavora in direzione di una reintegrazione dell’io; porta piuttosto «la persona a riconoscere che certi pensieri e sentimenti che sperimenta, e certi atti che realizza o vuole realizzare, non le appartengono e quindi devono essere tenuti distinti piuttosto che accettati».
In definitiva ritieni che la psicoterapia possa giovarsi della ripresa di un atteggiamento sciamanico?
PP - Non ho sufficiente competenza per rispondere a quest’ultima domanda, ma credo che la psicoterapia sia in prima istanza inseparabile dalla centralità dell’io, che deve riprendere il controllo della propria vita e consolidarsi. Questo vale almeno fintanto che il nostro orizzonte culturale non cambi radicalmente, cosa che difficilmente può avvenire in tempi brevi. Un “atteggiamento” sciamanico, così come la possessione, sono qualcosa di molto diverso a seconda dei contesti: è il problema che già rilevava de Martino, sostenendo che una diversa forma di “reintegrazione” culturale dovesse essere elaborata nel nostro mondo, che non può tornare incondizionatamente al magismo.
D’altra parte Michel Leiris, altra figura-chiave del mio libro – per così dire un Virgilio che accompagna il lettore per la parte africana del viaggio – vedeva la molteplicità psichica come una risorsa a cui riattingere, proponendo di ritrovare il “sacro” e il magico nella vita quotidiana in Europa. Ma si trattava di un ritorno all’infanzia e alla marginalità, a forme di esistenza non normali, che non venivano proposte come vie psicoterapeutiche istituzionalizzabili, ma come libere avventure dell’individuo, dall’esito incerto e fragile. Insomma l’abbandono dell’io può essere rigenerazione, ma anche regressione: in questa ambivalenza si colloca anche il mio libro, dove provo a rievocare l’energia straordinaria delle pratiche estatiche, ma tenendo anche fermo uno sguardo critico.
Lo sciamano moderno può essere il portatore di una visione del mondo diversa e liberatoria, ma può essere anche un ciarlatano. Perciò io sostengo che per rivivere qualcosa di simile alla liberazione dionisiaca bisogna vincere le norme introiettate, ma bisogna anche guardarsi dall’idealizzare il contesto reale in cui si svolge la nostra esperienza. Voglio indicare al lettore la possibilità di avere un doppio sguardo: quello capace di uscire fuori da sé e esplorare altre identità, anche mediante esperienze comunitarie, e quello capace di leggere gli interessi mondani di chi voglia approfittare della nostra intima fragilità.

JLF - Procedere per analogie può essere insidioso, come scrivi nel quinto capitolo, Il dio venuto dal mare:
Tutte queste analogie tra esperienze diverse, che ci accompagnano fin dall’inizio di questa indagine, pongono però un problema. Infatti, se usate in modo poco accorto, le analogie rischiano di tradire l’esperienza che vorrebbero descrivere, anche quando sono animate da un desiderio di solidarietà e di comprensione degli altri.
Come si può affrontare e risolvere questa problematica?
PP - Nel libro segnalo un paio di volte questo rischio: quando si cerca di comprendere l’esperienza di un posseduto – tarantato, adepto dello zar, del vodu, e così via – e si attinge all’infanzia col suo io poroso e la sua confidenza col gioco di ruolo, si rischia di attribuire una estrema ingenuità a persone adulte che vivevano e vivono in mondi storicamente ben caratterizzati. Al contrario, secondo me – e diversi altri osservatori – c’è una profonda scaltrezza nei posseduti, che convive con la loro credenza negli dei e spiriti. È molto difficile farsi un’idea adeguata di questa prospettiva provenendo dalla nostra cultura. Allora, che si fa?
Propongo, come faceva l’antropologo Clifford Geertz, di usare analogie, testimonianze dirette, fonti storiche, riflessioni antropologiche e filosofiche, per raggiungere una comprensione dell’esperienza altrui, senza pretendere di riviverla empaticamente. Questa comprensione non deve prescindere dalla diversità dei contesti: io che vivo a Roma oggi non posso davvero entrare nei panni di un umbandista che vive nella periferia di San Paolo. Ma se resto consapevole delle tante variabili, e assumo un atteggiamento di ascolto e comprensione, posso capire, e imparare qualcosa.

JLF - «Che vuol dire “sciamano”?» ti domandi all’inizio del sesto capitolo, Il dio della foresta.
Esiste una categoria di persone che possiamo chiamare così? L’uso di questo termine in un significato univoco e universale è un’invenzione europea. Tutto comincia in Siberia, tra Seicento e Settecento. Gli esploratori olandesi, tedeschi e russi che attraversano i domini più orientali della Russia riportano il termine tunguso šaman, da cui ricavano i calchi schaman, shaman, sciamano. Sull’origine e il significato della parola si discute ancora. L’arciprete ortodosso Avvakum Petrovič, esiliato in Siberia per la sua opposizione alla modernizzazione del paese, fu il primo a usare il verbo “sciamanizzare” nel senso di “divinare” il futuro, precisando che si trattava di profezie false e ispirate dal demonio.
Qualche pagina più avanti, poi, scrivi:
La scelta [di De Martino] di misurarsi con il mondo magico primitivo e lo sciamanismo in particolare – avrebbe ricordato tempo dopo – dipendeva dal bisogno di misurarsi con questo ritorno del mito: «Erano gli anni in cui Hitler sciamanizzava in Germania e in Europa, e ancora lontano era il giorno in cui le rovine del palazzo della Cancelleria avrebbero composto per questo atroce sciamano europeo la bara di fuoco in cui egli tentava di seppellire il genere umano». L’indagine su magismo e sciamanismo non nasceva quindi da una nostalgia di esperienze ataviche, ma dall’esigenza di fare i conti con quelle energie oscure dell’inconscio verso cui «l’esorcismo della ragione tradizionale non era riuscito appieno». Con l’auspicio, ispirato da alcune intuizioni psicoanalitiche, che a «rinnovare l’esorcismo fallito potesse concorrere una nuova etnologia, concepita come conquista di una ragione più ampia ed efficace».
In altre parole, capire il potere sciamanico e il suo fondamento antropologico, invece che liquidarlo come superstizione, era una condizione per interpretare il potere visionario e carismatico di personaggi come Hitler, che si radica in una medesima fragilità collettiva.
È possibile attualizzare questo ragionamento? In che modo l’indagine sul potere sciamanico può applicarsi alla situazione politica contemporanea?
PP - È un passaggio a cui faccio esplicito riferimento quando, alla fine del mio viaggio, mi trovo nell’America di Trump, l’anno prima dell’assalto a Capitol Hill, in cui le idee antidemocratiche hanno mobilitato, tra gli altri, Jake Angeli, il tizio vestito da sciamano. Si tratta di una figura emblematica, che vedo come complice e al tempo stesso vittima di un inganno mediatico. Nella situazione politica contemporanea, in un mondo privo di equilibrio geopolitico e di una realistica prospettiva di sviluppo globale, attecchiscono facilmente ideologie tribali, la cui prima mossa è sempre negare alcuni aspetti probematici della realtà e indicare un nemico esterno. Un esempio è il Brasile di Bolsonaro, un personaggio carismatico che fonda la sua retorica su discorsi falsi e su interessi mondani fin troppo ovvi mistificati in termini di cultura identitaria e religiosa. Il punto che mi interessa è come la possessione e lo sciamanismo siano campi di battaglia ideali: possono rappresentare al tempo stesso le risorse di culture subalterne e marginali e gli strumenti di un assoggettamento dell’individuo. Nella loro forma più autentica sono la prima cosa, e il mio libro vuole mostrare che come tali sono ancora qualcosa di vivo in tutto il mondo.

JLF - Con quale musica ti piace danzare?
PP - Prima ancora la domanda sarebbe: ti piace danzare? Sì, ma danzare è una parola troppo grande per me. Sono stato musicista a livello amatoriale, ascolto moltissima musica – dalla classica al pop, dall’hard rock alla dance – mi muovo sempre molto ascoltando la musica, e in qualche disgraziato caso ballo. La musica è la mia vocazione mancata, che sopravvive – senz’arte – nel movimento delle mani e del corpo. Quel che so fare, semmai, è dare ritmo alle parole. Durante l’anno del lockdown, questo libro dionisiaco e pieno di musica è stato un modo di danzare da fermo.
Pensiero
(1975) e autore e docente di filosofia. Ha pubblicato diversi saggi e un romanzo, "La vita lontana" (LiberAria).
08-06-2021
15-06-2021