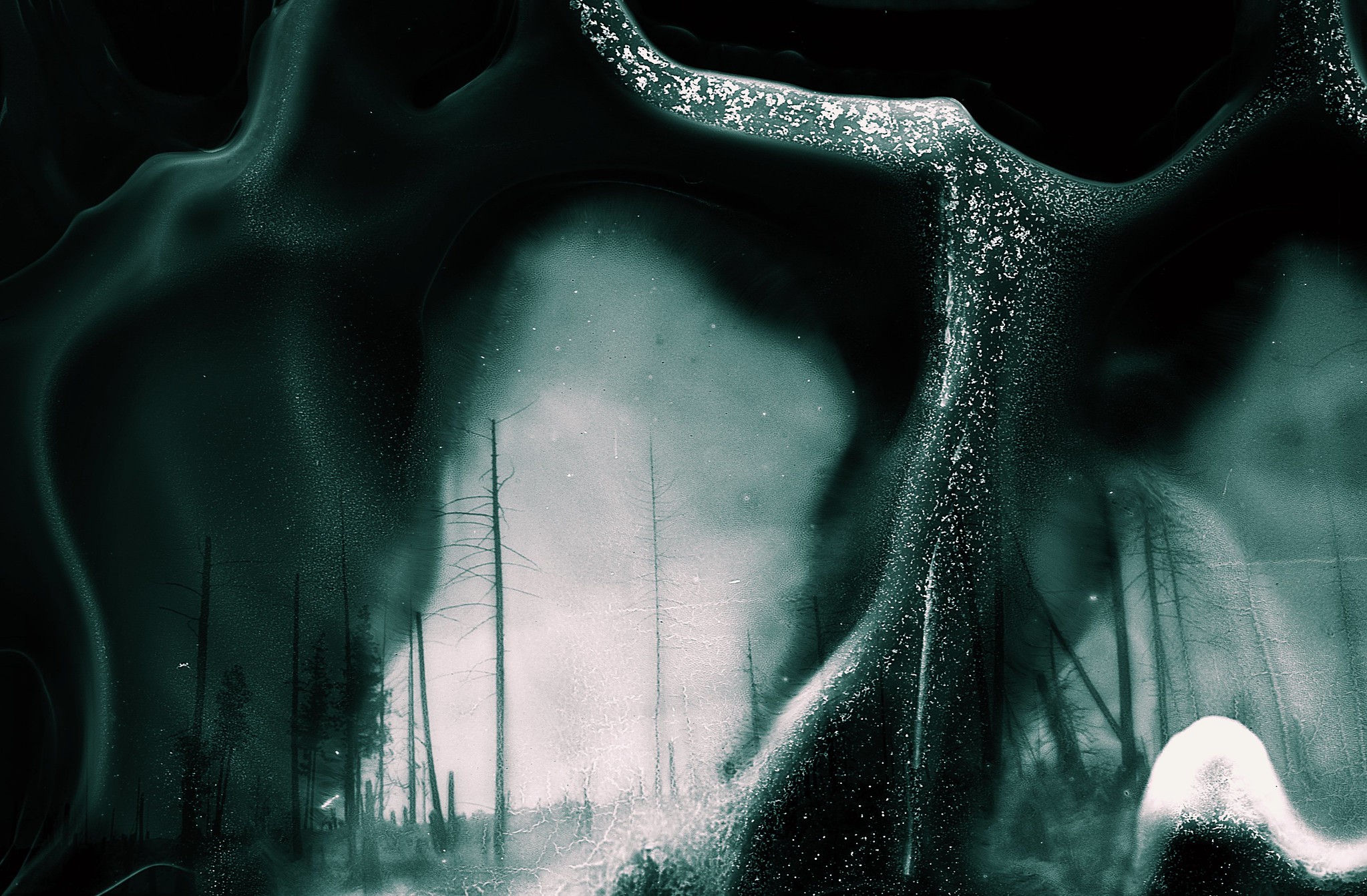Catabasi vegetativa: verso un'ecologia totale
Il mondo vegetale come inizio di un viaggio sulle implicazioni profonde dell'intelligenza e della vita. Un dialogo con l'autrice di "Così parlò la pianta", recentemente edito da Nottetempo edizioni.
Già nel 1848 il filosofo Gustav Theodor Fechner, nel suo capolavoro Nanna o L’anima delle piante scriveva:
L’opinione che la sensazione sia possibile unicamente mediante i nervi si appoggia in generale solo su di un’affermazione arbitraria o su di un sofisma: poiché i nervi sono necessari alla sensazione presso gli animali, i nervi sono sempre e in ogni caso necessari alla sensazione. Io oppongo a questa l’altra argomentazione: poiché le piante non posseggono nervi per la sensazione, devono avere qualche altra cosa che serva ad essa. L’una argomentazione è altrettanto valevole quanto l’altra, ossia nessuna delle due per sé sola serve: ciò che importa è se si possano trovare altri dati per sorreggerla.
Questa intuizione straordinaria – cuore pulsante di un testo che preannuncia gran parte delle scoperte scientifiche degli ultimi anni sull’intelligenza delle piante – è uno dei tasselli fondamentali da cui parte anche la ricercatrice, professoressa di Ecologia evolutiva alla Southern Cross University di Lismore, in Austrarlia, Monica Gagliano, della quale è stato finalmente tradotto (da Alessandra Castellazzi per nottetempo) il suo primo libro: Così parlò la pianta.
In questo testo avvincente, che può suonare a tratti anche ingenuo per quanto è autentico, Monica Gagliano racconta con una generosità che ha del prodigioso gran parte della sua esperienza: prima di tutto la ricerca scientifica (nel libro vengono raccontati i suoi studi più importanti sul comportamento delle piante), il rapporto conflittuale con l’accademia che l’ha portata a sviluppare un sistema di pensiero che lei stessa definisce “eretico”, e le esperienze di vita che l’hanno portata a incontrare ed esperire in prima persona anche alcune pratiche che potremmo definire “sciamaniche”; Gagliano ci fa partecipi, inoltre, del suo mondo onirico, e ci racconta di come sia possibile, tramite una resa incondizionata all’accadere della vita, cambiare sguardo sul mondo e imparare ad ascoltare persino il verbo delle piante. È molto raro ritrovare in un solo libro, seppur divulgativo, una narrazione tecnica e precisa di esperimenti eseguiti mantenendo comunque un certo rigore scientifico, insieme a un racconto autobiografico che suona molto vicino ai resoconti del cammino spirituale di alcuni illuminati personaggi che hanno vissuto e vivono tra noi.
Col senno di poi sappiamo bene quanto sia stato un peccato che il folgorante testo fechneriano Nanna o L’anima delle piante non sia mai stato un libro preso troppo in considerazione dalle cosiddette scienze dure, per il suo carattere poetico ed evocativo. Purtroppo, ben centosettataquattro anni dopo, sembra poter avere lo stesso destino anche questo libro, Così parlò la pianta, per le stesse ragioni. E, in fondo, si ripropone comunque la stessa medesima questione: se per Fechner era importante dimostrare che anche le piante hanno un’anima, per Gagliano è invece la loro intelligenza che bisogna indagare, ma poco cambia se il risultato tende ad affermare una verità che ormai sembra incontrovertibile: siamo una stessa cosa con la Vita, sia che essa si esprima in un germoglio, un gatto, un virus o un essere umano qualsiasi. E questa prova ontologica cambia tutto: suggerisce un modo nuovo e diverso di essere qui.
Penso che questo libro – ma più in generale questo modo di guardare il mondo, e di stare al mondo, con tutte le debolezze e le criticità che possano emergere nella pratica – sia esattamente ciò di cui abbiamo bisogno in questo momento storico. Non solo per la validità delle scoperte che vengono trasmesse nel testo ma soprattutto per il modo in cui sono raccontate, che ispira al cambiamento, prima di tutto individuale, di chi lo leggerà.
Per questo motivo ho deciso di intervistare Monica Gagliano che, come in altre conversazioni che potete trovare facilmente online, si è aperta con incredibile e sincera disponibilità, al punto che potrebbe sembrarvi una «pazza» o una mistica; ma vi assicuro che se provaste ad abbassare la guardia e a silenziare il giudizio, potreste anche scoprire che le piante sanno parlare e ascoltare, e che persino un topo può diventare un’aquila, e così cambiare punto di vista.
Andrea Cafarella - Qualche giorno fa stavo guardando delle interessanti conversazioni avvenute durante il festival «2084 – Storie dal futuro», a Milano. A una di queste [che potete rivedere e riascoltare cliccando qui] hanno partecipato Stefano Mancuso e Laura Tripaldi, che parlavano proprio dell’intelligenza altra in senso lato, dei vegetali e addirittura dei materiali. Ascoltarli mi ha fatto riflettere su quanto potremmo tirare “indietro” la linea di demarcazione tra cosa è intelligente e cosa invece non lo è; e anche sul fatto che noi esseri umani tendiamo sempre a dividere, mentre la prospettiva elementare di ogni essere vivente, secondo me, è più integrata rispetto all’alterità. Non si pone il problema, la divisione.
Mi piacerebbe che ci raccontassi delle tue ricerche in questo senso, di come affondano le loro radici proprio in questa dimensione intersezionale e non esclusiva, né del mondo umano né di quello vegetale; e come hai portato avanti il tuo lavoro in questa direzione.
Monica Gagliano - Quindi, da dove cominciare? Penso che il discorso centrale, rispetto alla definizione di cosa è intelligente – ammesso che una definizione sia necessaria – è proprio quello che dici tu: il nostro continuo desiderio di dividere. Le piante prima non erano considerate intelligenti ma ora sappiamo che lo sono; e ora troveremo sicuramente qualcos’altro che non è intelligente, e finché non proviamo che lo è, allora non è intelligente. Tutto questo ragionamento riguarda una decisione arbitraria che abbiamo preso in un certo momento della Storia. E ne siamo così convinti che non ci mettiamo mai in discussione: da dove vengono i pensieri? Perché sto pensando nella maniera in cui sto pensando? Riconoscere questo passo falso fondamentale, di aver creato questa separazione, può portarci ovunque, davvero.
Stavo rileggendo l’altro giorno, mi sembra, Intelligence in Nature di Jeremy Narby, non lo rileggevo da anni ma lo stavo sfogliando di nuovo. Sai quando tieni in mano un vecchio libro e apri una pagina a caso, di cui magari ti eri anche dimenticato, ed è proprio quella giusta? Ecco, lui dice una cosa del genere: cioè che nella nostra cultura – e intendo dire la cultura occidentale come intesa oggi – abbiamo questa fortissima idea che ci sono gli Umani e poi c’è la Natura. E la Natura è tutto ciò che non è umano. Perciò quando parliamo dell’intelligenza della Natura – a prescindere se stiamo parlando dell’intelligenza delle piante, dei funghi, o di un qualsiasi animale – abbiamo già compiuto questa separazione. Il solo fatto di avviare una conversazione su questo lo certifica. Il problema fondamentale è che consideriamo la Natura qualcosa di non umano. O dovrei dire la frase al contrario: non concepiamo gli umani come esseri della Natura.
E da questo discorso secondo me sorge l’intero problema, anche di dover controllare se gli altri possono essere intelligenti. Se noi siamo intelligenti, e noi siamo giusto una forma di vita, allora stiamo dicendo che la vita è intelligente, pertanto, ovunque vediamo della vita dovremmo innanzitutto assumere che è intelligente. E da lì, al limite, provare il contrario; invece di compiere il processo inverso. Perché non avrebbe senso per la vita essere diventata improvvisamente intelligente con noi, ma non prima. In più così stiamo dicendo anche che tutte le specie da cui proveniamo – letteralmente – non erano intelligenti, e poi all’improvviso noi abbiamo fatto questo balzo in avanti. Dai! Anche la Storia naturale non funziona proprio in questo modo. Lo sappiamo che non è andata così. E quindi perché dovremmo credere a una storia che, sia scientificamente, così come di sicuro anche da altre prospettive, non sembra avere un senso? Nonostante ciò, rimane questa la nostra auto-narrazione: noi abbiamo compiuto, di punto in bianco, questo salto che – ancora, e torniamo al discorso centrale – ci separa, ci distingue dal resto, che abbiamo chiamato Natura.
Quindi, partendo da questa idea – dovendo giocare anche una partita che, credo, noi dobbiamo giocare – bisogna scegliere come definire ciò di cui si sta parlando, e io avevo la necessità di definire l’intelligenza. Per esempio, nel mio libro l’intelligenza è interpretata a partire dall’etimologia della parola, dal latino, che significa: “scegliere tra”, quindi, se puoi percepire e discriminare; fare la differenza tra due o tre cose, e dopodiché scegliere tra queste una cosa anziché le altre, allora stai facendo delle scelte. E questa è l’idea principale della parola inter-ligĕre. In questo caso, per me, le piante sono intelligenti: perché quando si compiono certe scelte non ha importanza che sembrino o siano inconsapevoli; per favorire la fioritura, per esempio, o in certi casi estremi per sopravvivere; nella maggior parte dei casi anche noi facciamo lo stesso: le scelte che dobbiamo prendere, per la nostra sopravvivenza, sono perlopiù inconsce e non stiamo veramente a pensarci. Anche noi umani prendiamo scelte che hanno più a che fare con l’istinto che non con il ragionamento; anche se pensiamo di essere così eccezionali. Inoltre alcune di queste scelte “inconsapevoli” hanno conseguenze che non sono trascurabili, in quelle occasioni noi sappiamo di poter fare degli errori ma le prendiamo comunque in maniera automatica, nonostante siano rischiose – anche se sappiamo che normalmente non pagheremo un debito così grande come può essere il rischio di morire.
Quindi c’è questa meravigliosa gamma di differenti tipologie di scelta, e anche di diversi modi di scegliere, a seconda del tipo di scelta che un essere vivente deve prendere. E tutto ciò, che pensiamo sia una prerogativa della nostra vita, in realtà è ovunque.
In questo senso va il mio lavoro.
Certo, il fatto che la mia ricerca si concentri sulle piante è il modo in cui è emersa ma potrebbe essere applicata a qualsiasi cosa. Avrei le stesse domande, e avrei probabilmente ricevuto le stesse risposte, o più semplicemente non avrei cercato delle risposte, perché la domanda in fondo non ha nemmeno bisogno di essere fatta, ma alla fine è ciò che facciamo, e questo è quanto [ride].
AC - Basterebbe togliere la linea divisoria.
MG - Esatto. E non ci sarebbe più la domanda. Però, visto che la linea c’è e ci piace tanto mantenerla, la domanda emerge da questa frontiera, da questo incontro.

AC - Così parlò la pianta illustra anni di ricerche e di studio sul mondo vegetale ma i tuoi paper scientifici sull’argomento sono ed erano già ampiamente reperibili online. Credo perciò che la funzione primaria di questo libro vada oltre al raccontare le tue scoperte scientifiche, si concentra piuttosto sul percorso, su come tu sei arrivata a quelle conclusioni sviluppando un punto di vista fino a quel momento inedito. Il libro racconta soprattutto cosa succede quando ci mettiamo in ascolto, quando ci fermiamo a osservare lo spazio di frontiera, il confine di cui accennavamo sopra. E sei talmente tanto consapevole dell’azzardo insito in questo raccontarsi senza filtri che nella premessa lo dici esplicitamente: «Datemi pure della pazza». Il tuo tentativo è stato quello di mettere, insieme allo studio scientifico delle piante: i riti indigeni, gli psichedelici, i sogni e in generale la ‘sensibilità spirituale’ come strumento di conoscenza del mondo che andavi esplorando. Il messaggio che attraversa tutto il libro è che anche questi sono metodi tramite i quali il mondo vegetale – o banalmente il Mondo, nella sua totalità, senza separazioni – comunica con noi e ci può suggerire delle strade alternative. Questo mi sembra un modo di pensare, per visioni, per intuizioni, che ricorda il pensiero eretico di Giordano Bruno (che tu stessa citavi in una conferenza). Ci sono, a tuo parere, delle vie, degli strumenti che sono più raffinati, più sofisticati di altri? Oppure, come dicevi in un’intervista di qualche anno fa, basta accogliere le erbe che ci crescono dietro casa, e farlo con una certa attitudine, per comprendere i messaggi che il Mondo vuole trasmetterci, tramite una comunicazione sicuramente più discreta ma altrettanto efficace e simbolica?
MG - Direi che ogni via è una via maestra. Perché è specifica per te. La via diventa magica, incredibile, sofisticata a seconda della tua predisposizione a intraprenderla; non è la via di per sé a esserlo. Dipende dalla tua decisione a fare il primo passo. E noi sappiamo bene che le persone che sono per noi d’ispirazione, sono proprio coloro che stanno percorrendo la loro strada: può essere costruire un computer, come per Steve Jobs, o sedere in un carcere per restituire la libertà al proprio popolo. Ci sono infinite vie. Questo ci porta a un altro tema centrale per me, al momento: c’è un enorme revival delle sostanze psichedeliche, tutti cercano di vendertele e tutti insistono che dovresti provarle, per la tua sanità mentale, ti facciamo una bella certificazione… e questa non è una via. Questo non è di ispirazione per me, è solo il capitalismo che rimette in scena la sua solita vecchia storia. La maggior parte dei libri che vengono pubblicati sull’argomento ripetono sempre le stesse cose, nel tentativo di vendere un prodotto, sono una strategia di marketing, per vendere idee, oppure i beni materiali che verranno prodotti in grande quantità. E questo per me non è d’ispirazione, proprio per niente. Certo, puoi fare un bel successo, ma non sei di alcuna ispirazione e per me, e quella non è una strada.
Posso, se mi consenti, condividere quale è la mia via, raccontarti cosa è di ispirazione per me, avendo chiarito che è un percorso soggettivo per ognuno.
C’è un comune denominatore tra le storie delle persone che ho incontrato e che sono per me fonte di ispirazione, e l’esperienza che io stessa ho fatto e faccio; ed è quel momento in cui ci si rende conto con stupore di aver intrapreso un sentiero. Quando accade quella sottile magia – per me non è un percorso lineare, a volte entro ed esco da varie strade, a volte sono proprio perduta e senza direzione – non è mai una cosa voluta, pensata, non è l’esito di un progetto o di uno schema, non è la mente che l’ha costruita. No. È tutto nel cuore. E la conoscenza del cuore ha tutto un altro movimento, è più lenta, richiede ascolto; mentre la mente è rumorosa il cuore è molto silenzioso, nel suo sussurrare. La mente è impaziente di rigurgitarti addosso tutto quello che sa, che di solito riguarda ciò che è già stato, ma il cuore è capace di fornire una guida semplice e allo stesso tempo profonda: «hai provato ad andare da quella parte?» dice. Credo sia questo il momento in cui bisogna trovare il coraggio di seguirlo, nelle cose semplici come in quelle che potenzialmente possono distruggerci la vita. Ma se il cuore non dà requie e noi gli diamo credito, la magia accade sul serio. Il punto è essere sé stessi, vivere la propria vita e lasciar accadere la propria magia, non accontentarsi di essere il prossimo prodotto che funziona. Essere se stessi è una cosa straordinaria ma, nella società che noi abitiamo, non è propriamente raccomandabile: risulti un pensatore eretico. Potrei restituirti tutta la casistica delle reazioni curiose che le persone hanno quando mi conoscono: ma questo non dice nulla di me, dice molto della persona che mi guarda e si sente in diritto di giudicarmi, perché non sa bene cosa farsene di una come me.
AC - Mi risuona la teoria della ghianda di Hillman: la ghianda già sa di essere una quercia e già è una quercia nell’essere una ghianda.
MG - Di nuovo, il tempo e lo spazio sono irrilevanti.
AC - Proprio a questo volevo arrivare: negli esperimenti che racconti emerge molto chiaramente il valore dell’attesa e del lasciare che le cose accadano, al contrario del modo in cui oggigiorno concepiamo il celebre metodo scientifico: non bisogna arrivare a dimostrare una teoria ma esplorare l’ignoto.
MG - Scusa se ti contraddico, ma questo è esattamente il metodo scientifico. Nella scienza sperimentale si parte da una null hypothesis, la base, e poi c’è un’ipotesi alternativa: parto testando l’ipotesi nulla, dal presupposto che non ci sia niente da vedere e se si trova qualcosa che non sia il nulla, allora questa ipotesi alternativa apre ad altri esperimenti e ricerche. Il primo lavoro che ho pubblicato partiva proprio da questo presupposto, e uno dei revisori ha pensato «questa di sicuro non ha trovato quello che stava cercando e quindi poi l’ha scritto come se lo avesse improvvisamente scoperto». Ma magari fossi così contorta e complicata! Invece no, veramente io mi sono chiesta «è possibile che ci sia altro?». Era il primo esperimento che ho fatto coi peperoncini, il basilico e il finocchio. Sappiamo che i vegetali possono comunicare con la luce, con la chimica e il contatto, ma è possibile che ci sia altro? Non stavo facendo alcun test specifico, non ne stavo facendo uno specifico sull’acustica o sull’elettromagnetismo, semplicemente mi chiedevo: ma è possibile che ci sia altro? Ma il revisore – che secondo me era un lui – non riusciva a comprendere che si potesse partire dall’ipotesi nulla e vedere cosa può emergere: nel mio caso c’era l’alternativa, un’alternativa che ha aperto la strada ad altre ipotesi e altri esperimenti con cui poi ho proseguito il lavoro.
La scienza non dovrebbe mai chiudere: non è controproducente il fatto che io non sapessi quale fosse la traccia, anzi è stato il quid che mi ha permesso poi di immaginare, in senso creativo, quali fossero le possibilità da poter esplorare. Ho perseguito il percorso riguardante le capacità acustiche delle piante perché le mie esperienze nelle esplorazioni sciamaniche e indigene mi davano la sensazione che ci dovesse essere qualcosa da scoprire in questa direzione, nel suono delle piante e nella loro capacità di ascolto, ma avrei potuto indagare l’aspetto elettrico e chissà quanti altri, che al momento non sappiamo nemmeno immaginare. Se ripetessi ora l’esperimento, con le conoscenze che abbiamo ora, sono certa che troverei qualcos’altro, perché secondo me è tutto molto più complicato e complesso, la vita ha un’eleganza molto più elaborata di A+B=C.

AC - Racconti molto spesso di questa resistenza dell’Accademia, che io ho letto, non so quanto propriamente, in senso anche politico e polemico. Coerentemente è emblematico anche il fatto di nominare Giordano Bruno all’inizio di una conferenza.
Al contrario, quando per esempio racconti dell’esperienza con Mato Ta Pejuta Wakan Najin [durante un rito di passaggio chiamato Hanbleche yapi, ricerca della visione] sottolinei l’episodio in cui uno degli anziani ti ha detto palesemente che “c’è un grande potere in te”; e, in generale, tutto il racconto del libro sembra suggerire che tu sia predestinata a parlare con e per le piante – e torniamo a Hillman e alla necessità di esprimere il proprio daimon. Come, queste due realtà, l’Accademia e il mondo spirituale in cui le piante ti parlano, rispondono l’una all’altra? Io credo che persino l’ostracismo intellettuale dell’Università possa diventare un valore e alimentare in qualche modo l’altra parte, ciò che ti spinge a fare ciò che fai, mi sbaglio?
MG - Se mi avessero detto, quindici anni fa, che ci sarebbe stato un momento in cui avrei perso la mia identità e tutto ciò per cui avevo lavorato, e così sarebbero accadute tutte le cose che poi si sono susseguite in questi anni, non ci avrei creduto assolutamente. E non avrei mai immaginato di avere nessuna delle mie molte crisi (come quella che apre il libro, per esempio). Il presupposto è che tu non veda e non sappia nulla, prima, se tu sapessi già dove stai andando, tenteresti di portarti dietro tutta la roba che non ti serve e che appartiene al passato: il nuovo ha bisogno di essere nuovo e non può essere contaminato da ciò che è vecchio. Certo, le cose utili restano, e risultano essere utili più tardi. Ciò di cui sto parlando è una resa assoluta al fatto che tu sei parte della vita e la vita ti possiede. Non c’è nulla che tu possa fare di sbagliato, non puoi fallire. E in una società come la nostra, incentrata sul progresso, sulla competizione, sull’essere nel posto giusto al momento giusto… per me la vita non funziona così.
Ogni volta che mi trovo in questa posizione, perché di una posizione si tratta, mi sento di dover lasciare andare tutto.
È come se fossi messa in un calderone – il calderone dell’orso, in modo molto letterale – cotta a puntino e ricreata.
In questo senso riesco a comprendere che possa sembrare una “predestinazione”: sono stata cucinata per questo. Ma non era qualcosa di programmato, o qualcosa che speravo accadesse; se me lo avessi chiesto ti avrei risposto «ma neanche per sogno!». Mi piaceva lavorare nell’ambiente marino, coi pesci, sulla barriera corallina, ero bella felice, ma poi la vita aveva altri piani per me.
E, ora come ora, a essere onesta, sono di nuovo esattamente a quel punto, in quella posizione. Mi è stato chiesto, negli ultimi due mesi, che sono stati piuttosto duri, di rinunciare alla mia identità. Proprio ora che il mondo sta appena cominciando a scoprire il mio lavoro. Ma la verità è che: la persona che ha fatto quel lavoro, la me del passato è già sparita, sta cuocendo nel calderone: sono in un luogo in cui non ho la più pallida idea di cosa farò dopo. Potrei andare a vendere gelati, e sarebbe bellissimo; o forse sto per inventare qualcosa che rivoluzionerà il mondo, chi lo sa? Ma nel luogo in cui sono ora, e in cui sono stata molte altre volte, ci sono vulnerabilità e abbandono: un’apertura all’incontro di qualsivoglia versione di te; perché quello sei tu, e non c’è nulla di cui spaventarsi, anche se è molto spaventoso. In questo momento ho paura, sono piena d’ansia, mi sono anche ammalata, io che non mi ammalo mai, sono arrivata al punto da ammalarmi in modo ridicolo: un giorno ho avuto la tachicardia, poi la settimana dopo ci sono stati i reni, e poi gli occhi. Come se tutti i miei organi fossero coinvolti nel processo di cottura, per poi diventare nuovi. Questo processo di morte e rinascita – come la fenice che rinasce dalle sue ceneri per tornare cenere e di nuovo rinascere – diventa inevitabilmente una presa di posizione politica. Io non ho nulla contro la società, ma nel modello sociale che abbiamo creato le persone si sentono più al sicuro a vivere una vita incompleta, che molto spesso non è affatto quella per cui sono venuti al mondo. Ci viene consegnata una scatola piena di idee, di giudizi, concetti e ci si aspetta che noi li sottoscriviamo. Vedo un parallelismo tra quello che mi sta succedendo sul piano personale e quello che vedo succedere a livello sociale globalmente, e vedo che al posto di offrire la nostra vulnerabilità, ci limitiamo a fare finta che non stia accadendo. E così perdiamo l’occasione di trasformare la società.
Al momento c’è questa enorme questione: il pianeta ci sta chiedendo un cambiamento. Dopo la fase di negazione, ora tutti ne parlano e nessuno fa nulla perché la realtà dei fatti è che noi non vogliamo morirci, in quel calderone. Ma la morte viene prima della morte intesa come estinzione della specie: ciò che crediamo di essere, di essere stati, non è più necessario. Togliti i vestiti, sdraiati per terra e lascia che il cambiamento ti investa totalmente, così ti trasformerai; dobbiamo prepararci a essere fenice. Ma ovviamente il momento non mi sembra ancora questo, forse dobbiamo alzare ancora un po’ la temperatura del disastro, forse non saremo mai pronti a dire questo “sì”, o forse lo diremo domani.

AC - Vorrei subito chiederti, rispetto a quello che hai appena detto, del progetto Resonant Earth ma permettimi prima di fare un passo indietro. Volevo raccontarti questa cosa: nel fine settimana sono stato in Valchiusella, in montagna, in un posto che si chiama La Biblioteca del Lupo, un luogo, raggiungibile solo tramite un sentiero di montagna, dove vengono raccolti libri sugli animali selvatici e sul selvaggio in generale, e che è inoltre sede di un gruppo che si occupa di una costante attività di antibracconaggio nella zona. La donna che gestisce questo posto ha scelto di lavorare sul bracconaggio e di combattere la caccia al lupo proprio perché un lupo ha mangiato una delle sue pecore predilette, Zira: è stato il sacrificio di questa pecora a innescare tutto.
Questo mi riporta a quello che dici anche tu nel libro, quando all’inizio racconti del “sacrificio” dei pesci che stavi studiando, come biologa marina, che avresti e hai dovuto uccidere, e che hanno in qualche modo dato l’abbrivo al tuo radicale cambiamento. E mi fa ripensare a un altro intervento di Stefano Mancuso in cui si parlava della disponibilitàdelle piante, a dare, a lasciarsi mangiare, anzi: più vengono mangiate e più si riproducono e crescono. Che senso ha, in questa crisi di cui parli, il sacrificio? E se fosse questo un insegnamento delle piante che potremmo e forse dovremmo applicare alla nostra visione del futuro, alla nostra possibilità di esser-ci nel futuro?
MG - Sin ora sono stata molto inconsapevole del momento in cui viene fatto il sacrificio: me ne rendo conto dopo, ma quando ci sono dentro ci combatto, «oh no, non può succedere a me! Non ho intenzione di perdere la mia vita». Credo che ci voglia molta autocoscienza per riconoscerlo nel momento in cui accade, la consapevolezza necessaria all’arrendevolezza, che rende il processo più semplice. Certo, si può anche scalciare e strillare, ma alla fine ci si trova comunque nello stesso posto; ci si può arrivare lottando o lasciarsi trasportare fluendo. In un certo senso, il sacrificio per noi è già stato compiuto ma noi ancora non lo vediamo, forse abbiamo bisogno di uno sguardo dall’alto per capirlo, ma tutte le specie, animali e piante, che abbiamo già perso… continuiamo a fare liste di specie in pericolo, ma quante ancora ne vogliamo sacrificare prima di arrenderci al cambiamento? «Oh, devo solo decidermi a cambiare» è una frase classica dei nostri tempi, nel nostro quotidiano. Vogliamo continuare a scalciare e strillare, o fare il primo passo sulla strada del cambiamento che, comunque, sta già accadendo, incurante di noi?
Una volta ero un’integralista che berciava in consinuazione dell’auspicabile sparizione dell’uomo dalla terra – il che, se ci pensi bene, è solo l’altra faccia dell’antropocentrismo, l’importante è stare al centro, nel bene o nel male – e una donna aborigena un giorno mi rispose in modo incredibilmente dolce: “la Terra piangerebbe la sparizione di qualsiasi sua specie, di una farfalla, un batterio, un piccolo mammifero, un serpente o l’uomo. Tutte sono una sua espressione e lei combatterà per ciascuna di esse”. Questo mi ha fatto capire due cose: innanzitutto, noi siamo qui, e questo ci dà il diritto di essere qui. E inoltre questo discorso scardina, in modo molto delicato e femminile, la prospettiva antropocentrica egocentrica a cui noi ancora ci aggrappiamo, per inserirci in un circolo della vita in cui siamo solo una delle meravigliose specie cresciute dal corpo della Terra.
Solo se guardiamo a noi stessi in questo modo abbiamo la possibilità di comprendere che queste specie sono letteralmente i nostri fratelli e sorelle, e la maggior parte di loro sono fratelli e sorelle maggiori, che con la loro esperienza possono insegnarci molto della vita. In così poche bellissime frasi, questa donna ha centrato il punto di molte delle nostre sterili conversazioni e dissertazioni filosofiche: questo è, così, semplice.
Il sacrificio sta già accadendo, il punto è quanto ci metteremo a riconoscerlo.
Per quel che riguarda il progetto Resonant Earth, che mi sta mettendo parecchio alla prova, si tratta dello stesso processo. Ho passato un lungo periodo in solitudine, al buio, ne sono uscita con una visione al riguardo e sono partita in quarta: ecco cosa devo fare, è tutto molto chiaro, ho il nome, ottimo. E poi, ogni volta che provavo a cominciare, non funzionava. Non era l’idea il problema, ma le cose non si mettevano al loro posto. Un inghippo con un collaboratore, qualcosa che non funzionava. Non ne andava dritta una. Nonostante io mi sia accanita negli ultimi due anni, non riuscivo proprio a partire. È stato solo in questi due mesi che mi sono resa conto che il problema è che stavo cercando di portare avanti quel progetto come la vecchia me, quella che ora si trova in quel processo di morte e rinascita: invece il progetto è stato affidato alla me di prima, ma è destinato alla me che deve ancora arrivare.
C’è una bellissima storia dei nativi americani, che parla di Topo che Salta, un topolino che lavora molto sodo, con tutti gli altri topolini, e a un certo punto sente un suono. Tutti gli dicono di non distrarsi e di continuare il suo lavoro, ma lui continua a sentirlo. All’inizio pensa di essere matto, perché nessun altro sembra sentirlo, ma poi decide di andare a esplorare. Comincia così il viaggio dell’eroe, vive molte avventure, incontra strani personaggi, è una storia bellissima e alla fine di questo viaggio scopre che esiste un luogo speciale, una montagna che si vede solo quando ci arrivi molto vicino; e lì sta la risposta, alla sua ricerca di quel suono.
Prima di arrivarci incontra un orso, un orso triste e schivo, che non lo degna di uno sguardo e il topo gli chiede «che cos’hai? Una creatura come te non dovrebbe essere così triste, di cosa hai bisogno per guarire?». L’orso, che continuava a evitare lo sguardo del suo interlocutore, risponde «a quanto pare avrei bisogno dell’occhio di un topo, ma dove potrei mai trovarlo?». Il topo comincia a tremare terrorizzato, ma poi pensa «per far ritornare alla vita una creatura così meravigliosa, io che sono solo un topo potrò pure sacrificare uno dei miei occhi», e nel momento in cui formula questo pensiero uno dei suoi occhi cade per terra ed entra nell’orso che ritorna alla vita, finalmente lo riconosce e per ringraziarlo di questo dono si offre di portarlo in prossimità della montagna. Arrivati vicini, l’orso dice al topo che deve proseguire solo, e così il topo, che a questo punto ha un occhio solo, incontra un altro animale enorme, il lupo, che soffre della stessa depressione e potrebbe essere guarito anch’egli proprio dall’occhio di un topo. E il topo ricomincia a tremare più forte di prima, perché ora ha un occhio solo, «ma il lupo è un animale così meraviglioso e io invece sono solo un piccolo topo, lui lo merita», pensa. Così, il secondo occhio del topo cade e il lupo torna alla vita, e si commuove per il gesto del piccolo topo che però ora è davvero spaventato perché non vede più nulla. Così il lupo si offre di proteggerlo e accompagnarlo alla base della montagna, dove lo lascia, dispiaciuto di non poter proseguire oltre. Il topolino si prepara a incontrare la morte, certo di non sopravvivere, solo e cieco, ma si rincuora di aver fatto del bene per gli altri, di aver donato tutto quello che aveva, e si rassegna al pensiero dell’aquila che verrà presto a prenderlo. A un certo punto sente che l’aquila lo afferra e si abbandona, pensa “sono morto”.
Ma qualcuno gli dice «apri gli occhi!» e lui pensa “ma io non ce li ho gli occhi, sono cieco e sono pure morto”.
Apri gli occhi.
All’inizio non riesce a vedere nulla, ma poi capisce che sta volando sulla cima della montagna, e all’inizio si sente sollevato del fatto che l’aquila non lo abbia ancora mangiato; finché non apre gli occhi e si rende conto che lui stesso si è trasformato nell’aquila.
Io sono in questo processo. Sono stata topolino, sono stata afferrata e mi preparo a morire – e davvero lo sento, credimi – ma quel grosso progetto che era stato affidato al topo, non può essere compiuto dal topo: sto aspettando che diventi l’aquila. Questo mi sta accadendo al momento, e non so come andrà.
L’arrendevolezza e la vulnerabilità sono la chiave. Il topolino preoccupato di non poter vedere mai più, si fida della vita e si fida della morte e arriva esattamente dove doveva arrivare, vede le cose da un’altra prospettiva, voleva vedere la montagna e capire di cosa si trattasse, ecco: arrivare alla montagna, capire la montagna è la rinascita. Questa storia è perfetta per descrivere la condizione del nostro Pianeta. Dobbiamo affrontare questa trasformazione, che ci piaccia o no. Ci sarà paura e dolore, è parte del processo, quindi dovremo imparare ad arrenderci.

AC - Ora ti farò una domanda provocatoria sul dovere di essere vegani. È chiaro che chiunque parli di argomenti che in qualche modo suggeriscono un’attenzione verso il rapporto tra esseri umani e altri animali o altri esseri viventi, per coerenza, ci sembra ovvio che debba essere vegano o quantomeno vegetariano. C’è stata per esempio una specie di polemica intorno al fatto che Donna Haraway fosse o meno vegana. Io credo che il discorso sia molto più complesso di così e che ci possano essere delle zone grigie dove una decisione così assolutistica risulta insensata.
MG - Quando sono andata a trovare “il mio orso”, durante il rito della visione, come parte della tradizione rituale, diciamo, c’è da fare un’offerta di carne, che va mangiata per essere restituita agli Spiriti. È soltanto un pezzettino, cosa avrei dovuto fare, dire «no scusate, non mangio la carne»?.
La mia guida è il mio corpo e la mia decisione viene dall’ascolto del mio corpo, mi chiedo sempre di cosa abbia bisogno il mio corpo in questo momento. Prima sono diventata vegetariana, molti anni fa, dopo l’episodio dei pesci cui accennavi prima, avevo bisogno di un compromesso: finché avessi sentito, non solo in testa, ma dentro di me, una disconnessione con questo Altro, la mancata coscienza del fatto che sto prendendo una vita e la sto mettendo nel mio corpo, sto prendendo una vita ma non la apprezzo pienamente; allora non avrei mangiato la carne di altri animali.
Mi sono sempre ripromessa che avrei mangiato carne se ne avessi sentita la necessità; non l’ho mai più sentita – e io sono italiana, quindi fino a diciotto anni ho mangiato tutte quelle cose buone: salumi, formaggio. Sai di che parlo.
È cominciata così, molto più tardi sono stata invitata a un esperimento: eliminare frumento e latticini, e mi sono resa conto che era piuttosto semplice, il mio corpo non era particolarmente interessato a queste cose, mi sono resa conto che già non le stavo mangiando da un bel po’. Stavo già ascoltando il sussurro del mio corpo e di nuovo, se dovessi sentire la necessità di mangiare formaggio, domani, lo farei. Lo farei con questa consapevolezza, la consapevolezza di quello che sto mangiando, non soltanto perché è lì nel piatto. Non giudico la scelta degli altri di mangiare quello che vogliono – certo, ci sono scelte migliori di altre, ma come possiamo saperlo? Siamo tutti diversi, una dieta vegana può andar bene per me ed essere tossica per te; di nuovo, perché sentire il bisogno di dire alla gente cosa deve fare? È di nuovo una questione politica: alcune scelte sono scelte politiche, ci impongono di mangiare o meno alcune cose per ragioni politiche. Ho scritto un capitolo per un libro sul frumento ed è incredibile, è presente ovunque, e se una piccola parte della popolazione mondiale smettesse di mangiare grano e frumento l’industria collasserebbe su se stessa. C’è un enorme interesse a mantenere il mercato, anche se la maggior parte del frumento che mangiamo non è digeribile.
Si tratta di essere flessibili, anche nelle scelte, basandole sull’ascolto. Senza identificarsi con le proprie scelte: oggi la mia dieta è questa, domani potrebbe cambiare, e quindi?

AC - Hai da lasciarci qualche consiglio; libri, opere d’arte, qualche novità in cui sarai convolta?
MG - C’è un documentario uscito l’anno scorso che si chiama Aware, che esplora la domanda della coscienza, dell’awareness. Sono molto legata ai due registi, abbiamo passato tanto tempo insieme ed è un bellissimo lavoro, molto delicato, proprio a livello visivo. E sto partecipando anche a un progetto, in corso d’opera, con due registi di Torino, Alessandro Bernard e Paolo Manera, legato a una foresta in Trentino: abbiamo fatto delle riprese e sarà un lavoro filosofico molto fine.
In più, recentemente ho letto questo libro: The Immortality Key, The secret history of the religion with no name, di Brian C. Muraresku. Lui è un avvocato che ha fatto studi umanistici e una lunga ricerca sulla storia delle religioni, e l’ipotesi è che sino a seicentocinquant’anni fa ci fosse una connessione diretta col divino, interrotta e intrappolata nell’idea che si abbia bisogno di un intermediario umano. Si legge come Dan Brown, ma è tutto vero.
AC - [ridacchiando con ironia] È strano, c’è la traccia di un pregiudizio dentro di me che mi dice che, per il senso comune, tu non dovresti leggere questi libri.
MG - Non dovrei leggere neanche questo, The dream of the Earth di Thomas Berry, che era un prete ma aveva capito tutto: soprattutto in questo momento è veramente profetico, questo libro contiene molti spunti di riflessione. Ha esattamente ciò su cui dovremmo ponderare tutti e tutte.
Pensiero
è professore associato di ricerca in Ecologia evolutiva alla Southern Cross University in Australia, dove dirige il Biological Intelligence Lab finanziato dalla Templeton World Charity Foundation. Ha scritto numerosi articoli scientifici sulla cognizione (percezione, processi di apprendimento, memoria e coscienza) nelle piante, collaborando con scienziati come Stefano Mancuso. Thus Spoke the Plant è un successo internazionale, già tradotto in molte lingue.
04-11-2022
04-11-2022