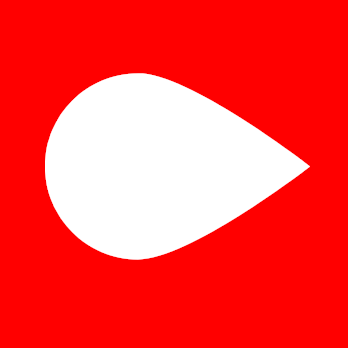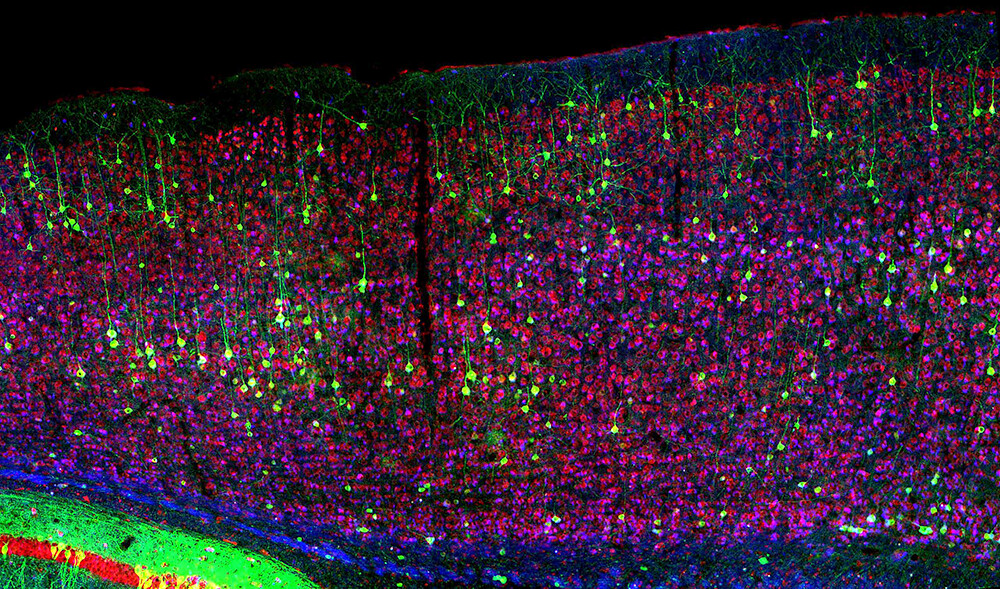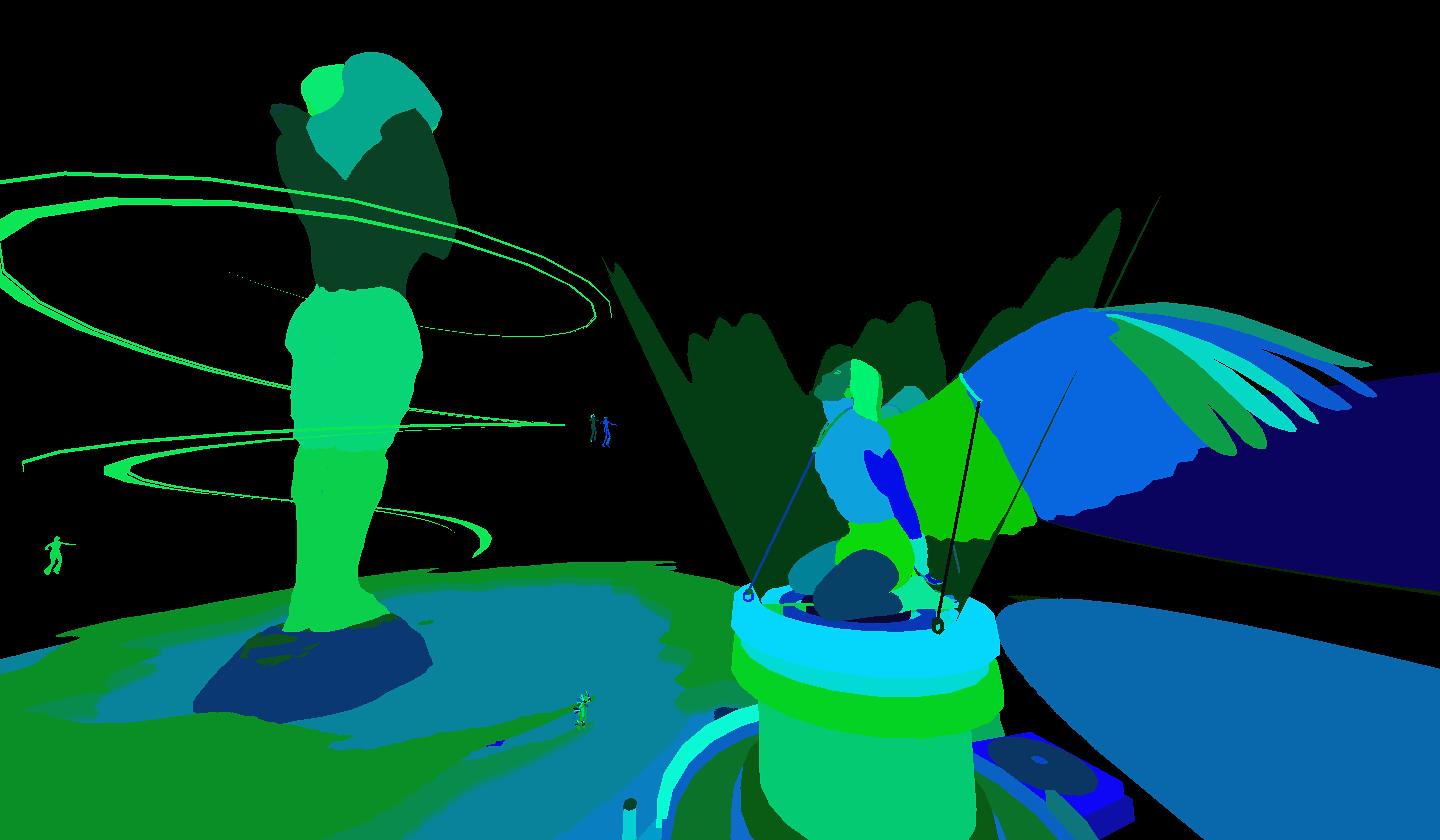Tra amici, senza sbirri
Tra ossessioni identitarie e il bisogno di convalidarsi in una generale conformità, una forma di salvezza è rappresentata da relazioni che stridono e tanta buona solitudine.
E in uno stemma il motto dello Stato mondiale: “Comunità, Identità, Stabilità”.
Aldous Huxley
Quando all’interno di una comunità si verifica una tragedia, tutti ne parlano per un po’: la copertura mediatica si sussegue febbrile e quasi sempre si concentra su un aspetto o una sequenza di aspetti trascinanti, i più spendibili da un punto di vista drammatico. Poi, in breve, man mano che la situazione ritrova un suo assetto, l’interesse per la vicenda scema e il bisogno di tornare alle vite precedenti si ripresenta, prepotentemente. La tragedia tutt’attorno torna velocemente a essere “astrazione”, come dice il giornalista Rambert al medico Rieux ne La peste, mentre la ricerca della propria felicità personale preme insistente. L’anno scorso, all’esordio della pandemia da coronavirus, la potenza con cui l’evento fece irruzione nella nostra esistenza fu tale da cancellare dai media qualsiasi altro argomento di discussione che non fosse non direttamente legato al COVID-19. Dopo oltre un anno, non sappiamo ancora quando e in che termini riusciremo a ristabilire – o torneremo a subire, secondo come la si pensi – una nuova normalità dopo un evento globale tanto sconvolgente; ma sappiamo quante siano state, fin dal primo momento, le persone convinte che la normalità, qualsiasi cosa significasse, dovesse prevalere sulla dimensione tragica. Persone che urlavano e tuttora urlano che è necessario lasciarsi alle spalle questo evento, nonostante i centomila morti solo in questo Paese. Un’intera città rasa al suolo. Non nel fragore di una bomba che scoppia, bensì nel silenzio di una RSA, di un ospedale lontano o di una morte in casa, nella solitudine di una quarantena.
Chi ha paura della solitudine
Nel silenzio sopraggiunge la morte, anche violenta. La valanga che a Rigopiano in Abruzzo, nel gennaio 2017, uccise 29 persone fra le quali il mio caro amico d’infanzia Dino Di Michelangelo, fu un evento silenzioso, immediato. L’avvertirono gli alberi, gli animali. Quasi un intero bosco fu smottato e trascinato con forza inaudita a valle. Dino e sua moglie rimasero uccisi sul colpo, all’impatto.
In Abruzzo, quell’inverno, aveva nevicato con una violenza che non si vedeva da tempo. Gli abitanti di quasi tutta la regione erano rimasti isolati per diverse settimane, le strade erano state per molti giorni impraticabili. Circa 200mila persone si erano ritrovate senza corrente elettrica e senza riscaldamento. Oltre ai morti di Rigopiano, le vittime furono diverse: nel teramano morirono assiderati un padre e un figlio, usciti a comprare le medicine e la benzina per alimentare il generatore in casa. Un tecnico speleologico del soccorso alpino, Andrea Pietrolungo, morì d’infarto a 39 anni, dopo che per circa un mese aveva prestato aiuto notte e giorno, instancabile, alle persone isolate e in difficoltà. Alla fine di quel tragico gennaio, il bilancio delle vittime in tutto l’Abruzzo, comprese le vittime di Rigopiano, fu di 43 persone.
Di Rigopiano, a parte le commemorazioni di rito, non si ricorda più nessuno. Di Andrea Pietrolungo, un eroe dei nostri tempi, le cronache riportarono il nome appena per un paio di giorni. Oggi parliamo tanto del personale sanitario candidato collettivamente al Nobel per la pace per il suo lavoro nelle prime fasi della pandemia. Chissà quanto ci vorrà per rimuoverne le imprese dalla nostra memoria, dopo che in qualche modo ne saremo usciti e le nostre felicità strettamente personali avranno ripreso – giustamente – il sopravvento su questa esperienza di condivisione forzata.
C’è un’unica categoria di persone che non potrà mai rimuovere le tragedie dalla propria mente: i sopravvissuti. I sopravvissuti sono coloro che si imprimono nella carne il trauma della violenza, senza morirne. Sono gli isolati e le isolate dal resto di una società che, al contrario loro, si tiene insieme rimuovendo. Coloro per i quali l’astrazione di cui parla Rambert ne La peste sarà per sempre più concreta che mai.
Per effetto della dimenticanza generale, i sopravvissuti alle tragedie e ai traumi vivono spesso la loro condizione in uno stato di sorda solitudine: si trovano soli a gestire la rabbia, il dolore, il senso di colpa. Le sopravvissute e i sopravvissuti sono tanti in questa società. Per lo più invisibili. Sono sopravvissuti i soldati, che tornano a casa dalle guerre disfatti dalla violenza vissuta ed esercitata su sé stessi e sugli altri, dissociati mentalmente dalla retorica patriottica con cui vengono a volte accolti, come racconta il bel romanzo di Ben Fountain È il tuo giorno, Billy Linn. Sono sopravvissute le prostitute: così si definiscono, quando riescono a liberarsi di una condizione che le vede vulnerabili e alla mercé di clienti e papponi, quindi a rischio di essere ammazzate, più e più volte al giorno. E sono sopravvissute le donne che subiscono violenza sessuale. Secondo l’Istat, circa il 90% delle donne in Italia che hanno subìto violenza sessuale non la denuncia. E quasi una donna su tre non ne parla con nessuno. La paura dell’isolamento e della loro vulnerabilità finisce per isolarle ancora di più e renderle ulteriormente vulnerabili.
La società tiene a distanza e rifiuta le persone che sono sopravvissute a esperienze traumatiche e violente. Da una parte, perché rimuove le proprie responsabilità nel non averle protette. Ma soprattutto, perché il dolore, il lutto e il senso di responsabilità stanno diventando sentimenti distonici rispetto a un’etica prevalente del benessere obbligatorio e dell’orgoglio di appartenenza, coerenti con il ciclo incessante della produzione e del consumo, con l’adesione sentimentale che ci viene richiesta alla società dei consumi. Poco esplicita nel sistema sociale, cionondimeno agente, con forza. Chi soffre, chi è infelice in questo sistema non è necessariamente dissidente, ma è sicuramente dissonante, come lo era il Selvaggio nel Mondo nuovo immaginato quasi un secolo fa da Aldous Huxley.
Viviamo in un culto implicito dell’apparenza felice. E questo forse spiega perché noi popolazioni occidentali, nell’ultimo anno, abbiamo fatto così tanta fatica a concepire, prima ancora che a rispettare, la necessità di fermarci, di accogliere nel nostro orizzonte mentale il rischio della malattia e quindi della cura paziente, che comporta anche l’accettazione dell’isolamento. Non riusciamo a non muoverci, e in questa difficoltà non c’è soltanto l’attaccamento al valore della libertà. C’è innanzitutto una grande paura di rimanere esclusi, cioè soli. La sindrome FOMO significa “Fear of missing out”, viene riferita solitamente alla paura di rimanere esclusi da esperienze gratificanti connesse alle reti virtuali, al senso di appartenenza ai circuiti sociali che oggi sono inestricabilmente virtuali anche quando incontriamo le persone dal vivo. Viviamo in una costante FOMO e persino la nostra reazione alla pandemia è stata, in buona parte, condizionata da questo.
La paura dell’esclusione e della solitudine tende a fare di noi – per quanto possiamo ritenerci trasgressivi – esseri tendenzialmente conformisti nei confronti del nostro gruppo di appartenenza e della sua etica. Tendiamo a conformarci nei comportamenti, nel linguaggio e nel pensiero stesso. Anche le divergenze di pensiero introducono, infatti, una dissonanza rispetto all’etica prevalente all’interno di un gruppo sociale. Negli anni ’80, la sociologa Elisabeth Noelle-Neumann coniò l’espressione “spirale del silenzio” per indicare la tendenza da parte delle persone a silenziarsi quando percepiscono che la loro opinione è diversa da quella della maggioranza. È un comportamento basato sulla cosiddetta “euristica del conformismo”, cioè la tendenza intuitiva a conformarsi al gruppo di appartenenza: sentirsi diversi dagli altri suscita il terrore di rimanere isolati.

Conformarsi alla maggioranza significa conformarsi alle strutture di potere esistenti all’interno di un gruppo umano; poiché è quasi sempre a partire da quelle che si formano le maggioranze e si costruiscono un’etica, un linguaggio e un pensiero prevalenti. “La questione è sapere chi comanda”, dice Humpty Dumpty ad Alice. È ciò che avviene nei gruppi umani più piccoli, come quelli familiari, dove “maggioranza” coincide spesso con le opinioni di padri, madri o del resto della famiglia, in ordine gerarchico. Ma è quanto avviene anche all’interno dei gruppi settari, dove la presenza di un capo carismatico coincide in modo pressoché assoluto con l’opinione della maggioranza. Trovarsi in minoranza o in disaccordo con le opinioni del leader quando si vive all’interno di un gruppo settario è una condizione profondamente dolorosa. Simile a quella di una vittima di manipolazioni che non riesca a fuggire dal suo aguzzino. O a quella di un figlio o figlia in conflitto con il padre o la madre all’interno di un nucleo o clan familiare di stampo tradizionale. Significa sapere che ascoltare i propri sentimenti, le proprie esigenze o la propria coscienza vorrà dire irrimediabilmente, prima o poi, esporsi a un certo grado di violenza, vendette e ritorsioni da parte del gruppo o figura di potere rispetto ai quali si vorrebbe affermare la propria indipendenza. In poche parole, trovarsi soli. Senza una rete di protezione che garantisca il nostro diritto di agire secondo coscienza e libertà.
Il potere del gruppo
Sulla carta, ogni cittadino della società democratica che viva circostanze simili dovrebbe in realtà poter godere di una simile rete di protezione. È questo, infatti, il senso di una democrazia moderna: garantire una rete sociale che consenta all’individuo “pari dignità sociale” in quanto individuo, non in virtù della sua appartenenza a famiglie, clan, sette o caste. “È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana (…)”, dice l’articolo 3 della Costituzione italiana. L’unità di misura della democrazia moderna è l’individuo, e come scrive lo storico Yuval H. Harari, il successo dello Stato mercantile moderno è dovuto proprio al fatto che ha consentito alle persone di “diventare individui”, slegando il loro destino dai diktat della famiglia e della comunità di appartenenza.
Eppure, esistono almeno due contraddizioni in come questa visione è stata interpretata storicamente. Da una parte, non a tutti è consentito di essere “individui”. Gli ostacoli cui si fa cenno nella Costituzione italiana sono ben lungi dall’essere stati rimossi. Chi subisce discriminazioni e oppressione – perché viene identificato come elemento di un gruppo sociale discriminato da chi detiene il potere – non ha il privilegio di poter vivere da individuo, e nei casi più estremi nemmeno da persona. Non viene giudicato per ciò che è in grado di dire, fare, esprimere come individuo, ma per le caratteristiche attribuite dal senso comune al gruppo in cui viene collocato: sia esso quello delle donne, dei neri, dei musulmani, dei gay, delle lesbiche, delle donne transessuali eccetera. Da un’altra parte, come Harari stesso segnala, la funzione emotiva delle famiglie e delle comunità non scompare, con gli Stati moderni, neanche quando gli individui hanno ormai ottenuto la propria indipendenza economica e giuridica dai loro nuclei di nascita. Ancora oggi, le famiglie e le comunità sono una fonte indispensabile del nostro senso di sicurezza. All’idea, infatti, di ritrovarci all’improvviso messi alla porta della nostra famiglia, o che a causa del nostro dissenso o divergenze di opinione potremmo finire stigmatizzati dal gruppo clanico di cui siamo parte, continuiamo a sentirci isolati e spaventati. Ci terrorizza la prospettiva di rimanere soli. Temiamo la valanga che potrebbe travolgerci e non riusciamo più a scorgere la bellezza di quella solitudine irredimibile che è il pensiero individuale, lasciato libero di farsi e di esprimersi.
Queste due contraddizioni si intrecciano fra loro e ne spalancano una terza. Chi, per caratteristiche fatte oggetto di oppressione o discriminazione, viene privato di una rete familiare o comunitaria di riferimento, tende a costituirne una o a inserirsi all’interno di una propria, con le persone che percepisce a sé simili. Ma anche all’interno di questa rete autocostituita possono verificarsi le dinamiche che si osservano in un qualsiasi altro gruppo sociale. Essere una persona transessuale è difficile dentro la propria famiglia, se la condizione che si vive non viene riconosciuta nella sua dignità; ma come racconta spesso la mia amica Neviana Calzolari, è difficile anche dentro la stessa comunità transessuale o LGBT, se il proprio modo unico di interpretare la transessualità, nel pensiero o nella pratica, non corrisponde alla concezione dominante o prevalente dentro quella comunità. La diversità che viene celebrata all’interno di molti gruppi che si costituiscono in contrasto con la cosiddetta “normatività” non è quella individuale, e non è quella di pensiero. È la diversità del gruppo rispetto alle caratteristiche del gruppo sociale dominante. Purtroppo, il gruppo sociale dominante non è l’unico gruppo in grado di esercitare un potere di controllo, repressione o isolamento nei confronti dell’individuo. Ciascuna persona, nel corso della propria vita, si ritrova ad appartenere, per caso o per scelta, a numerosi gruppi sociali. E all’interno di ciascuno di questi gruppi subisce, o esercita, qualche forma di potere.

Nella mia formazione socialista comunitarista mi è stato insegnato che “il sistema”, ovvero lo Stato, ci rende soli; che contrappone l'individuo alla comunità, alienando le persone fra loro. C’è del vero in questo; ma riguarda tutti i sistemi politici, non soltanto quelli contemporanei, non soltanto il sistema statale. Siamo sempre soli, quando ci troviamo dalla parte opposta rispetto al potere. Siamo soli quando esprimiamo dissenso, ma a ben vedere lo siamo anche quando non lo esprimiamo per paura di perdere la protezione della tribù. Silenziarsi significa vivere già una condizione di emarginazione, di dissonanza sentimentale rispetto alla “ginnastica d’obbedienza” generale. E tuttavia non esprimiamo, o esprimiamo in modo goffo e insicuro la nostra posizione, per paura di quella solitudine. Finché non succede qualcosa, una tragedia, un fatto eclatante, che traduce di fatto quella dissonanza in allontanamento, ostracismo o separazione. È accaduto a me che scrivo; ma è la storia di tante persone che si allontanano, nelle circostanze più diverse, da comunità settarie e opprimenti. Comunità che possono essere composte anche da persone a loro volta oppresse, o discriminate, da altre comunità. È questa, per esempio, la storia ben raccontata nella serie Netflix Unhortodox la cui protagonista, la giovanissima Esty, fugge dalla vita di sottomissione prevista per lei, come per tutte le donne, dalle regole della sua comunità ebraica chassidica di Williamsburg, New York, per ritrovarsi sola con la sua libertà a Berlino. La comunità chassidica di Brooklyn è una comunità di sopravvissuti all’Olocausto, vittime di una delle più feroci espressioni di odio razzista nella storia umana.
Alterità e identità
Quando per effetto di una dissonanza con il potere nella tua comunità di riferimento, succede che nella tua vita ti senti completamente, irrimediabilmente sola, è soltanto imbatterti nell’Altro che ti salva. Proprio come accade a Esty. L’Altro come lo descrive – e lo scrive, in maiuscolo – il filosofo Byung-chul Han: l’Altro che confligge con te. La negatività dell’Altro ti svela chi sei per contrasto: come la pellicola di una vecchia macchina fotografica. È un incontro che mette a nudo il dolore, accettandone la realtà senza censurarla. “L’amico è l’Altro”, dice il pensatore coreano. Anche quando è un estraneo, anche quando non ne conosci neanche il nome. Se non possiamo mai dirci completamente soli è perché nella società democratica, cioè relativamente libera almeno finché tale resterà, ciascuno è l’Altro. Lo incontriamo costantemente, anche quando non frequentiamo nessuno. Ogni nostro spazio d’azione è segnato dalla negoziazione, invisibile oppure esplicita, con gli spazi dell’Altro: di chi si palesa a noi sotto forma di impiegato delle poste, barista o vicino di casa. Una negoziazione linguistica, di significati, di doveri, diritti e possibilità. Molti dei più virtuosi comportamenti sociali democratici, da quelli più banali – pagare le tasse, non disperdere la spazzatura, non superare i limiti di velocità, rispettare le indicazioni sanitarie di fronte a un’emergenza – a quelli più straordinari, come sacrificare la propria vita per salvare altre vite durante una tragedia, sono rivolti al beneficio non solo né tanto nostro, ma di qualche Altro che non conosciamo. E che forse neanche vorremmo mai conoscere, ma che sappiamo a noi prossimo, volenti o nolenti, per il semplice fatto che condividiamo uno stesso tempo, e uno stesso spazio: lo spazio di una città, di un Paese, di un pianeta.
Questo tempo e questo spazio, in cui sono viva e lo sono anche gli altri che lo condividono con me, sono la mia identità: ciò che mi salva dalla solitudine e fa di me una persona fra le altre persone. Tempo e spazio, a mio parere, rappresentano l’unica forma sensata di identità che gli esseri umani davvero possiedono. Le uniche coordinate fisiche, e non sottomesse al logocentrismo, che condividiamo e per le quali siamo chiamati a fissare, e rispettare, regole di convivenza pacifica e mutuamente rispettosa. La condizione umana in carne e ossa. Tempo e spazio sono coordinate elastiche: si possono dilatare o restringere, possono abbracciare il presente, il passato e il futuro; il mio solo quartiere o la Terra tutta. Dipende da noi e dalle circostanze. Dipende dalla nostra necessità, oltre che capacità e opportunità, di pensare questi due assi portanti. E di liberarci così di qualsiasi altra categoria identitaria, ciascuna posticcia a modo suo; ciascuna una trappola che ci condanna alla solitudine, sia quando l’identità ci viene attribuita dagli altri, sia quando ce la attribuiamo noi stessi, barattando l’angoscia della solitudine con la rinuncia alla nostra individualità.
Una buona società è quella che salvaguarda, e per certi versi onora, l’Alterità dell’individuo nei confronti degli altri individui. Che ci garantisce una sponda di dignità e sostegno chiunque noi siamo, qualsiasi cosa pensiamo, qualsiasi cosa abbiamo fatto. Perché tutti possono averne bisogno e chiunque, in un certo momento della sua vita, può ritrovarsi completamente solo. Una società che protegge l’individuo dal pericolo dell’isolamento, permettendogli di trovarsi in posizione di dissenso, e di non sottomettere la sua dignità e indipendenza ai soprusi delle maggioranze e di chi possiede più potere, è una società che ha sviluppato anticorpi nei confronti del tribalismo e del settarismo, e della violenza che ne scaturisce, sia essa brutalità fisica o manipolazione sentimentale. Viceversa, se la società democratica non risponde all’individuo, qualcun altro potrà proporgli una soluzione antisociale ai suoi problemi. Lo vediamo ben rappresentato nella figura tragica del Joker di Todd Philips, incarnato da Joaquin Phoenix. Un personaggio disturbante perché disvela alcune verità radicali sul nostro vivere contemporaneo. Non a caso è stato immediatamente rimosso dalla coscienza collettiva. Il collega di Phoenix gli offre una pistola che a un certo punto, inevitabilmente, spara, ingenerando un nuovo tribalismo rivendicativo dei derelitti, antisociale e antipolitico, uguale e contrario a quello dei ricchi che si proteggono fra loro. È il tribalismo dei Wayne, dei Donald Trump; che, come Joker stesso, entrano se necessario nell’agone politico ed esercitano la leadership non per mediare punti di vista, non per rappresentare al meglio lo spazio e il tempo condivisi dagli individui nella società democratica, come dovrebbe aspirare a fare qualsiasi buon governante; ma come portavoce della violenza delle rispettive tribù.

Libertà è liberazione
“Quanto è bello alzarsi, uscire di casa e fare qualcosa. Siamo qui sulla Terra per andare in giro a cazzeggiare. Non date retta a chi dice altrimenti”. Così scrive Kurt Vonnegut in “Uomo senza patria”. È bello e se possiamo farlo è grazie ai pieni e ai vuoti della società democratica. Ai pieni che riguardano la garanzia di dignità per ciascun individuo; ai vuoti rappresentati da quegli spazi e quei tempi, fisici e mentali, che non sono ancora stati riempiti dal potere.
Il pensiero è uno di questi spazi. Oltre a consentirci di esprimerlo, la democrazia ci protegge dalla necessità di rendere trasparente al resto del mondo il nostro pensiero; ed è grazie a questo che possiamo “andare in giro a cazzeggiare” facendoci strane domande, innamorandoci dell’impiegata delle poste, trovando interlocutori improbabili nelle persone che incontriamo, nei libri, o negli amici o nei poeti di strada, o nei paesaggi dentro e fuori città. La democrazia è un sistema sociale relativamente libero nella misura in cui nessuno, fino in fondo, può sapere cosa stiamo pensando. Nemmeno facebook, che pure ce lo chiede con insistenza ogni minuto. E se ce lo chiede con così tanta insistenza è proprio perché, alla fin fine, non può saperlo. È stato il romanzo Il cerchio di Dave Eggers che mi ha convinta definitivamente di questo: i multimiliardari investimenti nella tecnologia digitale e del controllo sono, come tante dottrine del tempo presente, una forma di violenta reazione alla frustrazione di scoprirsi limitati; in questo caso il limite è dato dall’impossibilità per chi aspira a questo genere di potere, di possedere davvero il pensiero altrui. Possono canalizzarlo, manipolarlo, condizionarlo, distrarlo, possono mortificarlo e lo fanno spesso. Ma non possono leggerlo, a condizione che non siamo noi stessi a scriverglielo. È questo il motivo per cui ci istigano costantemente a farlo. Una delle più grandi utopie dei sistemi di potere è riuscire a penetrare nella mente umana fino al punto di renderne trasparenti tutti i meccanismi e pensieri. È un sogno irrealizzabile, come molti altri sogni di onnipotenza tecnologica scaturiti dalle minoranze dominanti della nostra specie: quanto più il potere cerca di occupare il territorio del nostro pensiero, attraverso i condizionamenti del linguaggio, sensoriali ed emotivi cui siamo costantemente sottoposti, tanto più la mente umana è in grado di aprirsi nuovi spazi, frutto dell’interazione con quegli stessi sistemi e linguaggi di potere.
La coscienza di questa nostra irriducibile potenzialità può divenire scaturigine di una ricerca di libertà indipendente dai poteri che cercano di controllarla, indirizzarla o sfruttarla a proprio vantaggio. La libertà è liberazione prima di tutto: tahrir in arabo, come le piazze del Cairo nel 2011. Come la liberazione delle donne dal giogo della sottomissione. Liberazione del pensiero dalla paura o dal dovere della compiacenza, pena la vendetta. “La libertà è la possibilità di dubitare, la possibilità di sbagliare, la possibilità di cercare, di sperimentare, di dire no a una qualsiasi autorità, letteraria artistica filosofica religiosa sociale, e anche politica”, scrive Ignazio Silone. È in quel “gesto molto più umano che ti dia il senso della violenza”. Nella rivolta come la intendeva Camus: “Mi rivolto, dunque siamo”. L’individualismo altruista; lo slancio dello schiavo che urlando “Spartaco sono io” riconosce la dignità dell’individuo nella comune condizione umana, e si contrappone in modo esplicito al conformismo che rende “l’amore e l’amicizia sottomessi a una dottrina” e dunque, al fondo, territorio di paura e insicurezza, piuttosto che di vicinanza e libertà.
Il potere, d’altro canto, si nutre del controllo. Racconta ancora Silone che quando a Mosca, una volta, rivolse il suo elogio della libertà a una dirigente della casa editrice di Stato sovietica, la compagna inorridita rispose “Ma questa è la controrivoluzione”. Sempre ne L’uomo in rivolta, Camus riflette a lungo sulle caratteristiche distopiche assunte dall’utopia comunista: su quella concezione di rivoluzione che fa “tacere il diritto fino a che non sia instaurata la giustizia”, e che per giungere al fine del trionfo della giustizia “passa attraverso la soppressione di ogni contraddizione”, distruggendo la libertà. E con essa, perciò, la possibile comunicazione. Secondo Camus, infatti, è solo nella rivolta, cioè nel dissenso, nel disaccordo, nel conflitto, nel dubbio e nell’esercizio della misura delle proprie libertà, che ciascun io può diventare un noi ed entrare in contatto con gli altri. “La complicità e la comunicazione scoperte nella rivolta si possono vivere solo attraverso il libero dialogo”.
Il bisogno di controllo, invece, comporta la necessità di uccidere la comunicazione. Nella società contemporanea iperdigitalizzata, intrappolata all’interno di uno spazio che non è né di vicinanza, né di lontananza, bensì di assenza di distanza quindi di iper-esposizione, il controllo avviene tramite la socializzazione. Portando, cioè, anche all’interno dell’ambiente digitale quei meccanismi di conformismo e terrore dell’isolamento che vediamo in azione nei confronti dei gruppi di appartenenza come la famiglia, il clan, la setta. Negli ecosistemi digitali, quell’incontro con l’Altro che presuppone negatività, alterità, conflitto e, in certe situazioni, rivolta, “cede il posto alla diversità dell’Uguale, del Diverso uguale.” Il mito della diversità, oggi così celebrato, è in realtà una mistificazione, perché “la diversità ammette solo differenze conformi al sistema (…). Con ciò protrae l’Uguale in modo più efficace dell’uniformità, perché l’apparente, palese molteplicità impedisce di riconoscere la violenza sistemica dell’Uguale. Molteplicità e scelta simulano una diversità che in realtà non esiste.”
È Byung-chul Han che parla, con il suo linguaggio filosofico complesso ma in grado di disvelare l’esperienza quotidiana di chiunque frequenti un social network. La diversità, che oggi è entrata di prepotenza nelle policy aziendali e nelle carte dei valori di tutte le multinazionali ultracapitaliste, nella società dello sciame digitale è solo una funzione dell’uguaglianza intesa come conformismo: di pensieri, linguaggio, atteggiamenti. Il “diverso uguale” è perfettamente incarnato non soltanto dal susseguirsi incessante degli stessi argomenti, linguaggi e meme sulle nostre timeline. Ma anche, in modo ancora più preoccupante, dalla proliferazione dei gruppi identitari (anche all’interno delle aziende, dove la creazione di questi gruppi viene fortemente incoraggiata, contrariamente alla sindacalizzazione). Sono quegli Uguali per eccellenza così impregnati dello “spirito di partito”, come lo chiamava Simone Weil, da arrivare a confondere verità e menzogna. “Si è giunti, in tutti i campi, a non pensare quasi più se non prendendo posizioni “per” oppure “contro” una opinione. In seguito si cercano argomenti a seconda dei casi a favore oppure contro. È esattamente la trasposizione dell’adesione a un partito.” Così si esprime Weil nel Manifesto per la soppressione dei partiti politici. Il settarismo partitico, che come lei stessa notava non è mai stato limitato alla sola organizzazione politica ma ha infestato l’arte, la letteratura, la scienza, è “la trasposizione dello spirito totalitario” e si sta affermando, giorno dopo giorno, sempre più come uno stile dominante di vita e di pensiero all’interno della nostra società, minando alla radice proprio il terreno di libertà “del nostro cazzeggiare”: cioè la possibilità di dire No alle definizioni identitarie e manipolatorie che vorrebbero statuire, attraverso il senso di appartenenza, una qualche forma di controllo sui nostri pensieri.
“L’intelligenza non può essere esercitata collettivamente. […] Perché un gruppo, quando vuole avere delle opinioni, tende inevitabilmente a imporle ai suoi membri. Presto o tardi gli individui si trovano ad essere, più o meno gravemente, impediti nella espressione di idee opposte a quelle del gruppo su vari problemi più o meno importanti, a me che non ne escano. Ma la rottura con un gruppo comporta sempre delle sofferenze, o almeno una sofferenza sentimentale”.
La tendenza cui assistiamo oggi conferma pienamente quanto individuato da Weil già ottant’anni fa. “O con me o contro di me” è ormai il metodo consolidato che accomuna sempre più partiti e gruppi identitari, e consiste nella polarizzazione, sempre più sorda, fra i sostenitori di un leader e/o di una certa ideologia e tutti gli altri: non necessariamente i detrattori, anche solo i semplici scettici o dubbiosi. All’interno del dibattito sulle discriminazioni – razziste, di genere eccetera – le posizioni ammesse sono soltanto due: ally, alleato della propria causa, oppure phobic, cioè razzista o all’occorrenza fascista. Come ben racconta lo scrittore Bret Easton Ellis nel suo pamphlet Bianco sollevare un dubbio, una contrarietà o semplicemente una posizione non totalmente aderente a quella attesa – nel suo caso, all’interno della comunità LGBT – comporta entrare subito in dissonanza con l’etica del gruppo, essere stigmatizzati come nemici. Per apparire alleati di una causa non bisogna porsi domande sul merito o sui metodi portati avanti dalla causa stessa. Porsi domande sul merito significa apparire immediatamente come suoi avversari. È una dinamica che chiunque abbia frequentato una sezione di partito o gruppo militante, così come un gruppo facebook di attiviste o attivisti, può aver riscontrato di persona. In altri tempi lo si sarebbe chiamato banalmente settarismo. La dannazione contro la quale si batterono non soltanto gli intellettuali come Weil ma anche le più dirompenti personalità del movimento operaio internazionale, da Rosa Luxemburg ad Antonio Gramsci. Oggi, con coordinate politiche, culturali e sociologiche molto diverse, quel settarismo mai sconfitto rivive in nuove generazioni e frange di attivisti, in gran parte estranei alla storia delle rivoluzioni socialiste.
Comunità, identità, stabilità
Chi prende la parola per denunciare gli esiti nefasti degli atteggiamenti neosettari – come è avvenuto significativamente allo stesso Easton Ellis, ma non di meno, mesi fa, a Noam Chomsky e altri firmatari della lettera “sulla giustizia e il libero dibattito” pubblicata su Harper’s Magazine, subisce condanne di status, ma raramente arriva a ricevere critiche puntuali nel merito. È una delle usanze più diffuse nell’attivismo contemporaneo quella di concentrare le proprie critiche sulle questioni identitarie: chi ha preso la parola non può aver ragione perché è troppo vecchio (boomer), troppo bianco, troppo privilegiato in quanto uomo, maschio e bianco, o in quanto donna bianca ricca, e così via. O perché automaticamente “di destra”. La discussione, quando avviene, non riguarda ciò che si dice, ma chi lo dice, e la misura del proprio privilegio. Eppure, come fa dire a una dei suoi personaggi la scrittrice Bernardine Evaristo nel bel romanzo Ragazza, donna, altro, “il privilegio è questione di contesto e di circostanze”. Nel contesto del discorso pubblico, tanto più quando esso si fa sui social media, la circostanza di esprimere un pensiero di minoranza rispetto a ciò che la maggioranza ritiene giusto non è mai privilegiata. Neanche quando a farlo è una persona che, in altri contesti, detiene una certa quota di potere.
In molte Università e accademie, soprattutto del mondo anglosassone ma non soltanto, sta diventando un’usanza pericolosamente frequente, da parte di alcuni collettivi di studenti, quella di impedire lo svolgimento di dibattiti e assemblee in cui siano presenti relatori o relatrici non considerati “alleati”. Qualcuno la chiama cancel culture e anche sull’opportunità o meno di questa definizione si è sollevato un paradossale dibattito polarizzante in cui gli alleati sostengono che sia un’invenzione dei privilegiati. Nei fatti, tuttavia, già da qualche anno nei campus americani e anglosassoni si è diffuso il costume di protestare contro conferenze o lezioni considerate disturbanti per i sentimenti delle persone vulnerabili, considerate tali in ragione dell’appartenenza a identità vulnerabili. Il fenomeno ha assunto proporzioni talmente grandi che molte istituzioni universitarie si sono sentite in dovere di chiarire la loro posizione in merito: nel 2016 è stato il caso, per esempio, dell’Università di Chicago, che si è risolta a inviare una lettera agli studenti per avvisarli esplicitamente che “nel rispetto della libertà accademica (…) non annulleremo la presenza di relatori invitati a parlare perché i loro argomenti sono ritenuti controversi”. Nell’ottobre 2019 è stato lo stesso Barack Obama a stigmatizzare la tendenza, da parte degli attivisti progressisti americani, a scambiare per impegno politico la “cancellazione” dai social media o da qualsiasi altra piattaforma di discussione di chi, per qualsivoglia motivo – a volte basta l’utilizzo di una parola che sfugge alla terminologia approvata dal gruppo – è ritenuto un ostacolo per gli interessi delle categorie più svantaggiate. Il paradosso è che molto spesso tali editti innescano un perverso meccanismo di competizione e mutua squalificazione fra gruppi identitari che si considerano rappresentanti delle cosiddette “identità vulnerabili”. Con risultati grotteschi, come gli scontri fra gruppi LGBT di diversa concezione, in guerra fra loro sul tema dei diritti, o l’attacco ormai sempre più frequente da parte dei collettivi cosiddetti queer nei confronti di femministe le cui posizioni su temi complessi e controversi quali prostituzione, maternità surrogata o identità di genere non riflettono gli interessi o le convinzioni ideologiche che vanno per la maggiore nel movimento arcobaleno. Attacchi ai quali, a loro volta, alcune realtà femministe rispondono spesso schierando una chiusura ideologica uguale e contraria, o riservando attacchi non meno virulenti a personalità considerate espressione dell’ideologia avversa.
La verità è che ogni argomento di discussione, ogni evento di cronaca, può diventare la scusa per innescare questo genere di scontri. Alla cui base, per paradossale che possa apparire, c’è la convinzione che il diritto a costruire la propria felicità si basi sul culto della propria “comunità, identità, stabilità”. Il motto dello Stato mondiale di Aldous Huxley. Le opinioni avverse ingenerano reazioni violente perché turbano la costruzione della nostra felicità. Sono il Selvaggio, giunto a minacciarci, che bisogna scacciare.
Basta entrare in Twitter per vedere ogni giorno, in ogni lingua, in ogni nazione, la “tempesta di merda” che le persone si lanciano addosso, molto spesso per questioni di merito evanescenti se non ridicole, colpendo e ferendo anche persone che nei propri contesti vivono situazioni di privilegio. La violenza di una shitstorm può diventare spaventosa, e può rappresentare anche situazioni di aggressione vera e propria. Le donne sono uno dei bersagli preferiti dei bulli da internet, ma non sfuggono neanche molti uomini. Possono essere giornaliste, cantanti, allenatori di calcio, scienziati, donne della politica. Non serve che faccia nomi, gli esempi sono quotidiani. La cronaca politica, sempre più scadente, produce tantissimi articoli a costo zero basati sulla popolarità delle vittime o dei perpetrator. Anche la politica nazionale spesso s’incaglia in questo tipo di dinamiche: due fronti, fra loro contrapposti, che utilizzano tutti gli strumenti della comunicazione non per entrare in dibattito sulle ragioni di divisione, bensì per squalificarsi reciprocamente. Basti rammentare le vicende ultime del Partito democratico italiano, o l’attacco violento che ogni giorno i seguaci di alcuni leader politici portano avanti, da anni ormai, a chiunque provi a mettere in dubbio anche solo con una domanda l’operato del loro leader. Ma altri partiti, in altri Paesi, non se la passano meglio. In occasione delle dimissioni di Jeremy Corbyn, e anche successivamente, il Labour britannico ha sofferto di numerose lacerazioni al suo interno, e di guerre settarie condotte in modo aspro e senza risparmiarsi veleni.
A nessun raggruppamento fedele a questo o all’altro leader sembra interessi ottenere una posizione che rispecchi la verità, quel valore spirituale che Weil ha descritto con lirismo, e che più prosaicamente potremmo far coincidere con il valore non negoziabile dell’onestà intellettuale: “La verità sono i pensieri che sorgono nello spirito di una creatura pensante desiderosa totalmente, esclusivamente della verità.” La cultura dello zittimento dell’avversario, spesso giustificata in chiave vittimista con un senso di minaccia e insicurezza che deriverebbero dalle opinioni altrui, è al contrario l’epitome del totalitarismo ossessivo e fanatico indicato da Weil: anche lo stalinismo si sentiva costantemente minacciato da qualsiasi interpretazione della realtà che non fosse di derivazione diretta del partito.
L’attitudine fanatica di fronte a qualsiasi argomento di discussione non si estende solo ai militanti dei gruppi organizzati. Sta diventando il metodo con il quale, giorno dopo giorno, le persone entrano fra loro in connessione, e non in comunicazione, attraverso i social media e non soltanto. Ancora una volta è Byung-chul Han che spiega le ragioni: quel marketing obbligatorio del benessere che non ammette dissonanze, e che nei gruppi umani comporta immediata identificazione ed emarginazione delle voci distoniche, gli individui stanno iniziando ad applicarlo anche su di sé: “L’io, in quanto imprenditore di se stesso, produce se stesso, è la performance di se stesso e si offre come merce”. Rifiuta, perciò, la negatività che il dialogo con l’Altro comporta, e ricerca, piuttosto, l’immediata, rassicurante positività di chi la pensa esattamente come noi, di chi convalida la nostra immagine: il nostro Uguale. Dice il filosofo: “Il ‘mi piace’ totale genera uno spazio della positività. A causa della sua negatività l’esperienza come irruzione dell’Altro interrompe l’auto-rispecchiamento immaginario: la positività che è propria del digitale riduce la possibilità di una simile esperienza. Perpetua l’Uguale.” La positività propria del digitale ci rende sempre più insofferenti alle divergenze, che ci fanno subito tremare la terra sotto i piedi. Mentre il rispecchiamento fra Uguali rassicura, ci fornisce un gruppo umano di riferimento che ci solleva dall’angoscia della solitudine e della distonia.
Lo spazio del pensiero
Ma l’insieme degli Uguali non ci aiuta a nutrire il nostro spazio di libertà. Aiuta invece la causa di chi è interessato al controllo, per esercitare il potere. L’insieme degli Uguali, infatti, solo apparentemente è orizzontale. Di fatto risponde sempre a una qualche gerarchia di potere. Capi carismatici, leader di partito, sponsor, guru, influencer digitali: gli Uguali finiscono sempre per diventare un’estensione, un rispecchiamento dell’Ego e del potere di questi. Poco importa se tale potere venga esercitato su sole quattro persone, qualche centinaio o due miliardi di utenti: rappresenta in ogni caso una forma di controllo nei confronti degli Uguali. Come aveva capito ancora una volta Simone Weil, un simile controllo si ottiene mistificando l’importanza dell’associazione, facendo combaciare libertà d’espressione e libertà, o addirittura necessità, di associazione.
È questo appiattimento sull’associazione che impedisce alle persone di coltivare lo spazio del proprio pensiero, dei dubbi e delle ricerche, o delle contrarietà, senza patire l’isolamento. Impedisce di accogliere la sofferenza, la debolezza senza cercare per esse rappresentanza identitaria, che è poi solo un modo per negarle, quando invece potremmo e dovremmo accoglierle, come parte della condizione umana. Quando mi è capitato di ammalarmi e di essere costretta dalle circostanze ad accogliere il dolore e la solitudine, di diventare paziente, ho capito che troppo a lungo avevo solo scacciato quel malessere e lo avevo seppellito nel conformismo; avevo scalpitato a lungo nel mio mondo interno, perché la fedeltà al mio gruppo mi imponeva di conformarmi anche a tutto ciò che ritenevo ingiusto o sbagliato, e avevo soffocato il mio pensiero. Alla fine il corpo ha deciso per me. Ha imposto il suo tempo e il suo spazio, affermando così radicalmente la mia identità. Ho accolto quella sofferenza, ché d’altra parte non aveva bussato, ma era entrata di violenza; finché le circostanze non sono cambiate, e ho cominciato a guarire. E poi è sopraggiunta la pandemia, a stravolgere ancora una volta tempo, spazio, la mia identità e quella di tutti.
Tendiamo ad appiattire l’identità sull’associazione. Io l’ho fatto per molto tempo. Invece, se “la libertà d’espressione totale, illimitata, di qualsiasi opinione, senza nessuna restrizione, né riserva, è un bisogno assoluto per l’intelligenza” (bisogno che non può in ogni caso esplicarsi senza limiti, specifica Weil) l’associazione per gli esseri umani “non è un bisogno, ma un espediente della vita pratica”. Ciò di cui abbiamo bisogno davvero, per vivere, è l’Altro. E di un sistema sociale – la società democratica – che ci permetta il più possibile di entrare in relazione autentica con l’Altro, preservando sempre l’individualità, la libera solitudine del nostro pensiero. La libertà di sentirsi e potersi dire infelici è indispensabile alla ricerca della felicità. La libertà di non essere d’accordo è indispensabile per la ricerca della concordanza. Per questo ci serve una società che rispetta l’individuo al punto che non gli chiede fedeltà in cambio di protezione. Non gli chiede concordanza in cambio di condivisione. Non gli chiede obbedienza, né compiacenza, né identificazione, per poter essere trattato con riguardo e rispettato nella sua dignità. È possibile una società del genere? Secondo Huxley, essa è in realtà l’unica forma di società possibile, l’unica che risponde al nostro essere non propriamente animali sociali, come vorrebbe la vulgata, bensì animali che si organizzano per stare insieme. “Per quanto si sforzino, gli uomini non possono creare un organismo sociale. Possono creare solamente un’organizzazione. Se tentano di creare un organismo, finiranno per mettere in piedi un dispotismo totalitario e basta.”
“I mercanti della politica fanno appello solo alla debolezza dei votanti, mai alla loro forza potenziale”, scriveva nel 1948. È quello che succede ancora oggi. È proprio questa debolezza autopercepita che spinge ancora oggi le persone a cercare rifugio nelle identità condivise, da quelle politiche a quelle sociali a quelle religiose eccetera. Per quanto ci si possa riempire la bocca di “empowerment”, la comunità avrà sempre una funzione di schiacciamento della persona, se accentua la pretesa di rappresentare un organismo – di valori, principi, ragioni di vita – rispetto alla saggezza di costituire un “espediente pratico”, una forma – o tante forme – dinamica e non pretenziosa di organizzazione. Forme che consentirebbero all’individuo di non doversi affiliare ad alcun gruppo per sentirsi protetto. Forme che ci permetterebbero di vivere “così bene, fra amici, senza sbirri”.