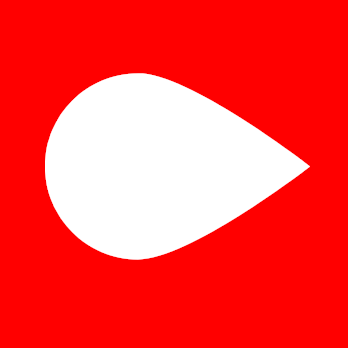Scusami, ma ci credo tanto (II)
Riflessioni sparse su Måneskin, rock’n’roll, Eurovision e capitale culturale. Atto secondo.
La prima parte dell'articolo è qui.
5.
Difficile spiegare ai loro nuovi fan da tutto il mondo che i Måneskin in Italia non erano affatto considerati delle vere rockstar ma un inconsistente fenomeno televisivo. Mettiamola così: nel panorama musicale di questi anni erano del tutto isolati e presi ben poco sul serio da quanti pensano di capirsene di musica.
Certo, non erano proprio sconosciuti: facevano concerti con discreto successo, pubblicavano album – il primo album in studio fu Il ballo della vita, del 2018, e arrivò al primo posto della classifica italiana - e vincevano dischi di platino, li vedevi in televisione (quasi più che in radio, dove passavano relativamente di rado, anche nelle radio ufficialmente ‘rock’ tipo Virgin Radio e Radio Freccia). Andarono per qualche mese a Londra a fare full immersion musicale, come giovani patrizi della Roma imperiale che vanno a studiare filosofia a Atene: da decenni non usciva più nulla di decisivo ma per imparare era ancora the place to be. Venivano bene nelle interviste – giovani, carini, entusiasti, disinvolti – e in fotografia. Avevano un loro pubblico ma era un pubblico che non faceva testo e non era facile da collocare: nella chiacchiera musicale online si faceva notare sempre, in senso spregiativo, che ai loro concerti ci andavano le ragazzine e le loro madri e non certo per la musica.
Il giudizio sui Måneskin era largamente condiviso dai competenti: una band anacronistica, con un sound vecchio ispirato a cliché rock da tempo scaduti e quindi impossibile da prendere sul serio. Convinti, contro la storia e l’esperienza che la musica in qualche modo progredisse (eppure che ‘the arts are not progressive’ lo sapeva già William Hazlitt all’inizio del XIX secolo) si premiava e commentava la musica ‘nuova’ e di ‘ricerca’ e ovviamente non contaminata dal contatto con la televisione. Alcuni ammettevano la presenza scenica di Damiano, altri la estendevano all’intera band, e qualcuno si spingeva fino a dire che non suonavano poi malissimo – ma nulla di più. Il peccato originale della partecipazione a un talent non veniva redento, come pure era sospetta la visibile determinazione a avere successo; secondo una diffusa definizione, i Måneskin non erano rocker ma cosplayer rock, probabilmente messi assieme da produttori senza scrupoli o da qualche algoritmo (in campo musicale il complottismo era di moda quando non era ancora mainstream). Del resto il rock era morto, no?
Inutile dire che, per quanto riguarda il rock, l’impressione era proprio quella. Nel 2015 un migliaio di musicisti italiani si erano riuniti a Cesena sotto la guida di Fabio Zaffagnini e avevano suonato in un campo di calcio Learn to fly dei Foo Fighters. L’idea era di convincere la banda di Dave Grohl, già batterista dei Nirvana e ultimo link vivente a quella tradizione che sembrava essersi interrotta bruscamente nel 1994, a venire a suonare a Cesena (e già il fatto che nel 2015 il rock fosse incarnato dai dignitosi ma non precisamente epocali Foo Fighters era abbastanza triste). Ci riuscirono e poi andarono pure in tour come Rockin’ 1000.
Però il video metteva una certa tristezza: bello e commovente, specie se ti rendevi conto che tutti quei cantanti, chitarristi, bassisti e batteristi non erano famosi. Facevano parte di una scena molto marginale, fatta di tribute band che suonavano in piccoli locali e festival di provincia e che non andavano in televisione o passavano in radio, tanti piccoli modesti canali Youtube con pochi amici iscritti. Tanta dedizione, tanta tradizione, a volte tanto talento – per nulla. Certo, uno poteva immaginare una cosa simile con un centinaio di rapper italiani che tentavano di cantare in coro Keep ya head up di Tupac Shakur e il risultato sarebbe stato decisamente comico (o, nel caso fossero riusciti davvero a andare a tempo, terribile come un raduno nazista a Norimberga) ma questo non cambiava la situazione. Guardando una performance dei Rockin’ 1000 veniva in mente Cabaret: sarà stato pure ‘the happiest corpse I’ve ever seen’ ma un cadavere comunque.
La scena musicale italiana di questi ultimi anni si divide grosso modo in tre principali correnti: un mondo pop mainstream dominato da vecchie glorie – alcune grandi e amate, altre giovani e brave, altre non particolarmente amate né brave ma che ci si è abituati a vedere in giro, oltre alla folla solitaria dei concorrenti di Amici di Maria De Filippi (il 1984 dei talent) – e che ha il suo centro attorno al Festival di Sanremo; una scena indie pop che copre artisti molto diversi, da Brunori Sas allo Stato Sociale, da Calcutta ai The Giornalisti, da Levante a Ultimo, da Diodato a Coez, e recupera sia la tradizione appunto pop che soprattutto, aggiornandola, quella cantautorale, fortissima in Italia e che ha la sua vetrina nobile nel Premio Tenco; infine e soprattutto una sempre più popolare scena rap e trap che riempie gli stadi e domina le classifiche, oltre che, apparentemente, l’immaginario giovanile (mi comunicano l’esistenza di una scena reggaeton italiana ma faccio finta di non aver sentito).
A parte il Festival di Sanremo – non per niente ispiratore dell’Eurovision – l’altra istituzione importante, almeno a livello di legittimazione del campo musicale, è il Concerto del Primo Maggio, nominalmente organizzato dai sindacati. Al di fuori di queste istituzioni e dei talent – di cui il più importante e rispettabile, fino a un certo punto, è X Factor – la musica, soprattutto quella nuova, non ha grandi spazi televisivi, mentre certi canali un tempo utili – tipo i centri sociali, i circoli Arci e le Feste dell’Unità – svaniscono poco a poco. Qui, chiaro, non semplifico con l'accetta ma direttamente con la motosega: ma se il punto non è la qualità (qualsiasi cosa si intenda con qualità) ma il consenso critico e la visibilità mediatica credo la ricostruzione regga.

Il rock italiano era decisamente marginale, più di quanto fosse mai stato. In fondo un certo numero delle vecchie star più amate venivano da lì – Vasco Rossi, Ligabue, Gianna Nannini, Piero Pelù – e ormai erano praticamente tesori nazionali amati da tutti, specie il primo. Vasco era stato il protagonista di un episodio ormai leggendario, cioè il penultimo posto al Festival di Sanremo del 1983 con una delle canzoni più popolari degli ultimi decenni, Vado al massimo – un classico caso di disconnect fra volontà popolare e mondo reale. Non per niente, intervistati prima dell’ultimo Festival, i Måneskin, alla domanda su cosa avrebbero fatto se fossero arrivati ultimi, avevano risposto ‘Diventeremo leggenda'. Io, in compenso, ricordo ancora mio padre in poltrona, davanti alla televisione, che commentava con pochissima simpatia l’esibizione di Vasco: ‘O l’è bombardòu’, è drogato.
Non era sempre stato così. Avevamo iniziato presto, col concorso di rock’n’roll al Vigorelli nel 1957. Tre anni dopo Adriano Celentano proprio come rocker sarebbe apparso nella Dolce Vita di Federico Fellini. Il futuro pareva brillante e nel corso degli anni centinaia di band si sarebbero formate, affermate, sciolte e dimenticate nel corso di un’impari lotta contro la tradizione melodica italiana, destinata alla fine a vincere.
Non era solo il fatto che l’Italia era l’Opera. L’Italia era anche il Madrigale e il Canto Gregoriano. L’Italia era il paese che aveva inventato la notazione musicale moderna. Per secoli l’Europa aveva cantato in italiano. L’Italia era la melodia, che si era ovviamente modellata sulla lingua italiana, sulle sue parole lunghe e piene di vocali. La lingua italiana era, in breve, un grosso ostacolo alla ricezione del rock nella nostra tradizione musicale, cioè un sound che si appoggiava all’inglese. Chiaro, si potevano trovare delle soluzioni che spesso funzionavano ma appunto, la lingua era un problema da risolvere e non un aiuto.
Non per niente un grande momento creativo del rock italiano era stata la stagione del prog - Banco di Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi, Area e persino i primi Pooh e Battiato – cioè uno stile musicale più adatto alla nostra sintassi. Alla lunga, la melodia e la canzone s’erano dimostrate più forti. Lo si vede anche da quale musica italiana è apprezzata nel mondo: In ginocchio da te di Gianni Morandi che si sente a sorpresa in una delle scene più importanti di Parasite; Se bastasse una canzone di Eros Ramazzotti nella commedia francese C’est la vie; il musical spagnolo sulle canzoni di Raffaella Carrà; i Grammys vinti a ripetizione da Laura Pausini – e non parliamo della tradizione pseudo-operistica di Pavarotti, Bocelli e i Volo. La nostra musica all’estero è quella, punto.
Le vecchie rockstar ancora popolari erano quelle che s’erano adattate al meglio alla tradizione italiana e proprio per questo si trattava di un rock tutt’altro che duro o estremo, una via italiana al rock che a molti puristi non piaceva. Quante volte s’è discusso se Vasco Rossi fosse rock o meno? E cosa s’era deciso, alla fine?
Metti poi che a un certo punto il rock era andato in crisi anche in America e Gran Bretagna; aveva, come l’Urss secondo Berlinguer, ‘perso la sua spinta propulsiva’. I Monster of Rock padani cessarono; il pubblico ai grandi concerti delle star straniere invecchiava come le star stesse; le chitarre elettriche non parevano più indispensabili. Figurarsi se poteva prosperare la scena rock italiana, che pure negli anni Novanta e primi Duemila era parsa, con un certo ottimismo, vitale e promettente.
Col senno di poi, l’ultimo colpo di coda del nostro rock fu la partecipazione degli Afterhours di Manuel Agnelli al Festival di Sanremo del 2009.
Gli Afterhours erano al centro di una scena indie rock di una certa distinzione, la generazione dei Marlene Kuntz e dei Verdena, e erano quel che si dice un gruppo di successo, sia pure all’interno di una pozzanghera in rapida evaporazione. Avevano venduto, erano stati in tour in tutta Europa e negli Stati Uniti, erano, grosso modo, ‘famosi’ – e ovviamente il pubblico di Sanremo non li aveva mai sentiti nominare.
La partecipazione a quel festival era parte di una specie di piano per portare l’indie rock italiano all’attenzione del pubblico. Il loro pezzo – Il paese è reale – era deliberatamente anti-sanremese, politico, nervoso, spiacevole, proprio per rimarcare la differenza col pubblico generalista, e era parte di una compilation dallo stesso titolo dove insieme agli Afterhours c’erano Marta sui tubi, il Teatro degli Orrori, gli Zen Circus e altri.
Ovviamente la partecipazione a Sanremo fu un fiasco. Fra l’altro in un anno che rappresentò una specie di nadir del festival, con il primo posto di un insignificante cantante che aveva vinto a Amici e il secondo posto di Povia con Luca era gay. L’unica canzone che si ricorda (più o meno) di quell’anno è Sincerità di Arisa. L’autentico paese reale, almeno in campo musicale, aveva vinto in maniera schiacciante e era reale nel senso più triste del termine.
L’insuccesso fu tale che quando, nel 2016, Agnelli divenne giudice di X Factor, nello slot assegnato alla ‘competenza’, al posto del sempre più instabile Morgan e del sempre meno interessato Elio, le reazioni si divisero fra ‘ma chi l’ha mai visto questo?’ e ‘ecco, si è venduto anche lui’.
(Posso azzardare un giudizio volante sugli Afterhours? Una band e un cantante che avevano tutto – talento, carisma, intelligenza, disciplina – eccetto non tanto il genio, che non è legittimo chiedere a nessuno, quanto un minimo di volgarità necessaria a piacere, una band ultimamente sconfitta dalla sua stessa serietà e intransigenza – però una nobile sconfitta, da samurai votati a un damyo che sanno perdente).
L’unica carta rimasta ancora in mano al rock italiano era una carta in un certo senso controproducente, specie in un caso come quello dei Måneskin, e cioè una massiccia presenza nel discorso musicale mediatico di gente cresciuta durante l’egemonia del rock e che perciò con idee fin troppo chiare sull’argomento di cosa sia rock o meno, e una cosa assolutamente certa per gli aspiranti gatekeeper del genere era che i Måneskin non lo erano. Qualsiasi gruppo che aspirasse visibilmente al successo, per esempio partecipando a un talent, era automaticamente squalificato come indegno di meritarselo, specie se poi piaceva alle persone sbagliate, tipo le ragazzine e le loro madri – well, it’s Celine Dion all over again…
Quindi, perversamente, dato per scontato che il vero rock era quello di una volta e che quello di oggi era condannato, anche con le migliori intenzioni, alla marginalità o al sarcasmo, finiva che i giornalisti musicali Boomer o Gen X finivano per essere più aperti e disponibili verso sound che dovevano in realtà essergli estranei, tipo rap e trap. Non foss’altro che per lavoro dovevano inseguire le ‘novità’ e ovviamente ‘the kids are alright’.
Per esempio, ecco Rolling Stone che nel 2020 festeggia il suo ritorno in edicola con un numero speciale interamente dedicato al trapper lombardo Sfera Ebbasta, al secolo Gionata Boschetti di Ciny (Cinisello Balsamo). Per quanto possa sembrare estraneo alla storia della rivista è chiaro che Rolling Stone deve occuparsene nel suo ruolo di ‘testimone dei fenomeni del tempo presente, raccontati mentre sono in divenire’ e per questo è necessario occuparsi di Sfera, ‘un personaggio larger than life da questo punto di vista, un artista in procinto di tentare la scalata all’impensabile: portare il rap italiano negli Stati Uniti’. E’ pure un bravo ragazzo, un po’ come Lorenzo Licitra: ‘Sfera è un ragazzo la cui ambizione infinita è pareggiata soltanto dalla devozione e dall’impegno infusi nel lavoro’. E’ un personaggio controverso? ‘Da quando la musica e l’arte sono diventate materie per educande? Nessun fenomeno pop di rilievo è mai nato tra i favori dell’establishment, e mai lo sarà’. E dobbiamo tutti augurarci che riesca a portare la musica italiana negli Stati Uniti: ‘se farà centro sarà un bene per tutti’.
E difatti Sfera Ebbasta (cui Ivan Carozzi ha dedicato un bel romanzo-saggio, L’età della tigre) va al Concerto del Primo Maggio, come ci vanno Fedez, Achille Lauro, Ghali, Mahmood – ma ovviamente non i Måneskin, considerati come non all’altezza. In effetti, come ci viene autorevolmente ricordato, nessun fenomeno pop di rilievo è mai nato tra i favori dell’establishment e mai lo sarà…
Questa contrapposizione fra Sfera Ebbasta e i Måneskin è una mia paturnia, sia chiaro: per quel che ne so potrebbero ammirarsi a vicenda e magari essere pure amici, come pure non mi sorprenderebbe scoprire che il Boschetti di persona è simpaticissimo (da dire che il giovanotto, molto correttamente, ammette di non voler parlare di politica o simili perché non ne sa nulla, non gli interessa e non vuole far finta di avere chissà quali opinioni da comunicare). Il discorso ha a che fare con i meccanismi di legittimazione della chiacchiera musicale nell’Italia d’oggi e con il fatto che a me musicalmente la trap evoca le alterazioni visive aurali che mi precedono l’emicrania.

Tipo, paragonate questi due testi, usciti quasi contemporaneamente nel novembre del 2020.
I Måneskin lanciano quel che si potrebbe definire un manifesto generazionale, Vent’anni, un tentativo abbastanza scoperto di porsi come portavoce di una generazione che dovrebbe essere la loro ma che con tutta probabilità non si riconosce nella paura di ‘lasciare al mondo soltanto denaro’.
Io c'ho vent'anni
Perciò non ti stupire se dal niente faccio drammi
Ho paura di lasciare al mondo soltanto denaro
Che il mio nome scompaia tra quelli di tutti gli altri
Ma c'ho solo vent'anni
E già chiedo perdono per gli sbagli che ho commesso
Ma la strada è più dura quando stai puntando al cielo
Quindi scegli le cose che son davvero importanti
Scegli amore o diamanti, demoni o santi
Sfera Ebbasta, invece, ci fa entrare nella vita di una vera star e dei problemi comuni alle vere star, cioè problemi con cui è facile identificarsi, tipo che la gente è falsa e lui invece è sincero e il successo non l’ha cambiato e vuole ancora bene alla mamma (che non è come le ‘modelle’ che lo circondano e di cui non gli frega nulla, davvero).
Tutto cambia nulla resta uguale
tranne l'amore di tua madre
la gente cambia e il cash ti cambia
più ne fai e più non ti basta
cambia il modo in cui la guardo mentre sta con lui
penso sono troppo cambiato o forse è meglio lui
cambio vestiti, cambio appartamento
non ho mai cambiato quello che c'è dentro
e non lo vedi che sono sincero?
che son triste, piange pure il cielo?
Insomma, dopo anni di canzoni su cash, marche e bitches è arrivato il momento della contemplazione pensosa, debitamente notata dalla critica più avvertita e sensibile. Mentre quando Damiano alza la voce per dirci che ha vent’anni e perciò ‘non mi frega un cazzo, c’ho zero da dimostrarvi’ la critica scuote tristemente la testa di fronte a tanta presunzione. L’ambizione dei Måneskin di riattivare le ‘pretese utopico-prometeiche’ del rock (un progetto per il quale erano così pateticamente inadeguati, specie dal punto di vista musicale, che non c’era veramente niente da dire) si registrava come pura vanteria adolescenziale. Non c’era dubbio su chi fosse il vero portavoce della sua generazione.
Poi, nel 2021, il film cambia completamente.
Dell’Eurovision abbiamo detto; torniamo un attimo a Sanremo.
Dal nadir del 2009 il festival era cambiato. Specie negli ultimi anni e sotto la direzione di quel che pareva un classico Medioman dello spettacolo come Amadeus c’era stato un rinnovamento e ringiovanimento musicale discreto ma sensibile. Il festival s’era riorientato sull’indie pop italiano, cioè su un tipo di musica corrente e che aveva degli appassionati, dei reali ascoltatori con una qualche interesse per la musica come non l’avevano i piccoli fan di Amici o il classico pubblico generalista.
La cosa, nell’edizione del 2021, a mutamento ormai consolidato, ha una serie di conseguenze: gli ascolti sono minori perché il pubblico più anziano non riconosce nessuno, si confonde e cambia canale; in compenso la risonanza social è molto maggiore (anche per il desiderio di parlare di qualcos’altro dopo un anno di pandemia) e l’età media del pubblico è nettamente calata; inoltre, per quanto discutibile la cosa possa essere, il livello musicale pare proprio migliorato.
Ora, quando gruppi rock o comunque in qualche modo alternativi decidono di correre il rischio di partecipare a Sanremo ci sono due strategie diverse, nel tono come nei risultati: puoi fare il simpatico e buttarla in ridere, il pubblico di solito gradisce, ed è così che gruppi come Elio e le Storie Tese, lo Stato Sociale e i Pinguini Nucleari Tattici non vincono ma finiscono secondi o terzi e vendono un botto; oppure vai lì con l’aria di spiegare la musica ai bifolchi – Afterhours, Marlene Kuntz, Bluvertigo, Subsonica, La Crus etc – e il risultato è generalmente umiliante (poi ci sono i Dhamm, l’unica band più o meno metal a aver partecipato a Sanremo, nel 1996, e vi lascio immaginare com’è andata). Il caso dell’unico pezzo rock a aver vinto il Festival, Mistero di Enrico Ruggeri nel 1993, conferma la regola: una specie di premio alla carriera a un artista amato, con un pezzo che più amichevole e sanremese non potrebbe essere rimanendo almeno un po’ rock.
I Måneskin non fanno nulla del genere: vanno con un pezzo bello aggressivo, Zitti e buoni, che va contro ogni regola festivaliera e vincono nell’anno in cui secondo i bookmaker avrebbe dovuto vincere un bel pezzo indie-pop estivo come Musica leggerissima di Colapesce e Di Martino (carinissimo, sia chiaro) che infatti va fortissimo in radio e era favorita dai bookmaker.
Non fanno i simpatici, non fanno i sanremesi, non tentano di spiegare la musica ai bifolchi. Approfittano dell’abbassamento di età del pubblico; la loro estetica gender fluid e LGBT approfitta dello sdoganamento operato da Amadeus grazie a Achille Lauro, ospite per tutte le puntate (per inciso: il tono di Achille Lauro è quello della vittima sacrificale predestinata e l’ideale estetico è Mina; quelli di Damiano sono il ‘cazzo guardi?’ e Freddie Mercury, per non dire Robert Plant: per il resto siamo lì). Vincono grazie a quello stesso televoto che li aveva puniti a X Factor e contro una potenza di fuoco social enorme come quella di Fedez, loro ex giudice nel talent e marito di Chiara Ferragani, la più popolare influencer d’Italia, che arriva secondo in coppia con la vincitrice di X Factor Francesca Michielin.
Vincono Sanremo e vanno all’Eurovision Song Contest proprio l’anno in cui questo esplode e vincono anche quello. E tutte le due volte con una canzone rock in contesti da sempre ostili al rock.
Chiamala fortuna…

6.
A questo punto la stampa musicale si rende conto che sui Måneskin bisogna impegnarsi un po’ di più, anche solo per dissipare la sgradevole sensazione di aver puntato sul cavallo sbagliato. Molti confermano il loro disinteresse, per non dire condanna: come è possibile prendere sul serio un gruppo che è stato a X Factor e poi ha vinto Sanremo e l’Eurovision, carrozzoni trash che ‘nessuno’, cioè nessuno che conta, nessuno di ‘noi’, ha mai preso sul serio? Ma l’avete vista che gente va ai loro concerti? Ma di cosa stiamo parlando?
Certi episodi poi confermano il topos ‘false rock’ dei Måneskin: per esempio l’aver accettato di modificare il testo di Zitti e buoni togliendo ‘coglioni’ e ‘cazzo’ (che poi però rimettono trionfalmente nell’esibizione finale dopo la vittoria). Peggio ancora quando, come abbiamo ricordato, nella conferenza stampa subito dopo la trasmissione Damiano è accusato di essersi fatto una pista di coca in diretta mondiale e lui non solo nega con forza ma accetta anche di farsi un test anti-droga che lo scagiona. Le ironie si sprecano, tipo che Damiano è l’unica rockstar che va a letto presto con la tisana (Crozza). Il rock era un’altra cosa e il fatto che un giovane ambizioso non avesse accettato di vedersi distruggere la carriera per rimanere fedele a un ideale trasgressivo da tempo scaduto giusto per compiacere vecchi Boomer e Gen X ancora fedeli, malgrado la mezz’età, la calvizie incipiente e il posto fisso, al mito del ‘live fast, die young’, possibilmente a spese altrui. La loro validazione musicale passa per l’adesione a totem di gruppo che non hanno molto a che fare con la musica.
(Già che ci siamo, il nexus rock’n’roll-autodistruzione è un’eredità scomoda: inutile condannare o riverire il passato; così era e ci resta della gran bella musica malgrado il costo umano non indifferente, per il quale vi rimando alla pagina Wikipedia ‘List of pop musicians who died of drug overdose’; ma non è il proprio il caso di riviverlo oggi, che gli anni Settanta sono lontani, anni in cui nel mio quartiere operaio si camminava su tappeti di siringhe e personalmente non lo rimpiango affatto)..
Altri decidono di rendersi un po’ meno ridicoli e cercano di rivalutare con più attenzione pregi e difetti della band romana.
Il miglior articolo di rivalutazione, secondo me, è quello di Simone Stefanini su Rockit.it, significativamente intitolato ‘I Måneskin hanno fatto anche cose buone’.
Stefanini non ha cambiato idea sulla loro musica, che ritiene mediocre, e sulle loro ambizioni, che gli paiono assurde, ma sente che è il caso di considerare anche i loro punti di forza, oltre che a fare i conti con i suoi stessi pregiudizi (tipo il fatto che Damiano fosse troppo figo e gli ricordasse quelli che gli portavano via le ragazze al liceo): insomma, decide di fare seriamente il critico.
Innanzitutto, ammette, sono una vera band: non solo sono perfettamente assemblati ma sono, come dire, autentici. L’incastro dei caratteri è così preciso – la Star, l’Intelligente, il casinaro e l’Introverso – da far sospettare una creazione a tavolino, una cosa tipo One Direction o BTS. Invece i Måneskin si sono formati da soli, a partire dallo stesso liceo in un quartiere romano bene ma non benissimo, Monteverde. Il nucleo originale è formato da Victoria e Thomas; alla ricerca di un frontman sufficientemente carismatico si imbattono in Damiano che è lì a portata di mano e sicuramente ci tiene. Col senno di poi sembra una scelta assolutamente ovvia, anche se il primo tentativo non funziona perché, secondo Victoria, è ancora ‘una schiappa’. Forse motivato dal rifiuto, Damiano ci si mette d’impegno e migliora: al secondo tentativo viene accettato. Ethan, il batterista, viene da fuori, trovato con annuncio su Facebook: ‘Cercasi un batterista per un gruppo indie rock/ new wave con varie cover e inediti già arrangiati”, autodefinizione che muterà in corso d’opera. Suonano nelle feste di liceo, fanno busking in Via del Corso, fanno cover anche inusuali (Raggamuffin, di Selah Sue – che scopro grazie a loro) e provano a scrivere canzoni loro, soprattutto in inglese, finché non arriva X Factor e si passa di livello.
Le influenze, dicono, sono varie: Victoria più pop, Thomas rock, Damiano soul e Ethan jazz. Non mi azzardo a fare illazioni sulle dinamiche interne della band, a parte il fatto che nelle interviste specie televisive danno tutta l’impressione di stare bene assieme.
Superficialmente viene spontaneo identificare il frontman come il vero capo di una band, specie se si tratta di uno come Damiano David, così platealmente per non dire insistentemente carismatico e dotato di mezzi vocali non comuni e una presenza scenica fin da subito formidabile e che per di più scrive la gran parte dei testi: di frontman del genere ne appare giusto uno a decennio. Difatti sono frequenti i commenti che già ai tempi di X Factor prevedono una sua carriera da solista o suggeriscono che il vero nome del gruppo dovrebbe essere la ‘Damiano David Band’. Visto che pare pure capace di rappare sospetto gli sia stato più volte proposto di lasciare la band e cimentarsi nel genere di moda e commercialmente sicuro. Però a parte l’ormai evidente compattezza della band sul palco (ne hanno fatto di strada da quella notte al Forum di Assago) non pare impossibile che Damiano si senta più a suo agio all’interno di un gruppo e che la fiducia negli altri membri della band gli sia indispensabile per rendere al meglio, una dinamica tutt’altro che nuova nella storia del rock, specie se vogliamo prendere alla lettera la dialettica aggressività/fragilità dei testi scritti da lui stesso.
Comunque, il punto fondamentale è la scelta strategica di essere una band, una scelta un tempo ovvia per chi volesse far musica ma molto meno oggi. Una band rock, quindi non una boyband e non la band di supporto a un solista ma una vera e propria band. Ce ne sono ancora, chiaro, ma la band rock nella sua versione più standard, voce, chitarra, basso e batteria, il cristallo di massa che ha caratterizzato il periodo di egemonia anche più dei vari sound che si sono succeduti all’interno del genere, è oggi una scelta e non una necessità, anzi.
Anche, aggiungo io, una band italiana con testi in italiano, e abbiamo già visto come l’italiano non sia ospitale per il loro sound preferito; ma bisogna notare che le classifiche di vendita italiane oggi sono molto più italiane che ai miei tempi.
Stefanini poi riconosce che i Måneskin sanno suonare. ‘È il vecchio rock, si divertono, lo suonano in maniera per loro dignitosa se non buona, buon per loro’. Altri giudizi sono più generosi ma questa è una buona base di partenza. Nell’era dell’autotune i quattro romani hanno voluto puntare molto sulla vecchia pratica di suonare veri strumenti musicali (‘strumenti effettivi’ dice Thomas) e pure di vantarsene e metterla in evidenza, con album volutamente underproduced e un suono relativamente sporco, tanto da rendere le loro performance live molto simili alle registrazioni in studio. Una pratica, quella di suonare di persona e insieme molto a lungo, che funziona anche da forma di disciplina, un determinato tentativo di crescere assieme in una fase in cui è ancora tutto in gioco (davvero, non si dà il giusto peso al fatto che sono proprio molto, molto giovani), una disciplina che poi si rafforza con la pratica della musica dal vivo. Si dice che non hanno fatto abbastanza gavetta (e già che si usi questo termine militare è tutto un programma e non un buon programma) e questo è assurdo: erano indubbiamente acerbi quando arrivarono a X Factor ma da allora di gavetta ne hanno fatto parecchia, davanti a tutti, iniziando con concerti di sole cover, fino a raggiungere una sicurezza invidiabile e una tecnica ampiamente sufficiente e forse qualcosa più che sufficiente.
Essere una band sul serio e sul serio imparare a suonare: ottima base di partenza.
Il punto successivo di Stefanini sembra banale ma è fondamentale: piacciono. Piacciono e non solo in Italia. Sanremo e l’Eurovision saranno pure baracconi che non hanno niente a che fare con la vera musica ma intanto hanno un pubblico: i Måneskin sono usciti fuori dai loro confini e sono stati scoperti da milioni di persone che, a quanto pare, hanno deciso di apprezzarli. E poi il fatto è che avevano un pubblico anche prima, quando chi se ne capiva di musica non li considerava proprio, e proprio perché piacevano alle persone sbagliate, ragazzine e mamme e altri deplorevoli. Stefanini ammette (finalmente!) che questi gusti sono legittimi, che ‘ognuno è libero di esprimere il proprio dissenso, ma questi volano lo stesso e al momento sembrano inarrestabili, quindi tanto vale capire cosa possiamo trarre di buono dal loro successo’.
Questo diventa un punto importante: può esserci un rilancio del rock? Teniamo basse le aspettative e diciamo che c’è un’opportunità. L’han detto tutti, da Manuel Agnelli a Morgan a Gino Castaldo, l’anziano decano del giornalismo musicale italiano, il quale lo dice nel modo più interessante: ‘Stilisticamente sono un’anomalia assoluta’ e insiste sulla loro inaspettata eccezionalità. ‘Sono imparagonabili a chiunque, in questo momento’ e possono creare emulazione. Hanno ridato vita a un genere morto. Castaldo sembra uno che abbia visto la luce, malgrado fossero in giro ormai da qualche anno. Come abbiamo fatto a non accorgercene?
Morto sì, ma fino a un certo punto. La sua mitologia è stata potentissima fino a non molto tempo fa. Molte rockstar sono ancora in giro e attive, i dischi sono ancora tutti a disposizione. Sì, i giovani sentono altro ma forse – forse – non è un dominio così solido come sembra, quello di rap e trap; ci sono migliaia di adolescenti che ogni anno riscoprono i Led Zeppelin e i Clash e persino i CCCP e tutti quei cliché che avevano finito per nausearci a loro paiono nuovi e molti di loro rispondono. E poi è un fatto, rispetto al passato i gusti sono molto più eclettici, si possono ascoltare cose molto diverse senza darci troppa importanza. Certo, il fatto che apparentemente tutti sembrassero ascoltare altro era scoraggiante ma ora, ecco, qualcuno, qualcuno che gli esperti non prendevano davvero sul serio, ha avuto successo proprio con quel sound ‘vecchio’ e poco innovativo, che non fa ricerca, che non apre nuove strade, che vuole solo essere se stesso e allora vuol dire che c’è speranza.
Infine Stefanini arriva a un punto davvero fondamentale: i Måneskin hanno colto il punto del rock, quello che sembrava tutti avessero dimenticato. Il rock è in realtà un musical e Stefanini, che li ha più volte definiti non rocker ma cosplayer rock ora decide che sì, aveva perfettamente ragione, solo che non era un difetto ma un pregio, che il punto era tutto lì, ‘it’s all a circus, kid’, come dicono nel musical ‘Chicago’: ‘Give ‘em the old razzle dazzle’ è l’unica vera regola da seguire e quindi anche il fatto di essere fighi, nota Stefanini, ci sta perché ‘le regole del rock sono specifiche e non le inventiamo certo noi e se sei figo è tanto meglio’.
Ci sarebbe parecchio altro da dire (lungo, eh?) ma un ultimo punto. I Måneskin sono un cover band eccezionale: riescono a rendere proprie canzoni molto diverse e anche superiori a quelle che sono (per il momento) in grado di scrivere: vedi la loro versione di Amandoti dei grandi geni solitari, i CCCP/CSI di Giovanni Lindo Ferretti, che, miracolosamente, diventa una canzone dei Måneskin, dopo essere stata anche di Gianna Nannini: di fronte a queste eccellenze i ragazzi reggono benissim.
E la loro scelta di brani è molto eclettica, senza alcuna traccia di purismo. Per esempio ci sono ben due cover di Caparezza. Caparezza?
Dicevamo prima che le canzoni politiche sono politicamente irrilevanti. Non solo, ma generalmente non sono nemmeno belle canzoni, dato che difficilmente riescono a sfuggire al classico dilemma: se sono politiche e intelligenti non sono divertenti; se sono politiche e divertenti non sono intelligenti; se sono divertenti e intelligenti non sono politiche. Quest’ultimo caso non è sempre vero, ci sono rari esempi di canzoni e artisti che riescono a creare canzoni politiche, intelligenti e divertenti. Uno di questi è Caparezza,
I Måneskin rifanno due suoi pezzi storici: Vieni a ballare in Puglia (versione simpatica ma più curiosa che riuscita: loro sono agli inizi e la canzone è molto geo-specifica) e Vengo dalla Luna, che invece è perfetta. La rispettano filologicamente e ne confermano lo spirito ma di nuovo la fanno propria. Lo sfogo anti-razzista del rapper pugliese, un classico caso di esasperazione di sinistra, di chi è troppo educato per sopportare ancora e allora decide di sbroccare, diventa in bocca a Damiano il trash talking di un fighter MMA e funziona altrettanto bene. E Caparezza è un artista inequivocabilmente di ‘sinistra’.
I Måneskin non fanno musica politica, hanno proprio un sound poco adatto secondo me, se non attraverso cover come questa. Il tono generale di individualismo libertario è in pratica l’opzione di default delle tematiche rock e quindi lo diamo per scontato. L’unica posizione esplicita è quella, piuttosto evidente, su temi come i diritti LGBT e il femminismo, in entrambi i casi più attraverso i comportamenti – il gioco sulle identità sessuali e il rapporto dei maschi del gruppo con la bassista Victoria, quella che potremmo definire come la fondatrice del gruppo che non solo è ma, ed è cruciale, anche sembra su un piano di perfetta parità con gli altri – e certe estemporanee dichiarazioni woke di Damiano come quella, finita sulle prime pagine, relative del figlio di Grillo, fermamente a favore delle donne vittime di stupro e del fatto che una denuncia è valida anche se è dichiarata dopo otto giorni, cosa che gli è costata una prevedibile piccola shitstorm online, oppure esplicitare la sua chiara percezione del privilegio maschile di cui gode.
(Opinione politica strettamente personale un po’ alla belin di cane: posizioni del genere, così gay-friendly e filo-femministe dieci anni fa mi avrebbero infastidito un po’, non perché le disapprovi, figuriamoci, ma perché mi sarebbero parse un po’ troppo ovvie e piacione, le cose che un maschio woke DEVE dire, mentre altri problemi sociali più complessi e materiali si possono bellamente ignorare; ma ora, in un’era sovranista e politicizzata fino alle mutande, in cui certi assunti che parevano pacifici e acquisti non lo sono più, simili posizioni sono più coraggiose e sincere di un tempo perché non sono più gratis, comportano qualche rischio).
Ok, a questo punto abbiamo descritto che tipo di band siano i Måneskin, schizzato il contesto in cui s’è trovata a operare e accennato al loro percorso fino all’attuale successo planetario (toh, eccoli sul New York Times).
E’ il momento di affrontare il punto centrale: ne valgono la pena?
Beh, sì.
7.
Proprio un secolo fa il filosofo Alain (Emile-August Chartier) si chiedeva quanto sarebbe stato apprezzato l’Amleto se fosse apparso oggi, un’opera nuova senza la sua fama secolare, i commenti e le interpretazioni e il posto nel canone. ‘In ogni tempo i critici hanno applicato le loro regole e si sono sempre sbagliati’, perché applicano l’idea all’opera e non trovano l’idea nell’opera. Questa perciò si difende come può, grazie a supporti criticamente indifendibili: ‘l’autorità di un capocomico, un attore amato, un uditorio, dei marinai ai quali ogni spettacolo piace, ecco i primi supporti delle opere mediocri, e anche delle più belle’. In verità non si sa mai davvero cosa pensare di un’opera nuova, si sta attenti a quel che ne pensano gli altri, che a loro volta stanno attenti a quel che pensiamo noi, si finisce per pensare che oggi non c’è più niente di buono, che tutto il bello è alle nostre spalle. ‘Lo spirito umano si forma non col fare delle scelte, ma accettando; non a decidere se un’opera è bella ma a riflettere sull’opera bella. Così, a dispetto dei luoghi comuni troppo evidenti, c’è dell’imprudenza nel voler giudicare da sé. È l’Umanità che pensa’.
In un certo senso l’equivalente moderno dei supporti di Alain – un cantante carismatico che piace alle ragazzine, festival televisivi molto seguiti, sistemi di voto bizantini, il desiderio di risentire un vecchio sound di cui si ha nostalgia – ha permesso che la musica dei Måneskin riuscisse finalmente a raggiungere un suo pubblico e essere goduta per se stessa, fuori dai luoghi comuni critici e dal desiderio di stare col più forte. Un vasto pubblico mondiale li ha scoperti all’improvviso e in questi giorni sta decidendo che le canzoni sono belle perché non s’è fatto in tempo a spiegargli che non lo sono. In pratica l’equivalente musicale di Elena Ferrante. Un mucchio di gente, specie all’estero ma adesso anche in Italia, sembra convinta di aver trovato delle rockstar come non se vedevano da anni. Nei commenti sotto i video su Youtube si leggono cose quasi imbarazzanti: cioè, erano così fantastiche queste canzoni e non ce n’eravamo accorti? Cosa avevamo nelle orecchie?
Come diceva Edgar Allan Poe ‘pochi sono i casi in cui la popolarità va considerata come l’unica, giusta misura del merito; uno di quei pochi, a mio parere, è rappresentato dalle canzoni’ (On Song-writing, 1849). Detto in un altro modo, una canzone non diventa memorabile perché bella, ma diventa bella perché memorabile, e i metodi con cui ciò succede sono diversi. Tutto (come se fosse facile…) sta a arrivare al pubblico saltando oltre le barriere invisibili del gusto e della distinzione.
Poi, chiaro, si può andare ancor più dritti al punto e concordare col poeta inglese E.A. Housman, quello di The Shropshire Lad, per cui la grande poesia è quella che quando la leggi ti senti rizzare i peli sulla nuca. Una reazione quindi perfettamente emotiva, che in un modo o nell’altro supera qualsiasi discorso critico.
Detta così, la critica musicale, che fra l’altro non è esatto il mio campo, diventa abbastanza impossibile. Metti poi che io provo a scrivere romanzi e quali che siano i risultati mi sono fatto proprio per questo un’idea abbastanza precisa dei meccanismi e delle strutture che li fanno funzionare o fallire, mentre non ho mai nemmeno provato a cantare o suonare uno strumento. Sono un puro ascoltatore.
Vabbé.
In questi anni negli Stati Uniti sono venuti fuori i Greta Van Fleet, una band molto giovane e molto, molto classica. In breve, rifanno i Led Zeppelin e li rifanno molto, molto bene. Cioè anche loro, come i Måneskin, si appoggiano a un suono vecchio e superato ma in musica e in arte non si supera mai nulla, dovremmo saperlo. Le canzoni dei Greta Van Fleet sono relativamente semplici e si rifanno a un modello molto preciso ma non sono un pastiche o una parodia perché sono convinte in maniera persino commovente: se il loro sound non può per definizione essere classico è almeno neoclassico e per un seguace di Mario Praz come me questo è un complimento.
Se fossimo a Parigi i Greta Van Fleet sarebbero il Pantheon e i Måneskin l’Opéra Garnier. Non solo le influenze degli italiani sono più diverse, anche fuori dai confini del rock – funk, raggamuffin, rap (che in fondo, per quanto mi dispiaccia ammetterlo, non è il nemico ma una delle tante armi a disposizione oggi) – ma tendono a accavallarsi entro ogni singola canzone. I brani dei Måneskin cercano di mettere in mostra tutte le possibilità vocali di Damiano e a cambiare spesso di passo mentre i tre musicisti devono ognuno avere il suo momento, specie gli assoli zeppeliniani di Thomas Raggi (brevi, perché non è più tempo di guitar heroes, ma ci sono e belli evidenti). Sono canzoni molto farcite, che potrebbero sfasciarsi a ogni istante, specie dal vivo, ma non lo fanno, perché la capacità di scrittura dei Måneskin procede di pari passo con la sempre maggior sicurezza di performer. E’ facile dire che le canzoni del Teatro d’ira vol.1, l’album uscito subito dopo Sanremo, sono più solide e riuscite di quelle del Ballo della vita. Giovani come sono le possibilità di crescita sono enormi. Un giorno potrebbero riuscire a scrivere canzoni semplicissime.
A me, devo proprio dirlo, i capelli sulla nuca si rizzano, almeno ogni tanto. Impressione soggettiva e tutto sommato, al di là del dato tecnico, che altra opinione posso avere?, ma che sempre più persone stanno provando in questi giorni, anche vecchi rocker fulminati sulla via di Damasco che si chiedono ‘come ho fatto a non accorgermene prima? A cosa stavo pensando?’.
Piuttosto, le parole, che almeno in teoria dovrei conoscere meglio. Ora non c’è bisogno di scomodare di nuovo Poe per dire che le parole di una canzone devono servire alla canzone e non hanno necessariamente vita autonoma. Le parole di una canzone devono funzionare in performance, e spesse muoiono lette sulla pagina. Di Bob Dylan e De André sono rari, e che le canzoni siano la poesia del nostro tempo è un luogo comune amato da chi non legge mai poesia. Al massimo si può dire che certe cose che un tempo faceva la poesia ora si fanno con le canzone, per il banale motivo che la poesia non vuole più farle.
‘Si canticchiano le canzoni, non si recitano i testi. Si cambiano le parole alla musica, e non la musica alle parole. La canzone è una forma d’arte in sé, sua è la sua perfezione’, come ci ricorda Laura Pugno.
Le parole delle canzoni sono ‘poesia d’occasione’ nel senso pieno del termine. Vi ricordate l’impressione che fece Amanda Gorman il giorno dell’inaugurazione di Joe Biden, in un contesto istituzionale e potenzialmente pericoloso, e questa giovane e attraente poeta nel suo cappottino giallo parve la voce della speranza? E il giorno dopo leggere The Hill We Climb solo per ritrovarvi una prosastica lezione di educazione civica, che ci stava pure ma la poesia è un’altra cosa? Eppure, in quello specifico momento, in quello specifico luogo, in quello specifico momento politico, con quella specifica voce e persino con quello specifico cappottino giallo, la poesia c’era, eccome.
Nei Måneskin i testi paiono essere interamente opera di Damiano, anche se ogni brano è firmato da tutti e quattro. Ecco, nelle interviste gli vengono sempre chieste le influenze musicali e mai quelle culturali (non oso dire letterarie), che a questo punto mi incuriosiscono non poco.
Il mondo dei testi dei Måneskin un mondo cupo, tipicamente adolescenziale e sarà il caso di ricordare che Damiano, Victoria, Thomas e Ethan sono davvero adolescenti, non stanno fingendo, non sono star di mezz’età costrette a ripetere i loro successi giovanili. E’ un mondo pericolosamente vicino all’Emo, benché si salvi grazie al vitalismo da palco di Damiano e al desiderio degli altri di far vedere quanto sono bravi. Piuttosto, è sorprendentemente atemporale: non ci sono riferimenti pop, non c’è vita quotidiana, non ci sono né televisione né Internet né altre tecnologie moderne, non c’è un contesto storico riconoscibile. Non ci sono le infinite griffe commerciali di lusso che riempiono le canzoni trap (less swag, more swagger). Per dire, non ci sono nemmeno le auto e perciò quando vengono nominate, in Zitti e buoni fanno un po’ strano, come pure nella stessa canzone il riferimento agli spacciatori che pare ancorarla, unica, a un presente riconoscibile. Altrimenti ci sono città notturne dalle porte sbarrate e una natura perfettamente indifferente. Siamo, per fare un esempio canonico, più sul coté Racine-Corneille che Shakespare, e già che ci siamo notiamo i numerosi riferimenti al teatro e al circo che fanno, se non proprio Barocco, almeno anni Settanta.
E’ in un certo senso un mondo fantasy, estremamente parco di dettagli di sfondo ma in cui è necessaria una postura eroica, tanto in difesa che in attacco: la violenza fisica è sempre dietro l’angolo – ‘colpisci forte, tanto non cado, rimango in piedi’, ‘ho perso sangue dal naso e mi sono rialzato’, la società è sempre e solo pressione sociale a conformarsi, la morale corrente è da ‘sottouomini’, gli altri sono o nemici o indifferenti e si può contare solo su ‘tre amici non codardi’ (Damiano usa spesso termini in qualche modo desueti, come ‘codardo’ e ‘impavido’) e cioè la band come bande à part in lotta contro il mondo, anche se ci si può alleare con tutti quanti vogliano mantenere la propria individualità. Insomma, mi sento piuttosto a mio agio in un immaginario che ricorda molto il buon vecchio heavy metal, un genere influenzato dal fantasy (e dall’horror) almeno quanto il prog. In fondo ero adolescente anch’io, allora.
L’ambizione è vasta e indefinita – ‘spiegare cos’è il colore a chi vede bianco e nero’ - ma certamente artistica – ‘di cos’è fare l’artista te ne hanno mai parlato?’ – e l’autoaffermazione si identifica con l’ambizione e la possibilità sempre presente di fallire – ‘lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine/coi morsi di mille serpenti fermo per le spire’.
Se c’è una cosa che Damiano è bravo a esprimere è l’aggressività e ancor più di Zitti e buoni la canzone giusta è Lividi sui gomiti (immagine curiosamente retro, che mi ricorda i tempi in cui noi bambini eravamo lasciati per pomeriggi interi a giocare in gruppo senza sorveglianza e tanto i gomiti che le ginocchia erano sempre lividi e sbucciate; si finisce sempre nella memoria) dove il setting è quasi riconoscibilmente scolastico, in quel microcosmo di cricche, clan e cordate in conflitto, quando non per niente la musica è importante e dove l’odio si può dispiegare liberamente contro di te sul tuo ‘gruppo con cui mangi, strisci, preghi, vomiti’ e il disprezzo più forte nella voce di Damiano cade sul banale ‘mangi’ e mai il mangiare è sembrato così spregevole (del resto, gli eroi di Racine non mangiano mai).
Poi c’è il tono malinconico, la sensazione di perdita nelle canzoni del Ballo della vita che hanno come protagonista Marlena, tanto donna quanto, ci dicono, musa ispiratrice, e uno si può chiedere da dove Damiano abbia tirato fuori un tropo così antico come la musa femminile che ispira il poeta/eroe uomo: sospetto a scuola, dove i ragazzi normali si annoiano con la poesia italiana e quelli più sensibili finiscono per ricordarsela anche non volendo. Torna a casa, il loro maggior successo prima di Zitti e buoni, è un dirge curiosamente elegante – ‘quindi Marlena torna a casa che ho paura di sparire’ – ma soprattutto la strofa che termina con ‘perché la vita, senza te, non può essere perfetta’ e questa frase, piatta sulla pagina, cantata in calando sono i secondi più belli della canzone italiana degli ultimi anni.
Un po’ di pratica con la poesia del Novecento ce l’ho e so della distinzione fra ‘poesia’ vera e propria, che non ha paura del quotidiano e del materiale, e ‘poetico’, che ha bisogno di parole e immagini ‘belle’ e bisogna ammettere che nei testi dei Måneskin c’è un mucchio di ‘poetico’, c’è molto poetico di repertorio. Ma sappiamo che nella cultura di massa i cliché usati nel modo giusto possono creare una poetica (come disse tanti anni fa Umberto Eco parlando di Casablanca: ‘quando tutti gli archetipi irrompono senza decenza, si raggiungono profondità omeriche. Due cliché fanno ridere, cento commuovono’), e comunque ci sono immagini che invece promettono qualcosa di più e suonano nuove, e che stiamo parlando di canzoni dove la parola non può essere staccata dalla performance, cioè dalla voce di Damiano, dagli assoli di chitarra di Thomas, dal giro di basso di Victoria e dal sostegno sicuro della batteria di Ethan e dove quindi questa lingua e queste immagini FUNZIONANO e invece di sentimentalismo abbiamo sentimento che è l’obbiettivo finale.
La canzone probabilmente più riuscita dei Måneskin è Coraline, un lento parecchio commovente, e è davvero singolare che non l’abbiano scelto per Sanremo e abbiano invece preferito un pezzo così poco festivaliero come Zitti e buoni: volevano vincere alle loro condizioni, mi sa. Comunque, Coraline è veramente un fantasy anche se la storia di una ragazza troppo sensibile che sta andando verso l’autodistruzione – probabilmente anoressia, se non suicidio – perché ‘ogni parola è un’ascia, un taglio sulla schiena’. ‘Non riesce neanche a uscire da una misera porta/ Ma un giorno, una volta lei ci riuscirà’. Alla spirale discendente di Coraline vorrebbe opporsi l’eroe, in un delirio di fragile vanagloria maschile, che sarà anche un soldato, e sarà ‘vessillo, scudo o la tua spada d’argento’. Ma inutilmente: ‘le han detto che in città c’è un castello/con mura talmente potenti/che se ci vai a vivere dentro/non potrà colpirti più niente’.
Aggiungiamo, per concludere, che in queste ore sta salendo le classifiche mondiali una canzone dei Måneskin in inglese ‘I wanna be your slave’ che è anche il loro primo tentativo riuscito di canzone leggera, benché sia un simpaticamente perverso elenco di gioco di ruolo sessuali con un partner. E’ anche la cosa più vicina a un tormentone estivo che abbiano scritto finora e potrebbe segnare una nuova direzione di sviluppo.
Insomma, ci siamo capiti. Rock’n’roll never dies.
8.
Concludiamo, che mi sono preso tutto il tempo che ci voleva e anche un po’ di più.
C’è una cosa molto specifica che io – un bibliotecario genovese sessantenne - ho in comune coi Måneskin, quattro adolescenti romani assurdamente attraenti: la sensazione che si prova quando si arriva secondi (o nel mio caso terzi) in un talent dietro vincitori che svaniscono nel nulla nel giro di pochi mesi e a te negli anni successivi viene ricordato che sei poco credibile, come scrittore o musicista, proprio perché hai partecipato a quel talent.
Nel 2013 Giancarlo De Cataldo e l’allora direttore di Rai3 Andrea Vianello ebbero l’idea per un nuovo talent, Masterpiece, una specie di Masterchef o X Factor per scrittori esordienti. Io, che da un paio d’anni cercavo di piazzare il mio primo romanzo, decisi che provare non mi costava nulla. Inviai il manoscritto e a sorpresa venni convocato per un provino in uno studio televisivo a Roma, sulla Nomentana, dove fui scelto per partecipare alla trasmissione.
Giudici del talent, oltre a De Cataldo, furono Andrea De Carlo e Taye Selasi; Massimo Coppola presentava. Se ne parlò molto, all’epoca: le reazioni del campo letterario italiano furono largamente negative, apparentemente nell’era del digitale la televisione era ancora vista come il nemico principale e si temeva che la vera letteratura sarebbe stata inglobata dal trash dei reality. Noi concorrenti fummo spesso descritti come ‘casi umani’. Già.
Non era il caso di preoccuparsi troppo: il programma fu un fiasco. Rendere spettacolare un’attività come lo scrivere, una cosa che si fa normalmente da soli, seduti e in silenzio, era molto difficile, forse impossibile, e comunque gli autori, che venivano dal Grande Fratello e programmi simili, non ci riuscirono. Non vi furono seconde edizioni. Il mio romanzo, terzo classificato, venne pubblicato da Bompiani ma morì rapidamente e in seguito, non quanto ai Måneskin ovviamente, mi capitò di sentirmi ricordare questo ridicolo peccato di vanità e lesa maestà letteraria.
L’analogia finisce lì: loro presero l’inaspettata sconfitta come motivazione a migliorarsi e continuare: io lì per lì fui quasi contento, vincere sarebbe stato persino imbarazzante. Poi, quando mi resi conto delle conseguenze, soffrii una modesta depressione. Continuai, ma in tono molto, molto minore e eccoci qua.
Masterpiece aveva una missione lodevole: raggiungere un pubblico nuovo per la letteratura italiana. I mezzi erano inadeguati ma non fu questo che venne rimproverato (pure con interrogazioni in Parlamento) alla trasmissione, quanto proprio il tentativo di abbattere o almeno allargare gli steccati in cui la nostra narrativa vive ma non prospera.
Steccati in alto – dove la presunzione di successo o anche solo divertimento è ancora un tabù se si vuole essere selezionati per il Premio Strega – e steccati in basso – i generi, giallo in testa, che più di tanto non possono dare, anche se almeno hanno lettori volenterosi. Una empasse che si riflette su un settore merceologico che, se pure inaspettatamente scampato al wipeout del 2020 dove invece ha modestamente prosperato, ha pur sempre un fatturato inferiore alla Nutella. Ai problemi strettamente letterari si uniscono criticità strettamente industriali, come quelle messe in luce dal recente sciopero alla Città dei Libri di Stradella, e che si ripercuotono sulla vita economica dei singoli scrittori.
Chiaro che c’è parecchia gente che cerca di trovare una via d’uscita, saltando sia le barricate della chiacchiera letteraria che quelle delle fedeltà rigorosa alle ‘regole’ dei generi, come ha raccontato Andrea Donaera su Minima & Moralia, riconoscendo che ‘Questo processo è uno dei tanti che danno la sensazione di vivere in tempi sul serio interessanti’. Un piccolo tentativo di Rinascimento, reso più urgente dallo stato d’eccezione in cui ci troviamo tutti a vivere dal marzo del 2020.
Sfortunatamente gli scrittori non hanno un loro X Factor…
I Måneskin non si sono fatti problemi di credibilità e se se li sono fatti hanno deciso che valevano il rischio e hanno partecipato a un talent, fortunatamente più vitale e popolare di Masterpiece. Protetti da quelle condizioni accessorie di cui parlava Alain – figaggine, incoscienza giovanile, un manager abile e notevole disciplina – hanno potuto portare avanti una loro storia che è culminata nell’espugnazione di due fortezze nemiche, Sanremo e l’Eurovision, che hanno tanti difetti ma anche un grosso pregio: hanno un pubblico.
E anche musicalmente, grazie al semplice espediente di non farsi prendere sul serio da quel che restava della comunità rock e della chiacchiera musicale, sono riusciti a forgiarsi un loro sound personale che però ha il pubblico come riferimento e non la comunità e la chiacchiera. Soprattutto, ambiziosi come chiaramente sono, hanno deciso di non puntare sul facile, su quello che va e che sicuramente potrebbero fare benissimo, e puntare invece su un genere invecchiato, privo di quel che era il suo tratto fondante, la vitalità, dandogli una nuova speranza di vita.
E’ possibile che l’industria, le radio, le televisioni, diano nuovamente un po’ più di spazio al rock, come è possibile, praticamente certo, che in centinaia di superiori italiane ci siano un gran numero di adolescenti, ragazzi e ragazze un po’ più belli della media, assurdamente idealisti e con un concetto di sé parecchio inflazionato i quali decideranno che proprio il vecchio rock è un sound degno di loro e della disciplina necessaria a praticarlo (in realtà sono tanti a farlo già, in questo stesso momento: la differenza è che oggi possono sperare in una maggiore attenzione). Così, persa da tempo l’egemonia, il rock può tornare competitivo in un panorama molto diversificato in cui può giocarsela alla pari con generi che paiono oggi più popolari (addio Sfera, è stato bello).
Per noi scrittori è più difficile: non abbiamo un talent e non possiamo puntare sul sex appeal (beh, IO non posso) e se Poe ha ragione per la popular music, dove la popolarità è segno di valore, Alberto Arbasino ha ragione per i libri: non è che McDonald è il ristorante migliore perché ci va più gente. Ma un ristorante in cui non va nessuno chiude e basta.
E ricordatevi, l’Eurovision nel 2022 la organizziamo noi italiani.