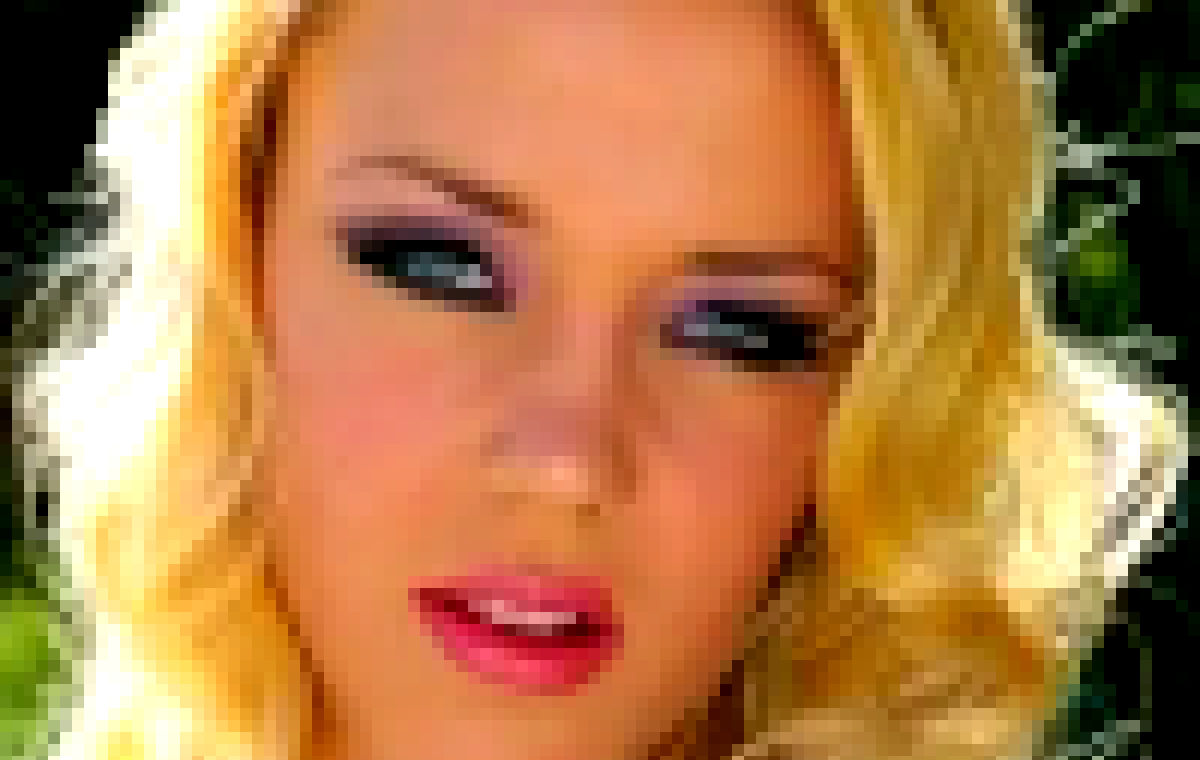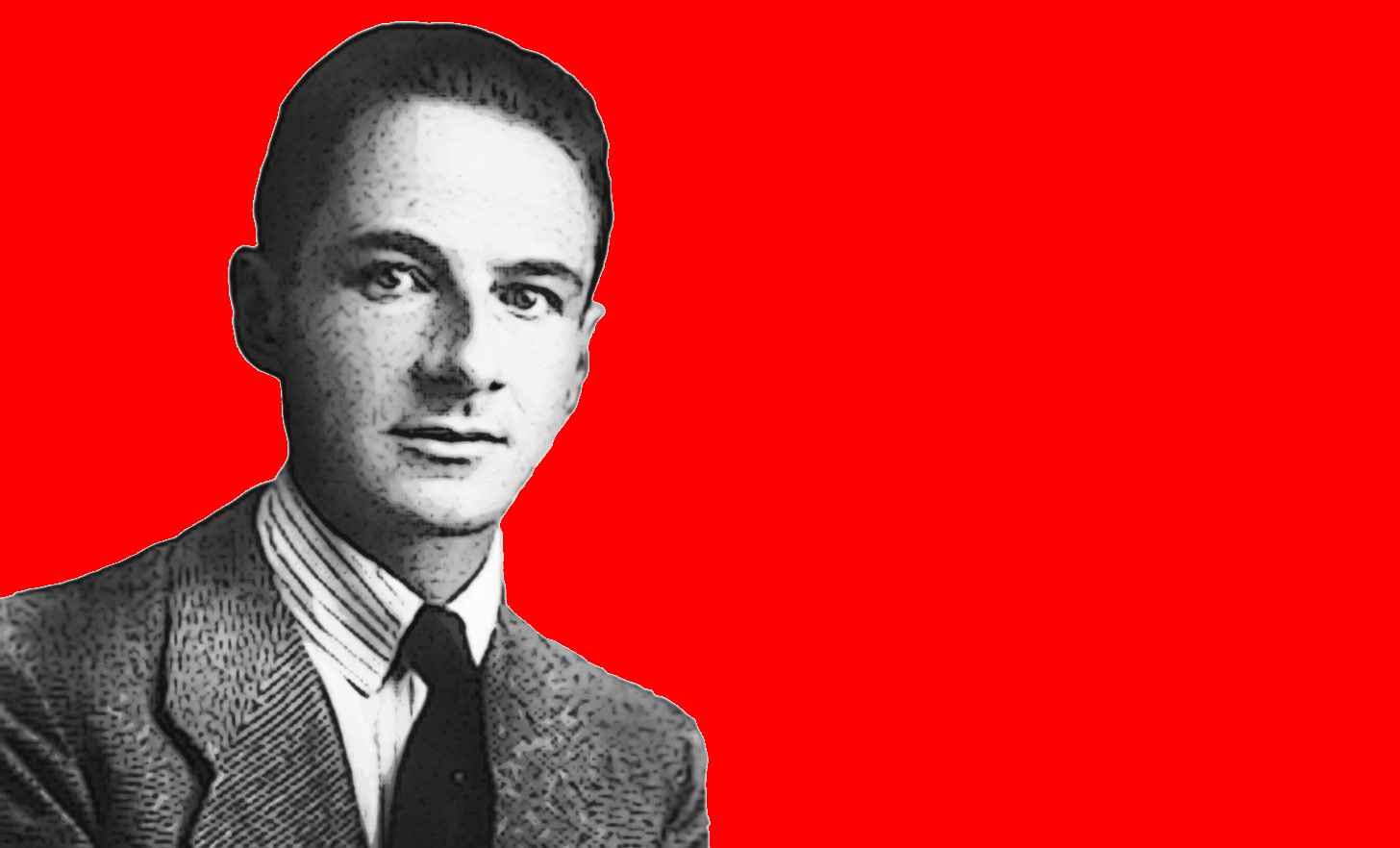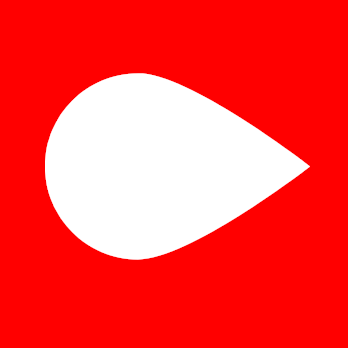Il Grande Romanzo di Internet
Analisi / recensione di due libri che parlano di Rete, passaggi d'epoca e distopie: "Odio", di Daniele Rielli e "Fuga dalla Rete" di Luca Pantarotto.
Vorrei parlarvi di due libri usciti di recente a tema Internet, il saggio Fuga dalla Rete. Letteratura americana e tecnodipendenza di Luca Pantarotto (Milieu, 2021) e il romanzo Odio di Daniele Rielli (Mondadori, 2020), ma prima permettetemi di citare due frammenti di archeologia letteraria italiana che apparentemente c’entrano poco o nulla.
Avevamo sperato per qualche tempo – pazza speranza, ma viviamo in un’epoca di sorprese e meraviglie – che la televisione in Italia non si avverasse mai, e restasse limitata agli esperimenti e a qualche costosa emissione come quelle che si hanno finora nel settentrione della penisola.
Così scriveva sulla Stampa nel 1954 Paolo Monelli, uno dei più noti giornalisti del tempo. La sua prospettiva è assolutamente apocalittica:
la televisione non ucciderà soltanto il cinematografo e il teatro, è sulla via di annullare quelli che sono stati finora i rapporti sociali e familiari, come già oggi la radio e il cinematografo hanno ucciso la conversazione.
Monelli paventava il giorno in cui la televisione sarebbe diventata l’unica fonte di tutto e sarebbe stata "manipolata, dosata, conciata secondo la scelta, l’estro e il capriccio, i preconcetti, le storture di poche persone". Insomma, la fine del mondo era vicina e questa immagine catastrofica e totalitaria della televisione, che il cordiale esperto di vini modenese condivideva con pensatori radicali come Gunther Anders, sarebbe rimasta – malgrado le sagge parole di pochi studiosi come Marshall McLuhan – dominante fino ai nostri giorni.
Nel 1978, invece, Alberto Arbasino, nel suo pamphlet sul caso Moro, In questo stato, invitava i letterati italiani a parlare di quel che stava accadendo nel paese, in particolare del terrorismo (e sì, fa un po’ strano che a farlo fosse proprio Arbasino e non per niente il testo coevo di riferimento sull’affaire Moro è rimasto quello di Sciascia malgrado a rileggerlo oggi quello del mondano vogherese appaia decisamente più interessante di quello del malmostoso siciliano). In fondo
parecchi dei romanzi più notevoli del nostro secolo, malgrado la poca simpatia per le smanie presenzialistiche dei loro autori, sono dovuti proprio a reporter “a caldo” come Hemingway in Spagna e Malraux in Cina; e risultano più importanti e interessanti delle opere di artisti che hanno parlato dei loro parenti e dei loro appartamenti
e non ce n'è nemmeno bisogno di andare chissà dove perché
basta mettere il naso fuori dal portone, ed ecco intatta l’Italia “nera” dei romanzi gotici inglesi; basta sfogliare il giornale, e impallidisce qualunque tragedia trucibalda di Stendhal; basta guardare la televisione e i più “hard boiled” romanzi americani di guerra e d’azione risultano al confronto delle giuggiole. Non c’è più neanche bisogno di viaggiare o spostarsi, o di accampare giustificazioni perché si è dovuti restare a casa: ti succede tutto qui, sulla porta di casa, più puntuale del postino delle raccomandate e degli espressi.
Ma niente, i romanzi sul terrorismo non vennero allora (a parte la coraggiosa Luce d’Eramo di Nucleo Zero e, a suo modo, Il Nome della Rosa di Umberto Eco’) e tutto sommato nemmeno in seguito.
(bene, teniamoli un attimo da parte che poi servono)

La mia prima connessione a Internet, con modem e linea telefonica fissa, risale al 2000: all’epoca in Italia sarà stato connesso a Internet meno del 2% della popolazione. Io mi sentivo come al solito in ritardo sulle novità del mondo ma in realtà se non proprio un pioniere fui di certo un early user.
Avevo le mie diffidenze: sono istintivamente conservatore e ho molte obiezioni, sia di pelle che più ragionate, al pensiero anarco-libertario che sembrava (già, sembrava) sottendere alla Rete; soprattutto mi faceva soffrire la profezia, diffusa allora fra tutti gli esperti (sedicenti, come avremmo scoperto in seguito) dell’imminente scomparsa del libro, cosa che toccava fin nel profondo della creatura libresca che sono.
Ma in complesso ero aperto alla novità, di cui capivo (vabbé, grosso modo) tutta l’immensa portata – mi era chiaro che non si trattava di una moda passeggera - e da cui mi aspettavo meraviglie. Non ero e non sono un nativo digitale, non sono a mio agio con la tecnologia, ma c’ero, facevo parte del nuovo che avanza, col mio nickname – Moritz Benedikt, un nome preso dagli Ultimi giorni dell’umanità di Karl Kraus, all’epoca era normale averne uno per interagire nei newsgroup della gerarchia Usenet, che intorno al 2000 era la spina dorsale di quello che ancora non ci si vergognava a chiamare cyberspazio – e ero pronto a tutto, come tutti. Le promesse che ci vennero fatte da quanti capivano come funzionava il digitale erano impressionanti.
Col senno di poi, potevamo fare a meno di farci impressionare: gli esperti erano tutti rigorosamente sedicenti. I cambiamenti ci furono, eccome, talmente radicali da costringerci a ripensare intere categorie mentali e la natura stessa dell’umano: ma non furono quelli promessi e sperati.
"Nonostante tutto quel che si sente dire sull’effetto liberatorio della rete dei dati, la verità è che per molti di noi costituisce una nuova causa di paranoia", come disse nel 1974 lo scrittore di fantascienza inglese John Brunner nel romanzo Codice 4GH (The Shockwave Riders), il primo vero e proprio romanzo sulla Rete allora nascente.
Il saggio di Luca Pantarotto affronta questo deludente mutamento epocale, la classica situazione in cui ottiene quel che credevi di volere e scopri che stai peggio di prima, da un punto di vista molto specifico, cioè la narrativa americana e di come questa narrativa, che in fondo è quella centrale della nostra epoca e che in teoria avrebbe dovuto essere all’avanguardia nel trattare il tema della Rete, in realtà sembri
aver reagito all’avvento della rete con poche idee ma confuse (…) Prevale il ricorso ad architetture narrative più che abusate, paradigmi interpretativi scolastici, modelli e chiavi di lettura fuori tempo massimo. Su tutte, l’idea novecentesca di un totalitarismo digitale deciso a piegare i nuovi strumenti a scenari di dominio degni di figure da fumetto come il Boss Artiglio dell’Ispettore Gadget.
In particolare Il Cerchio di Eggers e Purity di Franzen sono
due perfetti manuali di istruzioni sui modi migliori per gestire sul piano narrativo il rifiuto della realtà.
Quello stesso problema che Arbasino considerava particolarmente italiano si ripresentava negli Stati Uniti e senza nemmeno la scusa che se non stai attento quelli ti possono sparare.
Pantarotto è social media manager di NN Edizioni (quelli di Kent Haruf, per intenderci) e non quindi certo un luddista. Nel 2018 pubblicò per Aguaplano Holden & company, una raccolta di scritti sulla letteratura americana apparsi sul suo blog omonimo, quindi può parlare da competente del tema che si è scelto e lo fa in maniera perfettamente chiara e economica, tanto da poter essere un modello di come dovrebbe essere la critica, almeno quella di contenuto più che di stile come in questo caso: identificare il problema, leggere quel che c’è da leggere e esporlo nel linguaggio più chiaro possibile. Dovrebbe essere semplicissimo, ma spesso ci si fa distrarre da tecnicismi critici e da sfoggi di oscuri riferimenti letterari che appesantiscono il discorso (come faccio io, per dire).
Uno dei device intorno ai quali Pantarotto organizza il libro sono tre famose copertine di Time Magazine, un tempo una delle istituzioni centrali della mediasfera mondiale, in particolare la tradizionale nomina del Man o in seguito Person of the Year. Nel 1982 Time, a sorpresa, nominò il Personal Computer Machine of the Year, con una scultura di George Segal, dall’aria un po’ malinconica. Gli articoli che accompagnavano la scelta erano un misto di speranze e allarmi, come naturale in un tema ancora molto specialistico. Quando Time ritorna sul tema, nel 2006, lo fa col botto: l’Uomo dell’Anno sei TU! "Sì, tu. Tu controlli l’Era dell’Informazione. Benvenuto nel tuo mondo". Sulla copertina un computer il cui schermo è realizzato con uno speciale materiale riflettente che funziona come uno specchio. Il tono degli articoli è largamente entusiastico e le fantasie libertarie degli anni Ottanta e Novanta paiono diventate la filosofia ufficiale del tempo.

Ma a questo punto il cambiamento corre veloce: nel 2010 le fantasie cyberpunk hanno già lasciato il posto alla realtà di una rete dominata come non si credeva possibile da poche potentissime aziende e infatti in copertina campeggia la faccia leggermente inquietante di Mark Zuckerberg e il tono è molto più problematico. Ora anche la Rete, che qualche visionario aveva voluto proclamare indipendente da ogni potere pubblico, aveva un governo, in un certo senso, e certamente era diventata un potere (del resto era ovvio che, come una società umana che raggiunge una certa massa critica di popolazione crea da sé un potere centrale per governarsi, anche dalla Rete a un certo punto della sua crescita sono nati dei poteri che ne permettessero l’organizzazione, e questi poteri sono Google, Facebook, Twitter, Amazon etc – preciso che questa è un’opinione mia e non di Pantarotto).

E la narrativa? La fantascienza, persa dietro navi spaziali, distopie televisive e bombe atomiche, fu tarda a recepire la novità della Rete, che nasce negli Usa negli anni Sessanta e il romanzo di Brunner rimane isolato fino a Neuromancer di William Gibson (1983) da cui nasce il Cyberpunk e si fissa la mitologia del Cyberspazio con l’eroico hacker solitario. Il romanzo di Gibson è affascinante e pochissimo invecchiato: ha ben poco a che fare con la Rete nella sua quotidianità ma molto con la sua possibile essenza. Snow Crash di Neal Stephenson è anch’esso un ottimo romanzo e per un momento parve profetico in quanto predisse Second Life, che per un attimo parve il futuro della Rete e poi passò di moda.
Peggio ancora per i romanzieri importanti o quantomeno mainstream, secondo la ricostruzione di Pantarotto: Thomas Pynchon in Bleeding Edge fa Pynchon e non ci dice granché di nuovo; Stephen King con Cell scrive uno dei suoi romanzi peggiori; Jonathan Franzen, che passa per spietato critico della rivoluzione digitale e dei suoi slogan, in Purity perde l’occasione per approfondire il discorso perché in realtà non prende veramente sul serio la Rete; Dave Eggers, poi, ne Il Cerchio, ricorre ai più vieti cliché della letteratura distopica, che però non erano ancora cliché quando apparvero, con forza ineguagliabile, nel 1984 di George Orwell (di cui quest’anno, con la scadenza dei diritti, sono apparse varie nuove traduzioni fra cui quella di Tommaso Pincio per Sellerio). A quasi ognuno di questi titoli viene dedicato un capitolo intero di analisi precisa e dettagliata e i giudizi sommari qui riportati sono, appunto, miei riassunti.
Uno dei punti più interessanti di Fuga dalla Rete è proprio la discussione sul capolavoro di Orwell, legato ai totalitarismi del primo Novecento (paragonato sfavorevolmente alla distopia edonistica del Brave New World di Aldous Huxley) e di come non fornisca una base adeguata alle previsioni o fantasie distopiche sulla Rete in quanto
sono proprio le masse, oggi, a scivolare volontariamente e quasi inconsapevolmente in uno stato di dipendenza e soggezione, legandosi in modo indissolubile ai meccanismi algoritmici che governano il funzionamento delle piattaforme e, da lì, alla filosofia e alla visione del mondo delle compagnie che le possiedono.
Oppure il fatto che la distopia digitale sarebbe la prima in cui alla gente vengono date più libertà di prima invece di meno.
Come sostiene Daniele Rielli nel suo romanzo Odio, di cui parleremo in seguito, i pionieri della Rete avevano una concezione radicale della democrazia per cui
il volere della maggioranza tende per definizione al bene. Il corollario principale era che l’unico ostacolo alla realizzazione del paradiso in terra fosse la mancata circolazione delle informazioni. Ogni errore, ogni ingiustizia, ogni conflitto avvenivano secondo loro a causa di una situazione di scarsità informativa (…) Un’idea del genere, per quanto sia una completa idiozia, si sposa alla perfezione con la cultura occidentale da sussidiario, che in genere è tutto quello che i tecnici delle infrastrutture digitali – come il resto della popolazione – possiedono in termini di conoscenza non specialistica del mondo che li circonda.
Come sempre, tutto dipende da scelte filosofiche inconsapevoli o proprio mal pensate – la mia versione un po’ trash dello storicismo crociano.
Ricordate cosa disse il buon Monelli sulla televisione, il mass media più calunniato della storia umana (al suo confronto la stampa a caratteri mobili, i quotidiani, il telegrafo, il telefono, la radio, il cinema etc furono praticamente festeggiati dai contemporanei con poche eccezioni cui si da troppo peso)? Apparsa nelle case poco dopo la Seconda Guerra Mondiale vi fu un sincero allarme sulle sue possibilità demagogiche: cose avrebbe potuto fare un Hitler se vi fosse stata una televisione in ogni casa? Nulla, avrebbe detto in seguito Marshall McLuhan, non sarebbe proprio esistito, ma i pregiudizi non morirono. I cinquant’anni circa (1950-2000) in cui la televisione fu al centro del media landscape furono in Occidente anni generalmente moderati, in cui le elezioni si giocavano al centro dello schieramento politico e in cui i vari leader politici non avevano assolutamente nulla in comune con Hitler, Mussolini o Stalin (davvero, cosa si poteva immaginare di più antropologicamente diverso dal Duce dei leader democristiani della nostra prima era televisiva? Ma nemmeno Berlusconi, che pure le televisioni le possedeva).
Per esempio, nella mitologia (o demonologia) digitale l’informazione ‘tradizionale’ è descritta e vissuta come un blocco unico, sostanzialmente totalitario e orwelliano, che disinforma e sostiene il ‘regime’ ingannando il popolo per convincerlo che è felice e che i suoi capi sono degni di fiducia – ma davvero, siamo a livelli da cartone animato scrauso. Semplicemente, non è quel che succede (per esempio in un paese dopo il principale giornale moderato, il Corriere della Sera, ha inventato il termine ‘casta’ per definire la classe politica). Il sistema dell’informazione occidentali ha tanti problemi risolvibili – bias più o meno nascosti da parte di giornalisti e editori, dipendenza dalla pubblicità o dai partiti etc – e irrisolvibili – l’agenda setting, per esempio, è una necessità strutturale dell’informazione che è indubbiamente fonte di abusi ma senza la quale l’informazione sarebbe semplicemente impossibile – ma non assomiglia nemmeno da lontano all’informazione sovietica o fascista.
La possibilità concessa dalla Rete a ciascuno di noi di poter dire direttamente la nostra su tutto e tutti, un diritto democratico protetto da qualsiasi costituzione democratica, ha avuto conseguenze impreviste e la soluzione si è rivelata per certi aspetti peggiore del problema. Milioni di persone che usano i social come la propria tivù privata con cui trasmettersi al mondo e regalare i propri dati personali ai gestori dei social e alcuni di loro finiscono addirittura per diventare ricchi. Milioni di critici dei media che decostruiscono le news per sostituirle con le proprie fantasie o peggio, con le fantasie approntate da chi ha i dati a disposizione per cucirle addosso a chiunque; milioni di parrhesisti (si dice così?) che ‘dicono la verità al potere’ senza correre il minimo rischio e senza rendersi conto che, come ci ricorda Jarret Kobek in Io odio Internet:
le opinioni non erano altro che parole, non erano altro che cazzate che qualcuno da qualche parte inventava, e non facevano altro che oliare i meccanismi del capitalismo (…) L’unico effetto delle parole di persone senza potere su Internet era infliggere infelicità ad altre persone senza potere.
E vogliamo parlare della devastazione intellettuale che ha provocato la parola inglese ‘free’ che vuol dire sia ‘libero’ che ‘gratis’ e fra le altre cose ha distrutto l’industria discografica? Vi ricordate quando ci dicevano che senza l’intermediazione delle major la musica ‘commerciale’ sarebbe scomparsa e avremmo avuto un autentico Rinascimento musicale? Già, anch’io.

Ok, usciamo dalla modalità rant, che se no poi mi metto sul serio a parlare di politica e magari pure dei Cinque Stelle e non ne ho proprio voglia che poi so che straparlo, e torniamo a Pantarotto per segnalare un altro, fra i tanti, dei punti forti dell’analisi di Fuga dalla Rete. Dicevo prima che quando nel 2000 entrai nel magico mondo della Rete usai un nickname, come usava allora sui proto-social network che erano i newsgroup. All’epoca l’anonimato era considerato una delle principali attrattive della vita online: ‘On the Internet, nobody knows you are a dog’, nel 1993 una nota vignetta del New Yorker. Pensatori autorevoli vantavano l’utilità dell’anonimato online per la lotta a favore della libertà nei regimi autoritari (probabilmente gli stessi che nel 2010 credettero davvero che le rivoluzioni islamiche fossero avvenute grazie a Twitter e Facebook). Ma col Web 2.0 le cose cambiarono e fu presto chiaro che la maggior parte della gente non voleva spiare in segreto ma risplendere in tutta la sua fulgida individualità e essere la star del proprio personale reality show, anche a costo di rivelare di sé molto più di quanto avrebbe voluto, tanto che nel 2015 l’iconica vignetta del Newyorker venne upgradata a ‘Remember when, on the Internet, nobody knew who you were?’.
L’identità personale diventava una delle principali monete di scambio dell’economia digitale e Pantarotto identifica due romanzi fra gli altri che affrontano il tema, due romanzi in cui, inesplicabilmente, a un certo punto la Rete scompare. Nel mediocre romanzo comico Internet Apocalypse di Wayne Gladstone la scomparsa dell’identità digitale ci permette di recuperare il vero anonimato di cui godevamo in passato, quello, come dire, fisico: senza la quantità di dati che i social mettono a disposizione di chiunque possiamo davvero fingere di essere qualcun altro. Nel ben più raffinato e riuscito Silence di Don Delillo invece la scomparsa dell’identità digitale a cui abbiamo confidato troppe cose finisce per disintegrare l’identità personale di ‘fuori’, ormai dipendente dal suo supporto tecnologico. Non vedo l’ora di scoprire chi dei due ha ragione.
Tornando finalmente alla letteratura Pantarotto segnala come finalmente, dopo la serie di fallimenti citati, la narrativa americana abbia forse trovato finalmente il modo giusto per parlare di Internet. A parte Delillo, che fa ovviamente classe a sé, si tratta di scrittori giovani, come Mark Doten, Ma Ling e il già citato Jarret Kobek, che è disposto a tematizzare più degli altri. Kobek ce l’ha con i ‘bei romanzi’ e vanta il fatto di aver scritto, con Io odio Internet, un ‘brutto romanzo’. I bei romanzi della tradizione mainstream, rispettosi della tradizione o dell’Iowa Writers’ Workshop, quelli che celebrano ‘le gioie dell’esistenza borghese resa possibile dal dinamismo americano’ e parlano di sesso, tradimenti e mutui casa, sono parte del problema: la soluzione è ‘scrivere romanzi brutti che imitavano la rete informatica nella sua ossessione per i media spazzatura’ (che è quello che, secondo Pantarotto, aveva in fondo fatto David Foster Wallace in Infinite Jest, pur non parlando direttamente della Rete ma mimandone la struttura digressiva)
Il romanzo di Kobek è una feroce invettiva appoggiata a una trama esilissima, sovverchiata dalle incessanti digressioni su praticamente tutto il mondo moderno dipendente dalla Rete, facendo anche i nomi dei responsabili, tanto che nell’edizione inglese vi sono frasi relative a personaggi come Peter Thiel cancellate da righe nere (all’anima della Cancel Culture…). Una lunga e divertente tirata, a volte pure ingiusta, che a parte gli esili personaggi fittizi ha un protagonista segreto, Jack Kirby, l’inventore di gran parte dei supereroi Marvel che dominano la cultura pop e che ricavò ben poco dalle sue invenzioni che resero ricchissimi i suoi datori di lavoro: il destino di tutti noi content provider a gratis, secondo Kobek.
Comunque, la soluzione per rendere narrativa la Rete potrebbe essere questa, imitarne la struttura digressiva e ridondante, abbandonando le strutture consolidate del romanzo classico, sia ‘letterario’ che di ‘genere’ (giusto per smentire l’idea che la narrativa di genere possa navigare più facilmente i cambiamenti tecnologici, ricordiamo che nei forum per scrittori americani d’inizio secolo vi furono discussioni accese su come Rete e telefonini rendessero inservibili vecchi e collaudati plot point – tipo come fosse diventato troppo facile chiedere aiuto e troppo difficile scomparire e sostanzialmente impossibile perdersi…).
Pantarotto identifica e descrive un problema critico e suggerisce pure una soluzione ma non una spiegazione, limitandosi a notare proprio all’incipit che ‘la verità è che non eravamo pronti. E’ successo tutto troppo in fretta e non abbiamo avuto il tempo di adattarci’, cosa che vale per gli scrittori come per chiunque altro (e per quei tycoon dell’industria digitale che, per qualche misterioso motivo, limitano l’accesso a Internet ai loro figli). Qualche ipotesi ulteriore si può fare, già che siamo qui fra noi e si può parlare in libertà. L’idea di Kobek di una letteratura ‘seria’ che punta ai ‘bei romanzi’ e perciò non è letteralmente in grado di rendere la caotica sgradevolezza della Rete è un buon punto di partenza: il noto principio dello ‘show don’t tell’, il riassunto elementare di discorsi un tempo molto raffinati, diventa veramente difficile da applicare a una postura, una vera e propria postura fisica, curva e ferma, in cui non si fa altro che scrivere e pure scrivere a un livello spesso basso e degradato, e in cui anche l’espressione dei sentimenti segue strade in qualche modo differenti.
Questo vale ancora di più per la letteratura di genere, così strettamente legata al cinema e alla televisione, e che deve quindi puntare sui corpi in movimento e a gente che faccia qualcosa di più che limitarsi a commentare post su Facebook. Internet poteva essere mitizzato nelle ‘allucinazioni consensuali’ di Gibson quando era poco diffuso ma non quando diventa il centro di una vita spietatamente quotidiana, qualcosa su cui controllare gli orari di Trenitalia, ordinare pizze o masturbarsi; quotidiana e, negli USA, suburbana, cioè qualcosa che quella narrativa ha sempre considerato il male al confronto della città e della campagna (fra l’altro la grande icona della modernità nel XX secolo, l’automobile, era favolosamente cinematografica ma anche narrativa: era qualcosa che si muoveva e su cui la luce si poteva riflettere in modo interessante).
Morte le fantasie libertarie che ne avevano accompagnato l’ascesa da quando Wikileaks divenne una casella postale del FSB e gli hacker dei semplici ricattarori; improponibile ormai l’opposizione Reale vs Virtuale, che ormai fa tanto retroguardia boomer, quando tanta parte del Reale si è trasferita nel Virtuale; verificato che la grigia immaginazione è finalmente al potere e la multicolore realtà può essere vista solo attraverso la lente della nostalgia; in rapida diminuzione il digital divide fra vecchi e giovani, ricchi e poveri, integrati e emarginati (i famosi smartphone in mano ai mendicanti fuori dai supermercati che tanto indignano la gente) – insomma, pare davvero che l’unica alternativa al fare finta di niente sia mimare la Rete con tutte le sue brutture e quindi scrivere romanzi frammentari e ‘brutti’.

Oppure si può provare un’altra strada che personalmente trovo interessante, una ‘via italiana’ al Grande Romanzo di Internet. Ci aveva provato nel 2018 Ernesto Aloia con La vita riflessa (Bompiani), raccontando in uno stile classico e elegante la nascita di un nuovo e innovativo social network. La tecnologia pare credibile, come pure le dinamiche dell’industria digitale e le reazioni della società; al racconto tecnologico si intreccia bene la vicenda dell’eroe, un italiano (gran parte del romanzo si svolge a Torino) che fa parte del team che crea il nuovo social, e della sua famiglia, in modo che l’ambientazione tecnologica non sia una scusa per parlare delle solite dinamiche familiari e la famiglia non appaia come una scusa per umanizzare il protagonista e non farlo sembrare troppo nerd. Aloia, secondo me, parte da una premessa fondamentale: sì, sta cambiando tutto e anche noi stiamo cambiando (in fondo di questo si parla nel romanzo) ma per il momento, parafrasando Montaigne, siamo ancora tutti seduti sui nostri culi.
E la stessa premessa, con stile e ambizioni diverse, è quella da cui parte Daniele Rielli per il suo Odio. Rielli divenne famoso come blogger con il monicker Quit the doner; in seguito, scrisse per vari media e i suoi reportage furono pubblicati nel 2016 da Adelphi in Storie del mondo nuovo mentre il suo primo romanzo – Lascia stare la gallina - era uscito per Bompiani nel 2015.
Odio aspira chiaramente a essere un romanzo-mondo o almeno una descrizione dettagliata del nostro tempo, soprattutto per quanto riguarda ciò che ha a che fare con la rivoluzione digitale e le sue conseguenze più estreme. È anche – e secondo me soprattutto – un atto d’accusa all’Italia, un amicus brief per la Corte Suprema della Storia.
Il protagonista narratore è Marco De Sanctis, miliardario del settore digitale. De Sanctis era uno dei personaggi del precedente romanzo di Rielli, Lascia stare la gallina (misteriosamente introvabile), ma non il protagonista: un simpatico giovanotto in vacanza nel Salento che si ritrovava incarcerato per omicidio e prima che altri riescano a dimostrarne l’innocenza veniva sottoposto alla gogna mediatica tipica del giustizialismo italiano (e come è triste regola del nostro paese nessuna innocenza è mai sufficiente per il nostro sistema d’informazione e per la nostra magistratura). Va a vivere a Berlino, diventa DJ, torna a casa, a Bologna, fa l’organizzatore di eventi, poi ha successo con un blog di commenti tecnologici, viene notato dal Mastro, un venture capitalist italiano che se lo porta a Roma a scrivergli gli articoli e lo fa entrare nel giro politico romano (siamo ai tempi del governo Renzi) – insomma, ha parecchie esperienze interessanti che permettono a Rielli di mostrarci un bel po’ di ambienti diversi, sfruttando immagino sia la sua biografia che il suo giornalismo -, finché con l’aiuto di un amico genio dell’informatica capisce il segreto del nostro tempo – l’immensa quantità di dati messa a disposizione dalla Rete - e riesce a mettere su un servizio di consegne a domicilio che anticipa i desideri dei consumatori – ‘Hai pensato pizza?’

Da lì De Sanctis passa di successo in successo e di avventura in avventura, crea un’impresa di livello internazionale e il romanzo prende certi caratteri del techno o financial thriller. A ogni passo l’eroe deve combattere contro la corruzione, l’arretratezza e l’ignoranza di questo paese, in particolare contro la sua incapacità di modernizzarsi (non spaventatevi, ma Odio è per certi aspetti un romanzo renziano, benché il Senatore di Scandicci vi sia visto con ironia: resta che praticamente tutto il male sta a ‘sinistra’, il che è anche legittimo – la descrizione di certe piaghe intellettuali della nostra gauche è tristemente precisa – ma pare poco realistico negare la corruzione intellettuale e la presenza digitale tossica comune anche alla ‘destra’). La classe politica e intellettuale, secondo Rielli (e come dargli torto?) è profondamente ignorante di quanto sta realmente accadendo:
Le abilità pressapochiste di un’intera categoria di persone erano invece basate su un misto di lontane reminiscenze universitarie, intuizione e consolidate usanze di gruppo. Le mode del momento, insomma. Tutte cose che spiegavano il mondo con molta meno precisione dei dati, ma i diretti interessati tardavano a rendersene conto. Non che fosse un grosso problema visto che il pianeta diventava ogni minuto più complicato, popolato e povero di risorse mentre enormi moltitudini di uomini uscivano dalle risaie e chiedevano il loro posto al sole. Insomma, eravamo fottuti.
Ci sono manovre e complotti dentro e fuori l’Italia, De Sanctis finisce per mettersi contro il Mastro (e in questo c’entra una donna, Federica, un bel personaggio femminile, contesa fra i due ma perfettamente in grado di badare a se stessa) e finisce per perdere il controllo dell’azienda. Ritiratosi in campagna, nel paese d’origine della sua famiglia, mette giù un piano, ispirato dalla filosofia di René Girard, per riformare radicalmente l’Italia, in parte seria analisi e in parte Modesta Proposta alla Swift. Il Mastro se ne appropria e lo mette in atto: l’Italia diventa una distopia con la facilità e rapidità di un sogno e il romanzo termina con un’esecuzione pubblica sull’Altare della Patria in diretta Netflix.
Rielli riesce a descrivere il nostro tempo come vorrebbe? Beh, no (ma chi può riuscirci?). In breve, commette un errore piuttosto grosso che compromette tutto il progetto.
Ma prima segnaliamo quel che funziona. Funziona a livello informativo, tanto per cominciare. Personalmente non sono un purista del romanzo, che è un genere estremamente ibrido: la funzione di documento è tutt’altro che secondaria e Rielli la sa svolgere molto bene, con un notevole talento giornalistico. Giornalistico è anche lo stile complessivo – che per me è un po’ meno positivo ma pazienza – e si può dire che c’è del pensiero a sostenere il tutto.
Fatto interessante, se al Panopticon di Bentham aggiungi solo un po’ di reciprocità ti ritrovi con un modello abbastanza fedele di internet. Fatto ancora più interessante, questo meccanismo di sorveglianza è stato considerato a lungo da critici e filosofi una sorta di feroce e lontana distopia, mentre oggi è il mondo in cui viviamo senza spendere neppure un secondo a pensarci (…) “Che fastidio quel quadratino della privacy che viene fuori quando apri un sito!
– praticamente la stessa cosa che dice Pantarotto.
In particolare, la filosofia di Renè Girard, che sia io che Rielli consideriamo uno dei pensatori più importanti del nostro tempo, e con noi il già citato Peter Thiel, uno dei miliardari digitali più intellettualmente agguerriti. Concetti come la natura mimetica del desiderio e l’organizzazione della società intorno al capro espiatorio sono sempre validi, perché se è vero che la rivoluzione digitale ha mutato il campo di gioco e parte delle regole, la partita resta la stessa di sempre (peccato che Rielli non prenda da Girard quel che ci ho preso io, cioè il cristianesimo). La gestione della trama non è solidissima, ci sono momenti in cui Rielli ricorre a espedienti da film muto (l’episodio dello smartphone riparato è semplicemente imbarazzante) ma, di nuovo, nel complesso funziona, cioè vogliamo vedere come va a finire.
Il vero, grosso problema è il protagonista. Marco De Sanctis è odioso. Non fa ‘virtue signalling’, cosa che Rielli disprezza molto, ma ‘intelligence signalling’, che invece è una mia piccola bestia nera: non può trattenersi un attimo dallo spiegarci le cose, tutte, sempre, e ovviamente ha sempre ragione (a parte, bisogna dire, nei confronti del Mastro, che è un villain notevole di cui De Sanctis riconosce la superiorità e vede con notevole ambivalenza). Dopo un po’ non se ne può più. E poi naturalmente scopa che è un piacere. In più ha due amici altrettanto intelligenti e simpatici – Mauro, uno scrittore, e Emanuele, un antropologo – che in pratica sono suoi alter ego che ne triplicano l’intelligenza. E, comme par hasard, tutte le donne, a parte Federica, sono semplicemente pessime. Ha sofferto, certo, ma in un romanzo precedente che non abbiamo letto: sì, Rielli si preoccupa di farci sapere il necessario ma non è la stessa cosa. Non è nemmeno il fatto che De Sanctis diventi ricco e scopra che essere ricchi è bello e non si periti di farcelo sapere: quello ci sta, direi pure che era l’ora che qualcuno lo facesse. E’ che proprio verrebbe voglia di prenderlo a mazzate (come fa l’amico Mauro nei confronti di un blogger di sinistra particolarmente spregevole).
Dico questo perché se il protagonista fosse stato gestito un po’ meglio Odio sarebbe stato un romanzo molto migliore. Tempo fa, leggendo M. di Antonio Scurati, il suo romanzo su Mussolini, pensai che finalmente l’Italia aveva il suo romanzo alla Balzac, un romanzo su un personaggio ambizioso che vuole il potere, è disposto a pagarne il prezzo e lo ottiene (oppure no ma almeno ci prova) ma senza disprezzarlo in partenza per la sua ambizione. Ovviamente, trattandosi di un’icona pesante e sovradeterminata come quella del Duce il romanzo di Scurati non poteva permettersi troppe libertà immaginative. Rielli fa di Marco De Sanctis proprio un eroe non solo di Balzac ma anche e forse soprattutto di Dumas, cioè del Conte di Montecristo.
Scriveva Gramsci in carcere in Letteratura e vita nazionale: "Mi pare si possa affermare che molta sedicente 'superumanità' nicciana ha solo come origine e modello dottrinale non Zarathustra, ma il Conte di Montecristo di A. Dumas". Su questa intuizione Umberto Eco scrisse i saggi sugli eroi della narrativa popolare raccolti nel 1976 ne Il superuomo di massa. Come il Conte di Montecristo Marco De Sanctis è stato accusato ingiustamente e poi diventa abbastanza ricco e potente da potersi vendicare del colpevole, in questo caso l’Italia intera. Ecco, se Rielli non si fosse lasciato distrarre dalla necessità di spiegarci in continuazione come stanno veramente le cose o farci vedere i posti fighissimi in cui è stato, e si fosse concentrato su questa trama base del feuilleton ottocentesco Odio sarebbe stato sì un po’ più trash ma probabilmente anche più riuscito. Invece ci dobbiamo accontentare di una spesso interessante introduzione al mondo moderno.
Ma nei suoi limiti il romanzo di Rielli (come quello di Aloia) presenta una valida alternativa, per descrivere l’effetto della rivoluzione digitale sulle nostre vite, al modello mimetico di Kobek, cioè la possibilità che il romanzo tradizionale possa raccontare Internet, purché sia tecnicamente informato e si liberi da modelli distopici, come 1984, inadeguati al bisogno perché Facebook non è il Reich né Instagram l’Unione Sovietica e abbiamo bisogno di nuovi modelli.